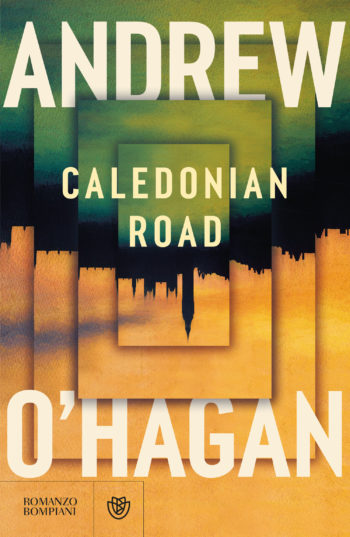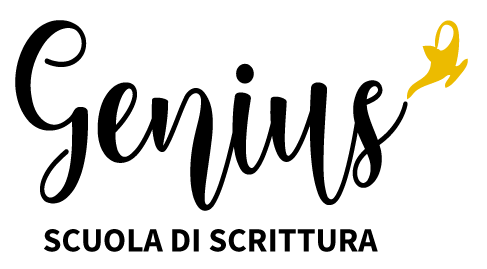Ventinovesimo capitolo – Foglio bianco
Ucraina ’23
Seduto sui gradini della piazza più povera di Mykolaiv, mi giro la penna tra le dita. La punto sul foglio. Poi la alzo. Guardo il cielo mentre due elicotteri passano tra le nuvole, tanto in alto che non posso sentirne il rumore.
Chissà se li butteranno giù i russi, se alla fine i piloti moriranno schiantati a terra. Magari hanno l’età mia.
Mi giro la penna tra le mani.
La guerra ti fa dimenticare quello che vuoi davvero, ti distrae. Sarà che questo cielo è sempre più scuro, ma inizio a pensare di dover far saltare in aria una parte di me per far sopravvivere il resto. In nome di questo si va in guerra, per salvare la pace.
Buffo.
Mi arriva qualche nota di musica ucraina, giro ancora la penna tra le mani ma non riesco a scrivere niente a Domitilla.
– Non balli manco te?
Alzo la testa, è Efrem, che durante il viaggio dall’Italia era nel van e non nel camper con me, per questo non ho avuto modo di parlarci molto.
– No no, se tu non balli mi accodo volentieri.
– Madonna che faccia che c’hai.
– Veh?! Me la sento gonfia e pesante.
– Sei stanco?
– No.
– C’ho li penzieri. – Rido.
– Ahhh – ride pure lui – Tipo liceale in gita scolastica?
Ridiamo insieme.
– Dai, facciamo un giro, abbiamo finito di scaricare. Ci sono delle danze, qualche canzone e poi si riparte.
La piazza è gremita di persone, il sole nascosto dalle nuvole è eclissato ormai dietro le grandi nuvole e il grigio dei palazzi inizia a scurirsi fino a fondersi con il fango a terra. Gli elicotteri sono spariti.
Giro la penna per l’ennesima volta tra le dita e la infilo in tasca. Chiudo il taccuino.
Efrem, davanti a me, mi fa cenno con la mano di muovermi. Vorrei parlare un po’ con lui per conoscerlo meglio. Mi piace pure lui a pelle ed è raro, mi piacerebbe dirgli quanta stima provo per il suo lavoro di operatore, per quello che fa silenziosamente per gli altri.
– Efrem, dici che dobbiamo ballare pure noi sennò s’offendono?
– No, zì, io non ballo sicuro, non so te. – Si aggiusta i capelli lunghi e scuri – Ma se tu vuoi vai eh, era solo per avvertirti che ci si muove tra poco. Che vuoi, restare qui?
– Uhm, no, direi. Però non ballo.
– No no, manco io.
Lo seguo tra la folla. La piazza non ha più spazio, siamo un mucchio di carne che non ha colori o provenienza, solo persone che esistono e l’unica cosa diversa è nelle intenzioni per cui siamo lì.
Mi guardo intorno, cerco di non incrociare sguardi, in particolare quelli italiani, per non dover sottostare all’invito a ballare. È chiara la mia incapacità di calarmi nella collettività, odio quelli che mi vendono il riuscirci come grande capacità empatica: ti lasci trasportare dalle emozioni e dalla musica e uno sconosciuto può diventare un fratello. Ecco, io mi immagino come una nave al Polo Nord ferma, bloccata dai ghiacci, in silenzio.
Forse, se invece che qui fossi proprio sulla linea rossa del fronte, lagnerei meno la solitudine, immaginerei meno barche e guarderei in faccia cosa rischio di perdere.
Mentre valuto il costo emotivo di un proiettile in testa a un nemico se fossi al fronte, mi arriva una spallata all’altezza del braccio. Una signora robusta si scusa, quasi piegandosi in due, e mi ringrazia in italiano, pur essendo ucraina, mostrandomi dei pannolini. Io le sorrido.
Da quanto ho capito, questo quartiere è stato bombardato diversi mesi fa e arrivano pochi aiuti. I palazzi intorno sono colabrodo in effetti e le persone, già povere anche senza guerra, ora non hanno più nulla se non le case e la paura che i propri uomini siano morti.
Mi guardo intorno, gruppetti di persone si radunano intorno al capo della grande carovana con cui siamo arrivati dall’Italia. Un uomo basso, piccolo, con gli occhi vigili che parla della missione e degli aiuti portati qui e quantifica, stringendo il pugno al cielo come se soppesasse della sabbia, il coraggio di chi si è imbarcato fin qui insieme a lui.
Poi si porta le mani al petto e ringrazia sia le donne e i bambini che gli anziani ucraini che resistono vivendo con poco o niente, infine si scusa in nome del mondo che vuole la pace.
Un uomo tra la folla attacca a suonare Toto Cutugno.
Cutugno mi ricorda l’Australia, vent’anni fa: quando andai lì, tutti i miei zii ascoltavano L’italiano. Chissà cosa direbbe l’Andrea di quel tempo all’Andrea di oggi. O viceversa.
In molti ascoltano il discorso del capo carovana, lo seguono mentre si affievolisce e si mescola tra le note musicali. Alcuni iniziano a muoversi per lasciar coinvolgere i corpi dalla musica e forse provano anche con le loro anime stanche.
Incredibile quanto alcune canzoni italiane siano evocative, soprattutto all’estero. Assumono un significato diverso, più nostalgico. A Cutugno segue Mango con Ti vorrei, che mi piace tanto, poi Celentano con Azzurro.
Guardo le persone, in molti ora ballano e cantano.
Gli ucraini gridano come possono in italiano e gli italiani abbracciano i loro vicini ucraini.
Devo riconoscere che, dopo qualche minuto, non vedo più differenze. Tutti ballano si mischiano non si conoscono e si abbracciano e non ci sono nazionalità, lingua o tratti somatici che tengano. Ai miei occhi sembrano tutti figli del mondo.
Però, allora, perché io resto fermo?
Neanche a dire che non mi vogliono o che mi emarginano. Io semplicemente non so come si fa.
Non so sentirmi parte di qualcosa fino in fondo.
Mi allontano, appena intravedo il van tiro un sospiro di sollievo e provo, sfiorando la terra con i piedi, a sgattaiolare lì. Riapro il taccuino senza far caso alle pagine e mi ritrovo con una pagina scritta in mano, c’è una frase che avevo segnato: “Ti auguro di trovare qualcuno che raggiunga temperature elevate al tuo fianco, così non dovrai passare tutta la vita a scongelare la tua anima”. Minchia, penso, quando l’ho appuntato?
Però sto meglio qua vicino al van, non c’è quel calore fievole della condivisione di balli e danze.
D’altronde il mio l’ho fatto. Ho guidato per migliaia di km, ho scaricato colli, ho aiutato dove potevo ma non posso condividere più di questo. L’incontro con quel papà ha mosso qualcosa, certo, ma sono ancora lontano.
Sento rumore di elicotteri, questa volta più bassi, vedo le persone in piazza guardare il cielo e poi guardarsi intorno. Forse, penso, ci smisteranno. Come ci spiegarono durante il viaggio verso Odessa, grossi assembramenti possono insospettire i satelliti o eventuali droni russi.
Forse gli elicotteri ucraini sorvolano la zona per questo motivo, avvisati dell’arrivo degli aiuti controllano tutto fili liscio.
Tiro un sospiro di sollievo, il momento di condivisione volge al termine velocemente. Mi sento però terribilmente in colpa per la mia incapacità di lasciarmi andare davvero.
Qualche signora ucraina mi stringe la mano, sanno che ce ne andremo e ci ringraziano. Ora riesco a guardarne qualcuna negli occhi. Scelgo solo occhi marroni, scuri, ci si vede di più dentro, sono più comuni, quindi li sottovaluti. Due signore mi fissano, io sorrido, loro mi guardano negli occhi e giungono le mani per ringraziare me e altri della carovana che ora ho vicino. Questo mi riesce meglio: prendere ringraziamenti, complimenti, compiacimenti, elogi. Sono un bambino invisibile e così prendo colore; sorrido per ringraziarle a mia volta.
Salgo sul van con quella nota di frustrazione che il senso di colpa mi causa. Che sono venuto a fare in questa piazza se non ne ho vissuto niente oltre al culo fatto per arrivarci? Mi scivola sempre tutto via dalle mani.
Prendo il telefono. Ora sento le pale degli elicotteri. La guerra ce l’ho tutta intorno, ma io sono così preso dalla mia che l’esterno non lo calcolo proprio.
L’occhio mi va a terra, sotto al sedile davanti al mio, c’è un biglietto scritto a penna, la calligrafia è ordinata, maschile direi. C’è scritto così:
“Tramonta il sole e sale su il gelo della sera
posso scaldarmi su di te anche se non c’è luna
valle di ghiaccio e paura, fatta di neve scura
se mi addormento in braccio a te ridammi la fortuna”.
Il biglietto mi gela i polpastrelli, sento la bocca asciugarsi, – ma chi lo ha scritto? – Lo chiedo intorno a me anche se sono solo sul van.
Lo lascio cadere a terra e con un calcio lo spingo sotto al sedile, il biglietto si rompe in piccoli pezzettini per poi sciogliersi.
– Oddio!
Devo essere stanco. Vedo tutto un po’ distorto, è normale; è stato un viaggio infinito e qui, all’apice, dove dovrei raccogliere emozioni, mi sembra ci sia solo altro freddo. Ci sta sentirsi un po’ fuori.
Guardo meglio sotto il sedile. Il biglietto è lì di nuovo, solo che ora c’è sopra la pubblicità di un gelato industriale e alcune scritte in ucraino, lo prendo, lo giro e dietro il foglietto è tutto bianco.
Mi strofino la faccia, guardo fuori, la festa è finita e la piazza più libera.
Efrem sale sul camper:
– Me sa che andiamo. Se sei stanco, dormi un po’, guida Giulio, m’abbiocco pur’io me sa.
Si butta sul sedile dietro al mio.
Annuisco e chiudo gli occhi mentre il rumore degli elicotteri si allontana; il mio dovere verso gli altri, alla fine, fin qui l’ho fatto.
Riprendo taccuino e penna, sfoglio qualche pagina e inizio a scrivere:
“Questa notte ripartiamo per l’Italia…”