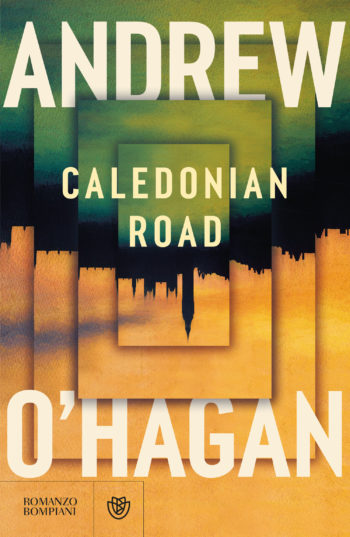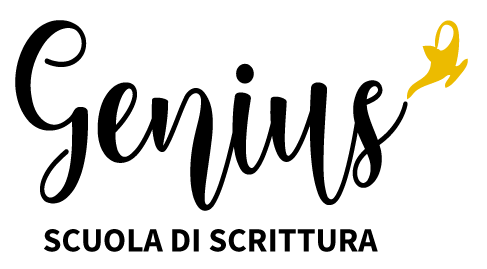Nei capitoli precedenti:
Venticinquesimo capitolo – Parole
Piove sempre. Il van schizza acqua ai lati delle strade. L’edificio sventrato è sparito alle spalle di una moltitudine di palazzi abbandonati. Il van non è il camper, quindi stiamo stretti e rimbalziamo sui sedili duri per via delle strade dissestate fuori dal centro di Mykolaiv.
Zaichivs’ke è il quartiere più colpito dalla guerra in questo circondario. Povero prima, ancora più povero ora.
Il nostro programma è raggiungere la piazza centrale del distretto e consegnare i beni di prima necessità alle famiglie.
Guardo fuori dal finestrino, il van avanza a singhiozzi in una piccola via che dà sulla piazza. Su ogni palazzo, insegna, tettoia, il grigio è ovunque e la pioggia ne riverbera tutte le sfumature possibili. Io non avevo mai notato quanto un colore potesse colarti addosso. Dopo un po’ lo assorbi. È triste il grigio, quindi sei triste ovunque guardi.
Mi gratto la faccia per scrollarmi quella tonalità scura dalla pelle. È l’ultimo impegno che abbiamo prima di tornare in Italia e, da quanto ho capito, siamo dove la guerra ha lasciato più segni. Prendo il telefono, lo sblocco. Guardo la foto profilo, Amelia abbraccia Domitilla. Poi lo richiudo.
Entrando con il mezzo, non mi ero accorto che la piazza fosse piena. Quel po’ di terra che si vede tra le decine, forse centinaia, di piedi dentro scarpe a mollo nel fango è anch’essa grigia. I palazzi intorno hanno finestre rotte, colori che passano dal bianco sporco al grigio antracite, alcune terrazze si mischiano con il cielo nero. C’è qualche giostra, vedo solo le parti superiori però, senza mettere a fuoco, percepisco la folla tutta intorno anche ai giochi. Non mi va di guardare le persone. Alla fine ho paura. Mi chiedo perché non ho paura della guerra, del rischio, ma non riesco a guardare il dolore de ’ste persone?
Ripenso a quel cagnolino che quasi gli spaccavo la testa, lo so io perché non riesco a guardarli questi qua.
Gli altri nel van con me scendono. Io ripongo il telefono. Vorrei scrivere a Domitilla. Lo riprendo in mano. Più una persona mi è vicina, meno parole ho da spendere.
È il segno più tangibile di quello che sono.
Ho capito che è quando non ho parole che sono davvero vicino a qualcosa, è lì che è tutto congelato. Per il resto del mondo, invece, la parola è l’unica arma che ho contro il vuoto.
Così faccio sfilare il telefono tra le mani e lo rimetto in tasca.
Scendo dal van. Una folla di persone sorride, aspettavano noi e gli altri del grande gruppo partito dall’Italia.
Decine di occhi azzurri mi fissano, ci guardano. Sono tutte donne, bambini, anziani. Nessun uomo della mia età o più giovane.
Sento una mano sulla spalla.
– Scarichiamo?
Mi giro.
– Sì, Giù.
Sorrido.
Ci mettiamo in fila e iniziamo a passarci i cartoni pieni di cibo, pannolini, medicine. Io sono nel mezzo. I pacchi scorrono fino a una donna ucraina, poi spariscono risucchiati tra mani su mani che scorrono avanti e indietro. Alcuni bambini mi girano intorno, salutano e corrono via tra la gente.
Hanno cappottini color pastello, blu, neri, rossi, colori che sul grigio si opacizzano dando la sensazione di trascuratezza.
Finiamo di consegnare un centinaio di pacchi, ho le braccia indolenzite mentre mi sgranchisco, allontanandomi dal gruppo per immergermi nella folla e perdermi un po’. Noto che anche dalle finestre ci sono persone affacciate che salutano. Io saluto, come se salutassero solo me.
– Andrea, Andre, porti questo a quel gruppo di mamme là?
Silvia sbuca al mio fianco come un fungo dalla terra. Letteralmente con un gesto atletico mi lancia un pacco di pannolini.
– Ehi Silvia, sì, vado.
Il tempo di risponderle e lei parla da sola sul da farsi mentre si allontana.
Volevo stare un po’ da solo, senza fare nulla, a guardare. Ma in effetti io non sono qui per guardare il tempo scorrere, come mi sembra di fare spesso a Roma.
Tutti gli uomini adatti alla guerra sono al fronte. Le donne devono andare avanti da sole, insieme agli anziani e ai loro figli.
Non hai molte alternative qui ora, o ti arruoli o sei un disertore. In molti hanno provato a fuggire quando la guerra è esplosa su scala nazionale, sono riusciti in pochi.
Arrivo dalle quattro donne con bambini piccoli al seguito.
Sento i piedi affondare nel fango, sorrido ai bimbi e mi vengono tutti incontro. Poi sento di lato sfilarmi il pesante pacco.
– Ti siamo grati. Ve ne siamo grati. Parlo male italiano, prendo io questo, dai.
Un ragazzo, avrà una trentina d’anni, con un bambino incollato alla gamba.
– Ci penso io, tranquillo.
Glielo consegno, sorrido cercando di nascondere in una smorfia la punta di stupore che mi rotola tra i denti.
– Parlo italiano perché vedo la vostra televisione, poi mio nonno era italiano, ha sposato mia nonna qui in Ucraina.
– Piacere di conoscerti. – Rispondo.
– Vedi, – ora si rivolge al figlio, – Lui ha fatto migliaia di km per arrivare fino qui per questi. Per aiutarci. Lui è coraggioso.
Anche se ha una forte cadenza ucraina, sento le parole uscire frammentate dalla commozione.
– Lui è più coraggioso di papà.
Io penso ad Amelia. Domitilla le ha spiegato che il papà è andato ad aiutare persone che hanno la casa tutta rotta. Mi chiedo se lo ricorderà.
Guardo il ragazzo.
Io non sono coraggioso, io non capisco cosa significa essere coraggiosi. A me sembra di fare tutto solo per essere qualcosa, altro che coraggioso.
– Non credo di esserlo, magari cerco di espiare qualcosa.
– Espiare?
– Sì, riparare qualcosa, liberarmi, espiare più o meno è questo.
– Beh amico, io mi sono fatto riformare, ho avuto paura. Ho un problema alla spalla e l’ho amplificato.
Guardo il bambino.
– Ti capisco.
– Tu hai figli?
Allungo la mano e sblocco il telefono per fargli vedere lo sfondo.
Lui resta in silenzio. Sbatte gli occhi come se gli pizzicassero. Io sto fermo, fermo nel senso che non ho idea di cosa fare.
– E tu non saresti coraggioso?
Questa volta resto io in silenzio.
Ho passato la mia vita a inseguire parole dette per poter sentire qualcosa. Da quando parlo meno, mi sono accorto che mi sento semplicemente un impostore. Troppe parole usate per convincere, per piacere, per essere almeno il riflesso di qualcosa.
Lo guardo negli occhi, i suoi blu liquido e arrossato, i miei restano verdi contornati di un bianco limpido.
– Non lo so, so che volevo andare in cerca di luoghi in cui poter essere qualcosa di definito. E mi sembra di farlo a scapito vostro, di cercare qualcosa di mio qui nella vostra disperazione. Capisci cosa intendo?
Il bambino tira la gamba del papà.
– No, non lo capisco. Il mio italiano è buono ma non così tanto!
Mi sorride e continua:
– Ma io so che pochi avrebbero lasciato quella bellezza lì, – indica il cellulare, la foto di Amelia, – per venire fin qui. Tua moglie deve essere orgogliosa.
Mia moglie, che moglie non è ancora, ha ben altri problemi con me.
– Credo sia arrabbiatissima, sai?
Sorrido.
– E perché?
– Perché l’ho abbandonata spesso, in mille modi diversi, pur di non lasciarmi andare con lei.
Lui mi guarda. Magari si chiede in ucraino: “Ma pensa come sta questo”. E avrebbe pure ragione. Invece mi tende la mano.
Io la stringo. È fredda e ruvida, avvolge completamente la mia. Mi guarda.
– Io, per esempio, mi vergogno. Mi vergogno e vedere te con una famiglia lontana con una bambina, qui a rischiare per questi aiuti, qualsiasi siano i tuoi motivi, ai miei occhi tu hai scelto con coraggio. Io, qui, in mezzo a donne e bambini, mi vergogno. Ma io voglio sopravvivere, io voglio vivere per mio figlio, io non voglio morire ma non sono un vigliacco.
Ora il bianco dei miei occhi si arrossa.
– Non ti dimenticare di questo: per mio figlio tu sei un eroe, insieme anche a queste altre persone che sono venute qua con te. Te lo meriti. Io resto qui da disertore.
– Ma, ma io non sono in guerra. Io sono qui pochi giorni in aiuto, tornerò presto a casa.
– Lo so. Certo, lo so. Tu però hai scelto, hai scelto e sei qui, rischi.
– E tu hai scelto tuo figlio.
Ora tutto si fa liquido e anche i miei occhi si appannano. Gli metto una mano sulla spalla.
– Siamo quello che siamo, amico mio.
Annuisce, allarga le mani e mi abbraccia.
– Grazie, amico mio, buon rientro a casa.
– A te buona fortuna, sarai un super papà.
– Pure tu.
Accarezzo la testa del figlio e sorrido alle donne. Gli do un ultimo sguardo, lui me lo restituisce annuendo di nuovo.
Il mondo è un posto incredibile, penso.
Con i piedi nel fango mi allontano e prendo il telefono, lo guardo e lo ripongo.
Arrivo fino a un gradino di una scaletta che sale verso l’ingresso di una casa dal portone divelto. Un gruppetto di donne suona in cerchio musica che mi sembra balcanica, altri del gruppo scaricano gli ultimi scatoloni di aiuti umanitari.
Tiro fuori il mio taccuino e inizio a scrivere, ho in mente poche parole, necessarie.
“Cara Domitilla…”