
Clelia Marchi e la vita su un lenzuolo
C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Nei capitoli precedenti:
Diciottesimo capitolo – Fame
Ucraina ’23
La mattina dopo la notte, ho sempre fame. È un istinto vorace che mi svuota lo stomaco, come se il sonno mi togliesse le energie.
L’alba deve essere passata da un po’, entra poca luce. La coperta della U.S. Army mi pizzica la faccia. Lo stomaco lo sento gorgogliare, mi viene in mente il mio bisnonno. Mi avrebbe amato. Lui, per assumere personale, portava i candidati a mangiare fuori. Gli diceva:
– Vuoi lavorare? Vieni a pranzo.
Se il pasto veniva consumato velocemente li assumeva. Altrimenti li rimandava a casa.
Da quando da bambino ho scoperto questa sua caratteristica, io osservo tutti mangiare. Per lavoro, donne, amici. Si capisce tutto.
Inoltre percepisco una profonda soddisfazione quando, prima degli altri, finisco di mangiare. È una sensazione che per anni si è mescolata al pensiero che mi forzassi, ho avuto a lungo il dubbio che la mia velocità fosse forzata dal pensiero del mio bisnonno.
Solo ultimamente ho compreso la mia voracità. Io non mangio per gusto, ma per saziarmi. Mi stufa mangiare, mi annoia, il cibo non è arte, non è seduttivo; le donne sono seduttive, il cibo è solo un mezzo. Un mezzo per sedurre, un mezzo per coltivare l’ego, un mezzo per colmare vuoti. Il cibo, per natura, è solo nutrimento, il resto è perdita di tempo.
Chissà cosa avrebbe pensato di me, a pranzo, nonno Nino – così lo chiamava mio padre e così lo chiamiamo ancora oggi.
Tiro piano piano la tenda verso di me, russano in pochi quindi molti sono già svegli.
Il cielo ucraino è come lo vedi in quei film distopici in cui si racconta del mondo dopo un’esplosione nucleare. Grigio, su casermoni grigi e alberi verde scuro con rami marroni che però sembrano grigi.
Mi alzo; Mariangela e Ludovico, seduti, si guardano intorno.
– Buongiorno. – Sussurro. Loro mi sorridono, esco dalla stanza mentre Mariangela inizia a svegliare tutti.
Fuori l’aria è fredda, metto il cappuccio e guardo il cielo che non cambia tonalità, resta grigio e bianco privo di spiragli celeste. Mi chiedo se un cielo simile incida sull’umore.
La dispensa all’interno del camper è ancora piena, prendo i biscotti e inizio a preparare i caffè, ne mangio cinque in meno di un minuto. Abbiamo poco tempo, quindi sono certo che a breve saranno tutti già pronti. E poi ho fame. Mangio una merendina, le stesse crostatine che piacciono ad Amelia. Non vedo l’ora di sentirla.
Ripenso al mio bisnonno mentre metto la prima cialda nella macchinetta portatile.
Ma come ha fatto?
L’odore di caffè inizia a spargersi nel camper.
Lui produceva, all’inizio, sette gusti di gelato, la panna fresca, dei bignè ripieni e la granita di caffè. In gelateria c’è ancora la macchina Camurri con cui lavoravano litri di caffè da ghiacciare. E ci ha costruito un palazzo e un successo secolare.
Una goccia alla volta, il caffè scende dalla macchina Nespresso.
Sono otto anni che gestisco il Palazzo del Freddo e ancora non ho inventato un prodotto che passerà alla storia, non so perché ci penso fissando le gocce cremose di caffè. Le persone me lo chiedono spesso però.
– Hai inventato qualcosa di nuovo solo tuo? – Oppure: – Uno come te di certo avrà inventato già un prodotto iconico? Il Sanpietrino è tua invenzione? – O ancora meglio: – Il gusto Amelia l’hai fatto?
Perché dovrei? Il gelato mica è un mezzo per dimostrare affetto o presenza, non voglio lasciare un segno così, io devo riempire un vuoto.
La prima tazzina è pronta nel momento in cui entra Mariangela dalle scalette del camper.
– Stai bene, Andre?
– Sì, tu?
– Sì. – Mi abbraccia.
– Un po’ scomoda, ma bene, ho dormito in posti ben peggiori.
Le allungo il primo caffè.
– È il primo, se non ti piace te lo rifaccio.
– Naa, dopo tutti quelli fatti per arrivare qui, ’sta macchinetta è meglio di una moka napoletana. – Si aggiusta una ciocca di capelli biondi, scendono morbidi.
– Devo lavarli, lo so, sono impresentabile.
– Direi proprio di no, sfido qualsiasi donna a farsi i km che hai fatto ed essere ancora così luminosa.
Beve il caffè, gli altri iniziano a salire uno a uno.
– Caffè per tutti?
– Ohh sì. – Rispondono quasi all’unisono.
Così in meno di venti minuti salutiamo i membri degli altri gruppi nella piazzola antistante alla scuola e ci organizziamo per avvicinarci a Mykolayiv.
Nel pomeriggio visiteremo un quartiere colpito in maniera grave dalla guerra per consegnare i beni di prima necessità caricati sul camper. Questa mattina, invece, ci dividiamo. Io andrò con i ragazzi in centro, Ludovico, Cecilia, Raffaella, Diletta, Efrem, Giulio e Amedeo. Gli altri devono incontrare alcune cariche municipali per spiegare il progetto principale per cui siamo qui, il generatore consegnato all’ospedale e valutare future missioni.
Così scendo dal camper e salgo sul van.
Il colore del cielo non muta di mezza sfumatura grigiastra, mi sembra piuttosto che si scurisca guardando verso Mykolayiv.
Le strade, entrati in città, sono abbandonate. Ci sono molti cani randagi che girano liberi. Probabilmente abbandonati.
Ci silenziamo tutti, come se vedessimo per la prima volta, in quel vuoto intorno ai cani, la guerra.
La città scorre, io tiro fuori il telefono e controllo l’app di allerta Ucraina, l’applicazione studiata per capire i territori caldi del conflitto. Il fronte da qui dista una manciata di km e sulla mappa dell’app è tutto rosso e costellato di icone di missili e droni. Mi strofino il naso e il viso.
A meno di un’ora di macchina, uomini della mia età si sparano per giorni interi, provando ad ammazzarsi per una guerra che, comunque finirà, loro perderanno.
Nessuno di noi parla, la città scorre, io mi appunto esattamente ciò che vedo, finché non arriviamo a destinazione. Il Palazzo del Governatorato di Mykolayiv, nascosto dietro grossi edifici grigi.
Dobbiamo lasciare il van, perché intorno alle strade del palazzo ci sono recinzioni in fil di ferro e croci di cemento e piccole casupole di colore militare. Non ci si può avvicinare con i mezzi.
Un cane ci gira intorno, annusa il van e se ne va.
Inizia a piovere, non mi ero reso conto del cielo ancora più scuro da dentro al van, avevo gli occhi fissi sulla strada. Siamo vestiti per reggere freddo, neve, ghiaccio, quindi nessuno si cura dell’acqua. Passa in strada qualche macchina, rari pedoni camminano veloci sui marciapiedi e tutti i negozi sono chiusi; il navigatore di Giulio ci indirizza verso una strada parallela. Superiamo croci di ferro e filo spinato, sembra che qui non ci sia nessuno. La strada è piena di foglie secche e coperte militari impermeabili, blocchi di cemento e filo spinato intorno a piccoli alberi che costeggiano la via.
Da una stradina limitrofa, piccola, si avvicinano due militari. Due uomini alti, il volto giovane, gli occhi azzurri. Mi fanno pensare al romanzo di Buzzati “Il deserto dei Tartari”, quando il militare rimasto di guardia vede il suo collega fuori dalla fortezza e gli spara, esegue solo un ordine pur sapendo che l’altro è un suo compagno, ma gli ordini sono ordini, quelli tassativi che restano validi anche dopo settimane di silenzio, l’attesa che culmina nell’unica azione possibile per un militare: Eseguire.
Tengono entrambi le mani strette sugli AKM, fucili spessi e robusti con una grossa canna per i proiettili di cui l’esercito ucraino è dotato, per la maggior parte forniti dagli americani.
Fanno cenno con le armi, senza parlare ma senza puntarcele, di allontanarci.
La pioggia batte più forte, nel buio del sole nascosto dietro le nuvole, gli occhi dei due militari brillano di un celeste carico di stanchezza.
Di nuovo ci fanno cenno di liberare la via tenendo in pugno le armi orizzontali.
Indietreggiamo tutti, loro muovono appena i fucili.
Ludovico resta fermo, poi si avvicina ai due che alzano le armi di pochi centimetri. Lui prova, in inglese, a spiegargli che siamo un gruppo di giornalisti italiani, poi non sento cos’altro dica. Mi sembra che i due rispondano in maniera gentile dopo i primi istanti, Ludovico annuisce e si allontana.
– C’ho capito poco, ma credo si possa passare da dillà, – Indica con la mano la parte opposta da un palazzo alla nostra sinistra, – Qui non si può perché passano i mezzi militari, dall’altra parte è possibile arrivare al Governatorato.
Così ci incamminiamo silenziosi, distanti l’uno dall’altro in strada. L’acqua inonda l’asfalto, le foglie secche ostruiscono gli scarichi e velocemente, data l’intensità della pioggia, piccoli torrenti scorrono vicino a noi sommergendo parte delle nostre scarpe. Non è come a Roma, che ti viene voglia di bestemmiare per l’incuria, qui tutto dipende dall’abbandono, non potrebbe andare diversamente. Decine di migliaia di abitanti di Mykolayiv se ne sono andati quando è scoppiata la guerra, la città è stata il fronte per settimane. Foglie secche e rami, nulla di più, niente bottigliette di plastica o carte di gelato o di patatine o sigarette, tracce umane non ce ne sono, qui non ci passa praticamente più nessuno. E sono vie centrali.
Penso a Via Principe Eugenio, penso a Roma vuota e al mio bisnonno che assume solo chi mangia veloce, chi assimila il valore del cibo non per riempire vuoti, ma per nutrirsi e andare avanti. Chissà cosa penserebbe di me, dilaniato dal rendere giustizia a lui, solo a lui attraverso il Palazzo del Freddo, a vedermi fare ciò che è giusto a costo di perdere pezzi di me veri, reali, frammentati dalla paura di essere altro se non un gelatiere con un cognome importante. Però mangio veloce, e lui mi avrebbe assunto subito e sono qui e non ho paura per ora. Questo pensiero mi riscalda mentre ormai valanghe di acqua si rovesciano su di me e su una città fantasma.
Sono l’ultimo del gruppo, tormentato da questi pensieri che mi si leggono tra le occhiaie e il volto smagrito. Giro verso la strada che gli altri hanno imboccato. Li vedo, tutti, davanti Ludovico, immobili, fermi con le mani sul viso o sulla bocca e alzo lo sguardo.
Il Palazzo del Governatorato spicca in mezzo a una piazza vuota, sventrato da un missile che lo divide in due parti come i meloni che uso per fare il gelato. Una voragine a forma di “v” che scende e squarcia il grigio del cemento. Si vedono le stanze degli uffici scoperchiate, annerite. Il palazzo non è crollato del tutto, ma il nero delle esplosioni resta lì, indelebile ai margini di una ferita che non si rimarginerà mai.
Gli unici colori sono quelli dei fiori a terra all’ingresso, colori di speranza; eppure penso che moriranno anche loro, strappati dalla terra.

C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Le carte della settimana sono: Forza, Papessa e Bateleur.
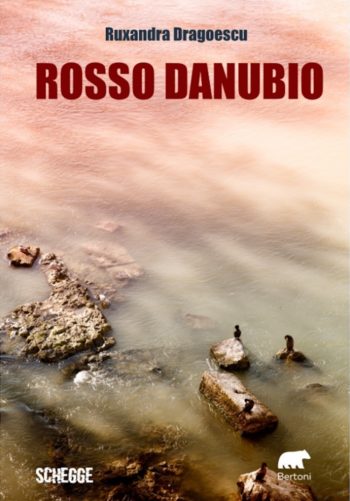
“Ho scelto un eroe collettivo. Ho una mia ossessione: capire, nella vita, come la Grande Storia assorbe la Piccola Storia, come vengono schiacciate le persone comuni dalle decisioni dei pochi”.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – [email protected]
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare