
Clelia Marchi e la vita su un lenzuolo
C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Nei capitoli precedenti:
Tredicesimo capitolo – Cibo da ridere, cibo da piangere
Mykolaiv, 2023
Il palazzo di Youth of Ukraine è rifornito d’acqua grazie a un pozzo. Se si blocca la pompa del pozzo i volontari devono camminare per otto chilometri con grossi contenitori da riempire per bere e lavarsi o per cucinare. Per questo, quando qualcosa si impalla nel caricare l’acqua, l’ansia ristagna nelle pance di ognuno di loro.
Mentre attraversiamo il cortile d’ingresso per capire se serve aiuto, ci viene incontro un ometto basso e piazzato. L’uomo indossa un maglione verde scuro di lana a collo alto. La barba bianca con spruzzi di nero sale dal collo fino al viso rotondo, ricoprendolo fino agli zigomi, svetta un naso grosso a forma di patata bucherellata. I capelli radi ondeggiano per via del filo di vento che tira, tra capelli e naso brillano due occhi piccoli e neri. Non sono occhi comuni, né belli né brutti ma intensi, con l’iride tagliata da striature di grigio come se il mondo che ha visto gliele avesse tatuate addosso. Ci guarda, apre la bocca in un sorriso enorme, gli occhi restano della stessa gravità. Ho come la sensazione che mi scrutino dentro, oltre il primo impatto è come se cercassero. Distolgo lo sguardo.
– Risolto! – Sorride. – Una stupidaggine, una molla saltata. Piacere di conoscerti. Sono Don Tonio dell’Olio, sono qui stanziale con Youth of Ukraine –, mi guarda.
Erri De Luca e Giacio lo salutano, devono conoscerlo già.
Gli stringo la mano, manco a dirlo è ruvida e dura. Sento la mia soffice e sottile inerme dentro al suo palmo.
– Lo sentite che profumo? Vi hanno preparato una cena di benvenuto. Anzi di ringraziamento.
Sorrido.
– Sarà una roba veloce. C’è il coprifuoco. Siamo a pochi chilometri da Kherson, il fronte. Vabbè lo sapete. Non adombriamoci, seguitemi. Tu hai affrontato un lungo viaggio mi sa. – Mi indica.
Annuisco e cammino.
Il cortile, nel tempo delle presentazioni, si è riempito di persone. Alcuni sono arrivati con me, altri italiani da quando è iniziata la guerra, e poi ci sono gli ucraini.
Mi guardo intorno. Tutti fanno qualcosa. Ordinano, distribuiscono piatti e posate di carta.
Erri De Luca cammina silenzioso. Incrocia le mani dietro la schiena, cammina e guarda al suo fianco il suo amico Giacio. Giacio mi esorta:
– Vai a vedere che roba, come ti cucinano. Vai vai.
Mi spinge con una mano sul sedere verso un gruppetto di persone accalcato davanti a qualcosa che non riesco a distinguere.
Mi faccio strada, sorrido, chiedo scusa in inglese e cerco di superare un po’ di persone per vedere.
C’è una casupola, una specie di casa per attrezzi, con delle donne che si adoperano, non capisco cosa fanno. Avanzo.
Superata la prima fila, mi trovo davanti un grosso carretto in ghisa, subito fuori la casupola. Una grossa signora ucraina, sudata e con il grembiule sudicio e un sorriso dolce che mi ricorda la panna in gelateria, mescola due grossi pentoloni dentro il carretto in ghisa.
– Borscht.
– Cosa?
Una ragazza vicino a me indica i pentoloni.
– Borscht. For you. – Poi indica me e altri in mezzo al gruppo.
È la cena.
– Borscht. – Questa volta lo ripete, prima però muove un dito vicino alla guancia come si fa con i bambini per dirgli che un piatto è buono e poi, però, mette la mano sul cuore. Ha gli occhi blu cristallino, i capelli lisci biondi e sul viso un pallore stanco che contorna delle occhiaie scure.
– Thank you – riesco a dirle.
Vorrei dirglielo bene però, senza che il tono di voce faccia sembrare il mio grazie un soffio menomato di un venticello primaverile.
Vorrei dirle grazie perché stanno qui nella merda a quaranta chilometri da dove si ammazzano e ci cucinano e ci sorridono. Ho la sensazione di arrossire.
Mi chiedo perché, qualsiasi cosa faccia, io mi senta sempre un impostore. Ma va meglio, adesso. Perché poi penso alla strada fatta negli ultimi anni, ai chilometri fatti per arrivare qui, al culo in frontiera, all’essere qui se sparano un missile magari rischio pure io.
Sì, perché a casa non ho detto di aver scaricato le applicazioni di allerta attacco aereo o di droni, non ho detto molte cose sui rischi di questo posto.
Un ragazzo enorme, alto due volte me e largo tre, mi mette in mano un piatto di Borscht.
Il Borscht ha molte varianti, propriamente è una zuppa di barbabietola, questa volta con carne di maiale, pomodori, cipolla, aglio, sale, spezie, cetrioli, patate, spesso anche panna acida. Resto immobile e prendo il cucchiaio, con la mano sinistra lo ficco nella zuppa e assaggio.
È il tempo del contatto tra labbra, lingua e liquido in cui la ragazza mi grida:
– No! – Il suo no arriva prima dell’aglio, prima delle spezie e, me ne rendo conto in un istante, troppo tardi per la temperatura.
Non posso sputare. Posso ustionarmi, sì, ma non posso sputare. Sputare il piatto rappresentativo di tutta l’Ucraina in faccia a questa ragazza è fuori discussione.
È la prima volta nella vita che metto in bocca qualcosa di così bollente. Sento la lingua squamarsi dopo essersi ritratta in gola, gli occhi stringersi fino a diventare due fessure raggrinzite, espiro aria tenendola in bocca sperando qualcosa accada, sperando il fiato tolga almeno in parte il bollore. Non vedo più niente. Se con il freddo il gusto è inibito, con questo calore non lo percepirò mai più.
Gonfio un po’ le guance, sento esplodere il calore tutto sul palato e sotto la lingua.
Intravedo qualcosa muoversi, un’ombra. Un cucchiaino, mi sembra di vedere ora con gli occhi socchiusi, mi si avvicina alle labbra, sento il metallo e il bruciore sulla parte esterna delle labbra rinfrescarsi appena, così si schiudono di riflesso e intravedo la ragazza infilarmi in bocca qualcosa di molle e untuoso.
– Eat!
Annuisco.
– Eat!
Mastico, spalmo sulla lingua e sul palato questo composto molle e grasso. È panna. Panna! Con i grassi si crea un vero e proprio film, una patina sul palato che, se normalmente allevia il piccante, riesce almeno i parte a calmare l’ustione.
Apro gli occhi, la ragazza ha la mano sulla bocca, gli occhi a fessura sorridenti. Le viene da ridere. Da ridere. Io quasi brucio e lei ride.
Ci guardiamo negli occhi, lei leva la mano dalla bocca e soffia sul mio piatto. E ride.
Lei tira fuori la lingua:
– Are you ok?
E poi proprio non riesce e ride di nuovo.
Il suono del suo ridere è limpido, suona come il ghiaccio che si stacca da una montagna, è il suono di una risata cristallina che arriva fino alla mia bocca, raffreddandola.
Ma è la panna a salvarmi. Non la mia panna, la panna tipica del Borscht qui in Ucraina.
Roma, 2016
Il pastificio Cerere è un ex pastificio attivo fino al secondo dopoguerra. Si produceva pasta dal 1905. Poi dagli anni Settanta alcuni artisti si sono insediati per vivere e creare le loro opere, dandogli nuova vita e sono riusciti, negli anni a venire, a trasformare il pastificio Cerere in un luogo di riferimento per la cultura romana. Oggi c’è un ristorante all’interno.
– Va di moda – mi ha detto al telefono la giornalista.
Seduto su un divano mi guardo intorno. Se mi vede qualcuno che conosco, come mi giustifico? Non dovrei essere con lei, l’ennesima via di fuga. Sento lieve il desiderio di andarmene.
L’età media mi sembra sui quaranta, un po’ più di me. Coppie o gruppetti di amici che bevono vino, ridono e scherzano. Intravedo la cucina, pulita, quando una cameriera esce di lì. Ha i tacchi bassi, quelli che non mi piacciono, una camicetta grigia e un gilet scuro. Ha due piatti in mano e, mentre muove la gambe sode e scattanti, una caviglia si piega, lei si arrotola su se stessa alzando le braccia con i due piatti per evitare di farli cadere. Non è lontana da me, anzi, così d’istinto mi alzo per aiutarla. Lei è più veloce e riesce miracolosamente a rimanere in equilibrio. Sospira e mi supera.
Mi risiedo. Non sento odori. È strano per un ristorante. O meglio, la canna fumaria e l’areazione ormai eliminano gli odori, certo, sarebbe bello non sentirsi in una sala operatoria. Bevo un sorso di vino. Poi un altro. È in ritardo.
Il che non mi preoccupa, penso di nuovo che non dovrei essere qui, non solo per la persona con cui dico di stare, ma pure per me. Che ci sto a fare?
Un pensiero mi sale dal buio. Fortuna che ho incontrato solo donne che posso gestire, che tengo alla giusta distanza e a cui non permetto di affacciarsi troppo oltre ciò che voglio mostrare. Tutto apparentemente più facile, così.
Bevo ancora. È un pensiero del cazzo anche perché non ne capisco il senso. E il motivo per cui debba annoiarmi proprio adesso.
La cameriera neanche mi ha sorriso per il tentativo di aiutarla. Forse per imbarazzo.
Eccola! Clara, Chiara, Caterina come cazzo si chiama la giornalista?
Entra dalla porta e saluta un cameriere che le tiene addosso gli occhi più del dovuto. Bona però è bona, ammazza. Ha uno stivaletto stretto fin sopra alla caviglia, un vestito corto e un corpo esile, il collo pallido affusolato inchiodato su due spalle delicate e un piccolo tatuaggio in vista proprio sulla spalla. Ha un viso disegnato di lentiggini, gli occhi e i capelli castani con riflessi rosso mogano.
È qui che devo essere.
Il telefono mi suona, guardo chi è, lo giro e lo silenzio.
– Ciao Andrea!
– Ciao, vieni, siediti.
Mi alzo per farla sedere.
Ha i denti bianchi e grandi, adagia la borsa con due giri di tracolla alla sedia e si siede.
– Sono felice di vederti.
Si tocca i capelli e abbassa lo sguardo.
– Recensisci spesso ristoranti simili? – Le chiedo.
– Sì, più spesso pasticcerie caffetterie e gelaterie però.
La cameriera che prima era a un passo dalla rovina ci porge due piatti.
– Un omaggio per darvi il benvenuto dello Chef: “Cialda vegana di ceci, gelato di barbabietola e fegatelli”.
Sorridiamo entrambi.
– Sorbetto di rape, lo sai fare?
Sorrido.
– Sì, ma devo ancora capire cosa pensare di questi tentativi.
– Tentativi?
– Beh, questo non è gelato. È un tentativo.
– Tentativo di che?
– Esercizi di stile per portare il gelato in nuovi spazi, prove, ma te l’ho detto, non ho ancora un’idea chiara.
La guardo negli occhi.
– Sì, me lo hai detto. Ho la sensazione che ti pesi lavorare nel gelato.
No che non mi pesa. Cretina. Mi pesa nella misura in cui mi pesa questo posto per fighetti e mi pesa tutta l’esistenza, te compresa. Che cazzo di domanda, “ti pesa”. No, se non fosse stato per i coreani adesso starei affanculo chissà dove, senza una lira. Quindi sì, mi pesa ma me lo faccio andare bene.
– Beh, un po’ sì, onestamente. – Tossisco. – Sai, ho rinunciato a delle cose, a delle strade.
– Sì?
– Sì.
Guardo altrove, fuori dalla grossa vetrata pioviccica, la gente accartocciata negli impermeabili schizza impazzita sul marciapiede, in cerca di riparo. Chissà perché quando piove tutti perdono il lume. Traffico, impermeabili, appuntamenti rimandati, uscite evitate, il gelato vende meno.
– Tipo?
La riguardo. Se non fosse così bona sarei triste, mi farei un piantarello se fossi capace, ecco. Che le spiego io a questa? Tipo che sorrido per finta, che non faccio eccezione tra migliaia di parole perché il punto fermo di ogni conversazione è sempre l’invisibile che indosso.
– Tipo che avrei voluto scrivere.
– Puoi sempre farlo.
Me lo dicono sempre. Tutte. Perché lo racconto solo a chi conosco poco; chi ho vicino invece a malapena lo sa, cioè lo sa all’inizio poi finisce per dimenticarselo.
Abbasso la testa e assaggio l’entrée. Il sorbetto di barbabietola mi punge i denti. La cialda friabile si sbriciola. Lei pure assaggia, schiude le labbra rosso peperone, né sottili né grosse, disegnate. Si schiudono e mi sembra di sentire odore di lucidalabbra alla fragola misto alla barbabietola.
– Sì, potrei.
Ma è chiaro che se potessi, lo farei. Ma non ci riesco proprio.
– Buono eh?
– Sì, non male. Il sorbetto forse è un po’ dolce.
– Eh detto da te, sarà deformazione professionale.
Il telefono mi suona di nuovo, lo silenzio ancora.
Lei lo guarda, poi mi guarda, io accenno un sorriso, ho la sensazione voglia un bacio.
– Era la tua fidanzata, vero?
– Scusami?
Che sfacciata.
– Al telefono. La tua fidanzata.
– Perché?
Le donne lo sanno, non c’è niente da fare.
– Era quella che durante l’intervista l’altro giorno è salita nel tuo ufficio, giusto?
Vorrei mentire. Dire no. Dire era una mia amica, una mia collaboratrice, mia sorella. Normalmente lo farei. Una sensazione di tristezza mi asciuga la bocca. Ma che ci sto a fare qui, magari mi sputtana pure. Poi la guardo, alzo gli occhi è bella bella, tutto riparte come sempre, il buco nero ricomincia silenzioso a ingurgitare ogni pensiero.
– Sì. – Rispondo tentennando.
– È bellissima. E ha un corpo mozzafiato.
Che stronza. Che stronza.
– Eh sì.
Ma te pare? Lo so bene che è bella e che ha un corpo mozzafiato. Sta stronza però sa di essere bella da far girare la gente per strada e finge non ci sia competizione, finge. O forse è solo un nuovo genere di femminismo. Però sta qui, la stronza, no è solo stronza, altroché.
– Ha la faccia da stronza però.
Ecco, qui ci vedo più genuinità.
– A volte lo è.
– Non ti va di parlarne?
– Secondo te?
Ci guardiamo. Non le pare vero di scavalcare una donna bella. Sta godendo, glielo leggo negli occhi che quasi me ne andrei. Quasi.
– Scusami, devo andare in bagno. – Lo dice però con un tono che suona caldo, avvolgente.
Si alza, intravedo la pancia olivastra e morbida. Se non mi fosse già successo in passato, giurerei di aver intravisto un gesto come a dirmi di seguirla, un movimento degli occhi. Non ci credo.
Chiede alla cameriera informazioni sul bagno, la ragazza glielo indica. Il bagno è dritto davanti a me. Se mi guarda di nuovo, mi alzo.
Il locale è pieno, i camerieri si incrociano con le mani piene di piatti pieni e vuoti, c’è un chiacchiericcio di sottofondo, mi sembra lei si avvicini al bagno a rallentatore.
E poi, a poco meno di un metro dalla porta, si aggiusta il vestitino e si gira. Mi guarda, si morde il labbro appena, in modo elegante, muove la testa e poi sparisce dietro la porta.
Io scalzo il tovagliolo dalle gambe e mi alzo, senza dare nell’occhio, fermo un cameriere:
– Scusi, sa dirmi dov’è il bagno?
– Lì in fondo, signore, quella porta che si sta chiudendo.
– Grazie.
Arrivo alla porta, prendo la maniglia ed entro. Il bagno degli uomini è chiuso, quello delle donne aperto. Mi affaccio. C’è un antibagno con un lavandino in acciaio e poi un’altra porta socchiusa.
C’è odore di disinfettante. Busso. Chiara, Clara, Caterina insomma, la giornalista apre la porta, è lì, appoggiata sul muro a mezzo metro dalla tazza del cesso.
L’odore di disinfettante alcolico si mischia alla mimosa del profumo per ambienti messo accanto alla spazzola per la tazza.
Mi avvicino. Chiudo la porta.
– Non lo faccio con tutti.
– Devo crederti?
– Non mi interessa. Ma non lo faccio con tutti.
– E perché con me sì?
Perché sei una stronza. Perché ho una fidanzata che rischia di essere più figa di te e a te non va giù.
– Perché mi piaci. Come guardi, il modo.
Le prendo il viso tra le mani e la bacio. Le sue labbra sanno di fragola e cioccolato, arrossate dalla barbabietola e dal contatto con le mie si schiudono, lasciandole muovere la lingua piccola e ancora fredda del sorbetto.
Una vocina, nella mia testa, che sale dal petto mi parla nell’orecchio.
– Lo so che vorresti piangere, roccia.
Le lingue si attorcigliano, la vocina grida. Di tutta risposta, più lei grida dentro di me, più le mie dita affondano nella carne delle gambe della ragazza di cui non conosco il nome. Lei mi bacia il collo, sento le sue unghie sulla schiena prima che si alzi il vestito che struscia sulla mia maglietta. La vocina si silenzia, tutto intorno svanisce, non c’è gioia o dolore e il suo vestito le sale sopra la pancia. Non c’è altro che profumo di fragole, cioccolato e disinfettante.

C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Le carte della settimana sono: Forza, Papessa e Bateleur.
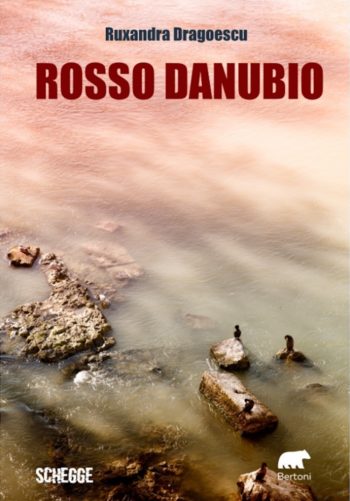
“Ho scelto un eroe collettivo. Ho una mia ossessione: capire, nella vita, come la Grande Storia assorbe la Piccola Storia, come vengono schiacciate le persone comuni dalle decisioni dei pochi”.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – [email protected]
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare