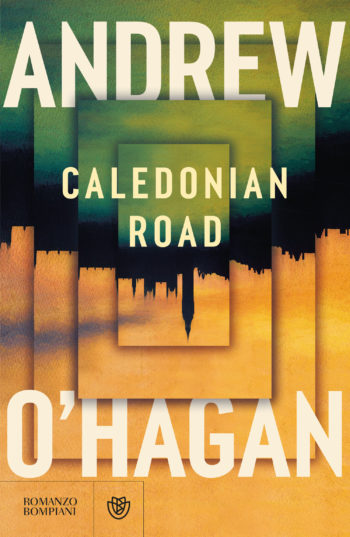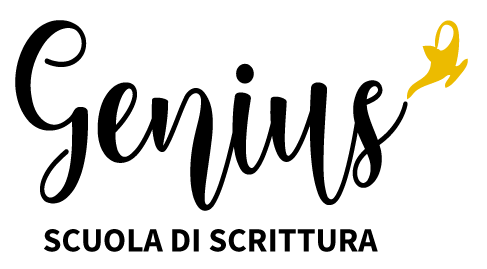Papille, il seguitissimo critico gastronomico fuori dagli schemi, amato dal popolo e temuto dai più grandi chef, perde l’uso della lingua e del gusto per la vendetta di uno chef stellato.
Puntate precedenti
Capitolo 1 – Panace di Mantegazza
Capitolo 2 – Cappio
Capitolo 3 – Ferite
Capitolo 4 – Mignon vegani, alici, cacao e melanzana
Capitolo 5 – Strazzata lucana
Capitolo 6 – Pomodoro Ciettaicale
Capitolo 7 – Battuto d’occhio
Capitolo 8 – Sardine
Capitolo 9 – Zuppa di pipistrello
Capitolo 10 – Tramezzino pollo e insalata all’obitorio
Capitolo 11 – Lampare
Capitolo 12 – Pesce fresco
Capitolo 13
Entrée
Vede dottoressa, il mio lavoro è un atto di fede. È il mio modo di rispondere al vuoto che sento. Io mando giù, ingoio e giudico gli altri per non giudicare me stesso.
Si tratta però di un lavoro certosino, epocale. Mi segua. Il mio giudizio culinario è spietato ma è anche perfetto.
Lei continua a dire – c’è dell’altro, – ma io altro non vedo. Vedo un uomo appena avanti con l’età, di successo, che realizza di avere come scopo il non scendere mai a compromessi con una categoria che fa del cibo il proprio feticcio. Perché di questo si tratta dottoressa.
L’altro ieri ero a cena da un tre stelle Michelin. Famoso, lo conoscerà di certo. Arrivo, mi vedono, mi riconoscono, mi siedo. Avevo prenotato con un nome qualsiasi lasciando come sempre la carta di credito. Non lo chiedono mai il nome della carta. È così meschino chiedere la carta di credito per evitare disdette dottoressa. Altroché. Se salta il tavolo perdono soldi, – se il tavolo salta per noi sono costi. Il cliente deve essere educato, – dicono.
È un pensiero che spoetizza il concetto di cucina, uno squallido mercanteggiare con quel feticcio di cui le parlavo.
Insomma, non divago. Arrivo e mi siedo in questo ristorante. Tonalità scure. Elegante. I tavoli minimalisti apparecchiati solo con un piccolo centro tavola, un fiore di loto con striature di rosa antico. Le posate in argento, il tovagliolo porta la iniziali dello Chef M.S. in corsivo. – Gradisce dell’acqua? – mi chiede il cameriere quasi inchinandosi. A un mio cenno mi versa della San Pellegrino. Capisce dottoressa? La San Pellegrino. Tutti i migliori ristoranti usano San Pellegrino, anche all’estero i migliori ristoranti usano San Pellegrino. In Cina i ristoranti mediocri per far bella figura usano San Pellegrino. Non è buffo? Non sono tutti uno stesso enorme meccanismo dove il cibo non è altro che un mezzo? Tutte le macchine vanno a benzina e tutti gli chef usano San Pellegrino. E parlano di unicità della loro cucina, di identità.
Comunque dottoressa. Il menù è un menù da duecento quaranta euro a persona. Vini esclusi.
Io me lo immagino lo Chef spendere la vita a studiare, dottoressa, davvero lo immagino cucinare per ore, la gavetta, il sudore, i primi risultati, la prima stella, il cielo che si illumina, il primo ristorante di proprietà, la seconda stella, il lavoro all’estero, lo straccio di notorietà, la terza stella. A me non interessa, non me ne faccio niente della loro esperienza. Io critico la personalità, critico l’uso diabolico del cibo, tentatore. Io distruggo il loro ego sperando di mandare un messaggio chiaro.
Mi serve sapere cosa sei oggi, cosa vuoi dirmi oggi con i tuoi piatti. E spesso vogliono tutti dire la stessa cosa: – Io ci sono e voglio essere il migliore. Nessuno vuole dire: – Hey, io rispetto il valore primordiale del cibo, non mi interessano premi e sponsor, a me interessa cucinare per la gente, per tutti.
Egocentrismo dottoressa, distrofia dell’ego nel meccanismo da ungere con una bottiglia di San Pellegrino.
Il cameriere mi lascia un piatto con cinque gocce di olio torbido, non filtrato, bello, un cespuglio di alghe, tre ravanelli, due conchiglie di media grandezza, grani di sale grosso, noce moscata e una spuma di champagne e ostriche che sembra una nuvoletta di un cartone animato. È l’entrée dottoressa. È la stretta di mano, la presentazione.
– Abisso – dice il cameriere indicando il piatto. In lui dottoressa c’era paura. Scandisce quelle sei lettere tremando.
L’alga sembra posizionata da un bambino, troppo arrotolata, spennacchiata. La consistenza della spuma è buona. In bocca sento il mare. Le ostriche restano sul palato non quanto avrei desiderato e lo champagne è troppo vecchio. È una stretta di mano molle dottoressa, quelle strette che ti fanno capire subito la consistenza dell’interlocutore. Per me è importante. Io sento quando questi chef sono fragili, li vedo oltre le loro casacche. Cercano consenso, sempre. Non sono artisti come credono. Io cerco dentro di loro, scavo come un forsennato, nelle mie recensioni scarnifico il loro ego fino a renderli vuoti gusci privi di alcunché.
E mentre il pensiero della stretta di mano molle cresce dentro di me, mi punge quel punteruolo di rabbia nel fegato. Quella sensazione che mi ha portato qui da lei. Mi prende una fitta lì quando mi trovo a dover distruggere uno Chef. Una rabbia violenta che posso solo utilizzare davanti allo schermo mentre registro la recensione.
Insomma dottoressa mi alzo da tavola e me ne vado. Perché quando tu stringi la mia mano, senti la pasta, il calore del palmo e la pelle liscia, la forza dosata con sapienza. Mi alzo e me ne vado dottoressa per quella stretta molle. Lascio tutti in un abisso appunto, ma di sgomento.
E mentre esco dal ristorante cosa accade dottoressa? Mi trovo lo Chef piantato sulla porta. Mauro Sagripanti. Lo conosce di certo. È un uomo lungo e affilato dall’espressione saccente. Gli occhi tagliati sottili in orizzontale su un viso scavato e magro. È alto, imponente nella sua magrezza, dottoressa. Ha una postura rigida, vuole spiegazioni prima che io vada via. Mi minaccia senza dire una parola. Qualsiasi cosa dicessi dottoressa, lui non l’accetterebbe ma soprattutto non la capirebbe. Il punto è che ha perso, e lo sa.
E sa cosa faccio dottoressa, un passo laterale. Uno solo. E poi tiro dritto. Ma prima, mentre le mie gambe scartano l’ostacolo, lo guardo dentro quegli occhi taglienti, con il disprezzo uscito dal mio fegato puntellato per renderlo cieco di rabbia.
Quello sullo Chef Sagripanti fu un video da seicentomila visualizzazioni. E come spesso accade la Michelin riaggiornò all’appuntamento annuale le sue stelle, togliendone una. Se li fanno lì sul libro rosso degli scrupoli quando parlo io.
Dottoressa, cosa capisce lei da tutto questo? Se non che io, per me, la fragilità, non la tollero. Che altro dovrebbe esserci?
Ce l’ha davanti l’albanese. A pochi passi dentro l’androne. Sembra ancora più grosso del solito. Passano pochi secondi. Papille fa un passo di lato. L’albanese lo imita bloccandogli la via. Un passo indietro. L’albanese si avvicina.
È un mestiere quello della criminalità, come il cuoco o il fabbro. Uno vale l’altro quando si è davanti a un intoppo più grande di te, tutto si azzera e fa breccia l’istinto.
Mentre i due si muovono, il portone si apre con un sibilo. Devono aver citofonato e qualcuno deve avergli aperto.
Per non dare nell’occhio, Adriàn lo strattona e lo trascina verso le scale.
– Tu sei più stupido di come pensavo. Mi hai fato regalo grande a venire qui.
Papille sente sul collo il fiato riscaldargli la pelle. Adriàn lo trascina su per due piani e si ferma davanti a un portone blindato rivestito in legno.
Una targa d’ottone ha inciso il nome in stampatello Fabio Carletti. Sotto, in corsivo, “revisore contabile, esperto in diritto commerciale.”
Adriàn suona. Dalla tromba delle scale arrivano le voci di un uomo e di una donna, seguiti dal ridacchiare di due bambini, due maschi. Papille li sente correre e saltellare sui gradini un piano sotto di loro.
Ad aprire la porta è un uomo nerboruto, dalle mani grandi. La prima cosa che nota Papille. Ha una camicia bianca opaca sbottonata sotto al collo, una cravatta allentata e la pancia gonfia. Il volto ha lineamenti delicati, occhi verde scuro su capelli castani. Un grosso anello al dito indice gli stringe la falange come fosse un salame.
– E questo chi è? Avvicinalo.
– Questo è il tipo che ti dicevo prima fratè, questo ora lo vede di cosa si parla qui. Questo pezo di merda. Di merda. Che ha staccato mezo colo di mio fratello. Pezo di merda.
Adriàn spinge la faccia di Papille contro la porta d’ingresso.
– Stai fermo imbecille. Vuoi ci becchino testa di cazzo? Entra. Albanese di merda.
– Parla bene pezo di merda. Tu lo sai che io non ci mete niente. Niente a tagliarti le palle.
– Sì le palle. Entra.
Lo studio è una grande sala open space. Legno qua e là, diplomi, lauree e master. Una grossa scrivania con un mappamondo color ambra sul lato. I muri sono costellati di quadri, tutti paesaggi tranne uno. L’autoritratto di questo tipo, il commercialista. In veste ottocentesca.
– Questo te lo dico io chi è Adriàn. Te lo dico io capra di un albanese che non sa un cazzo di quello che lo circonda, un cazzo di niente sai. – Carletti allarga le narici.
Papille tira il braccio per liberarsi dalla presa di Adriàn che cede.
Guarda il tipo e non risponde. Pensa di usare l’unica arma che ha.
Tira fuori il moncone e fa cenno di non poter parlare.
– Questo pezo di merda parla, Fabio. Te lo dico io. L’ho sentito che parla – Adriàn grida, tirando a Papille uno schiaffo sulla nuca.
– Stai zitto. Questa è grossa. Ma davvero grossa. Devo prendere il telefono.
Papille oscilla la testa. Dietro la scrivania c’è una libreria con decine di Faldoni. In stampatello con un pennarello rosso sono scritti gli anni e i nomi dei clienti. Aronne, Adalgise, Braschi, Baratti. Papille scorre con gli occhi veloce. Donnini, Drusi. Ancora più veloce. Ianni Iervolino Montanari Montecchi, Parisi, Pavoncelli. E poi, Sagripanti trattino Sarpi nello stesso faldone.
Suona il campanello. Adriàn lascia la presa. Carletti guarda i due e fa cenno all’albanese di allontanarsi da Papille. Si sistema la camicia e stringe la cravatta.
– Chi è?
Continua…