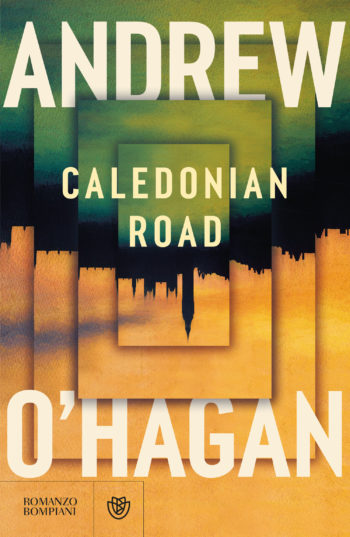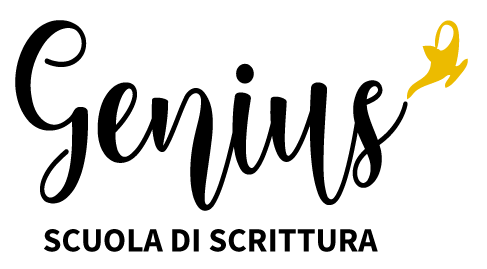Nei capitoli precedenti:
Sesto Capitolo – Bestialità
Berehove è la cittadina di frontiera ungherese che abbiamo appena superato. Uman sarà la prima tappa, sulla strada per Odessa, la nostra tappa prima di Mykolayiv.
Capisco ci fermeremo in un piccolo albergo aperto a pochi chilometri dalla frontiera. Mi stupisce ci siano alberghi aperti in un paese in guerra.
La strada è libera. È notte e siamo stremati dal viaggio. Scarico sul telefono le app di allerta missili e allerta allarme aereo che avvisano in caso di attacco russo. L’app suona con una sirena uguale a quelle che suonano in città, mi dicono. Ti aggiorna su tutti i punti di sicurezza dove scappare per rifugiarsi all’interno di bunker seminati su tutto il territorio. Non ne ho ancora visti in questi pochi chilometri percorsi dentro l’Ucraina, ma è presto. Da quanto ho compreso, la parte calda arriverà nei prossimi giorni. Siamo lontani diciotto ore dalla trincea di Kherson vicino Mykolayiv, dove le persone muoiono e gli allarmi suonano ininterrottamente.
Parcheggiamo nello spiazzo di un motel. Ha un’insegna fluorescente striata di rosso e blu, entrambi i colori luminosi contornano la scritta Motel, solo la L è spenta. Intorno come funghi in autunno spuntano pochi edifici grigi, asfalto ovunque e un prato che nell’oscurità notturna mi sembra di colore giallo paglierino.
All’interno, alla reception, ci accoglie una signora ucraina. È immobile dietro al bancone in legno laccato e parla solo ucraino. Non fa nulla per agevolarci, lo vedo dai tratti duri, scavati del volto. Sfoggiamo diverse lingue, dall’inglese al francese allo spagnolo ma niente, sembra quasi non le distingua l’una dall’altra. Lei non si muove, fa solo cenno con il volto stanco di non capire. Indossa un vestito celeste a righe bianche e sulla testa una crocca nera come il petrolio, la guardo un po’. Poi ho un’idea. Uno dei miei migliori amici, a Roma, ha la moglie ucraina. Lo chiamo. È molto tardi ma capirà. Rispondono con la voce impastata dal sonno, sanno che sono qui in Ucraina e sento preoccupazione mista alla stanchezza di chi è stato svegliato nel cuore della notte inaspettatamente. Anastasia ci aiuta a prenotare le stanze separate e a pagare, via telefono. Finalmente ci dividiamo maschi e femmine nelle varie stanze.
Mi trascino verso la stanza che condivido con Ludovico. Mi chiedo cosa pensi di me. È il giovane giornalista che segue la carovana per scriverne poi sull’Espresso e, mi racconta, anche sulla testata online Tpi.
Percepisco una cura delle parole maniacale. Ha questa capacità verbale prima ancora di quella scritta che mi arriva dritta la sua certosina ricerca dei termini adatti, del linguaggio aulico mai pomposo, preciso, chirurgico, affascinante. Mi sta simpatico proprio, a pelle. È un po’ più giovane di me.
Sdraiato sul letto di una stanza fisso il soffitto, Ludovico nel suo letto carica la sua macchina fotografica.
Sono in Ucraina, un paese inserito nella top ten dei paesi più pericolosi al mondo.
– Hai paura, Ludo?
– Sì, ma l’altra volta ne ho avuta di più. Sono stato qui poco dopo lo scoppio del conflitto.
– Ah sì?
– Sì, non proprio qui, sono passato dalla Polonia. Sai qual è il lato già schifoso della guerra?
– Le morti inutili?
– No no.
– Tira fuori la bestialità. Ci ricorda quanto possiamo essere abietti.
Resto in silenzio, mi chiedo cosa abbia trovato.
– Sai che gli uomini si sono dovuti arruolare allo scoppio della guerra? Molte donne quindi sono scappate. Sole o con figli.
– Sì, ne ho letto.
– Ma hai letto dove finiscono alcune di loro?
– No.
Mi gratto il naso, il muro bianco ora sembra liquido, il sonno cerca di colare dentro di me. Provo a battere le palpebre. Ludovico ha una bella voce e parla piano, parla consapevole di saper orchestrare le parole.
– C’era questa donna, mentre ero in frontiera, in Polonia. Con una bambina. Sedute a terra lei teneva la bambina stretta tra le braccia.
Dopo pochi minuti si sono ritrovate contornate di uomini. Era notte e la donna e la piccola avrebbero dormito in stazione. Gli uomini intorno provavano a convincerla che con un passaggio sarebbero arrivate presto in un luogo più comodo, sicuro.
Lei rifiutava.
I muri tornano spessi, il sonno sparisce, sento le guance arrossarsi.
– Poi gli uomini hanno iniziato a strattonarla. Più la strattonavano più la bambina la stringeva. Nessuno faceva niente. Finché io mi sono staccato dal mio gruppo e sono intervenuto, e altri mi hanno seguito e ho allontanato gli uomini. Sembravano iene su una preda.
Sbuffo. Ecco uno dei motivi per cui sono qui. Toccare con mano la ferocia.
Il muro si apre, la voce di Ludovico rimbomba, ripone la Reflex, respira, sento il ticchettio dei cavi, la zip della custodia.
– Tratta di esseri umani, la peggiore delle intenzioni umane, il grado più basso, tratta di persone, organi, esseri viventi.
Vorrei il muro mi risucchiasse, vorrei sparire.
– Tutto ok?
– Sì sì. Pensavo solo a quello che mi stavi raccontando. Pensavo.
– È una merda, lo so.
– Sì. – Mi giro su un fianco.
– Fai un lavoro duro. Sono felice di averti conosciuto, sei in gamba.
Ludovico sorride.
– Tu pure non scherzi, mi hanno parlato molto di te.
Quando porti un cognome che può avere un significato per le persone che non ti conoscono, non sai mai cosa si intende quando ti si dice:
– Mi hanno parlato molto di te.
È una gentilezza? O davvero gli hanno parlato di me? Queste sono persone che il vuoto lo hanno riempito di scelte, di cultura, di empatia. Quel vuoto che mi logora in loro non c’è. Forse gli hanno parlato davvero di me mi dico.
Sorrido.
– Ci provo. Mi fa strano essere qui. Alterno momenti in cui mi dico: “Ma che cazzo fai?” a momenti in cui l’adrenalina mi lascia i brividi sul volto e potrei arrivare domani mattina a destinazione.
Guardo Ludovico che sorride.
– Mi puoi prestare il cavetto usb che hai lì per la mia camera? Non trovo il mio.
Lo vedo armeggiare di nuovo con la Reflex e un grosso obiettivo.
Allungo il braccio dal letto e pesco nella tasca dello zaino i cavi che ho portato con me. La piccola usb con cavo annesso mi rimane tra le dita e gliela giro.
– Non tutti nella tua posizione avrebbero scelto di sobbarcarsi un rischio simile.
Penso alla mia posizione, sorrido.
– Sì, forse è così.
Poi va via la luce. Buio. I neon saltano e sento il telefono emettere il suono che avvisa il cavo del caricabatterie sia stato rimosso. Mi alzo dritto sul letto, dalla finestra sento battere una forte pioggia sul vetro.
Primavera 2017
Sono circondato. La mia fidanzata sulle scale, la giornalista seduta davanti a me e un messaggio del commercialista di cui l’anteprima dice “Andrea, ma hai finito di compilare il business pl…”
Mi tiro indietro sulla sedia.
– Mi aiuti con le buste? Non vedi che sono piena? Ho la macchina in doppia fila.
Non si cura della giornalista. Ruota tutto intorno a lei. Alla fine, penso, è come me. Per questo non andremo lontano.
Mi alzo dalla sedia e lascio un biglietto da visita sul tavolo.
– Prendilo pure, ci aggiorniamo per l’articolo. Se hai bisogno di altre informazioni scrivimi o chiamami.
La mia fidanzata, di cui il nome non è necessario qui, fissa prima lei poi me. La giornalista si alza, mi sorride e io faccio strada a entrambe. La giornalista sorride anche a lei e si allontana.
– Se hai bisogno di altre informazioni scrivimi o chiamami…
– Ma quanto sei stronzo?
– Stronzo?
– Che pensi non lo sappia?
– Ma cosa?
– Quel tono, quei tuoi toni. Andrea, te lo dico, non fare cazzate.
Penso al business plan, devo compilare dieci pagine di dati.
– Non mi ascolti?
– Sì sì, ti ascolto.
Dieci pagine di dati con tutto ciò che prevedo per l’azienda. Costi, ammortamenti, nuove aperture, staff.
– È più forte di te, eh? Proprio non resisti. Sei così ragazzino da non resistere mai.
Guardo le sue buste, ora metà sono nelle mie mani, guardo il suo profilo e le lunghe gambe affusolate.
Poi il commercialista. Nico. Un terminator dell’analisi finanziaria che ho incontrato grazie al padre di lei, proprio di lei, sì. Una manna dal cielo, un segno che sperare in qualcosa di buono è ancora possibile. Nico sa tutto. E se non sa studia alla velocità della luce e per gli anni a venire sarà il miracolo capace di risolvere ogni rogna.
Confido in Nico.
– Andrea?!
– Ehh, ehh. Dimmi. Dimmi.
– Scusa?
– Dimmi, ho capito, ti ascolto.
– Ma come mi rispondi? Ti pare, mi rispondi così?
– Ma così come? Io stavo lavorando eh.
– Con quella bionda rifatta?
– Non è rifatta.
– Lo vedi come sei? Le hai fatto i raggi x.
– Mi ha intervistato. E poi tu non vuoi rifarti le tette e il naso?
– Ci hai fatto il cretino?
L’aria fuori la gelateria è tiepida, guardo l’orologio. Posso ancora sperare di chiamare Nico.
– No, non ci ho fatto il cretino. Ora devo fare alcune telefonate, ci vediamo domani?
– Domani?
Mi vibra il telefono, dallo schermo vedo il messaggio da un numero che non conosco. Sblocco con il pin e apro il messaggio.
Numero sconosciuto: “Non ti ho chiesto nulla su qualche foto antica, qualche testimonianza passata”. La giornalista.
– Andrea. – Mi strattona
– Sì, scusa. Domani, questa sera devo finire il lavoro con Nico per mandarlo in Corea.
– Bah.
Le do un bacio sulle labbra.
– Ora vado.
Carico le buste di lei sulla macchina e mi allontano, mentre rispondo alla giornalista che manderò qualche immagine in serata via mail.
La giornalista risponde subito:
“E non mi hai offerto il gelato ;)”
Mi chiedo perché, spesso, le donne preferiscano inserirsi in mezzo a una relazione pre esistente invece di trovare un uomo libero. Sorrido.
Rispondo: “Beh, oltre che Amministratore Delegato dell’azienda, faccio anche consegne a domicilio”.
Risponde ridendo,
– Vivo a San Lorenzo, quando vuoi allora finiamo l’intervista… magari davanti al tuo gelato ;)”
Rientro in gelateria. C’è poca gente. Una signora parla con il cassiere che mi indica.
Io cerco i defilarmi. Sono due mesi che aspettano il mio business plan.
Ma lei si avvicina. Ha l’aria arrabbiata. Il viso tirato in una smorfia grinzosa che le rende la pelle una scorza butterata di fossette, il naso arricciato.
– Andrea Fassi?
– Sì, salve!
– Non ci posso credere che ha venduto l’azienda a dei cinesi.
– Scusi?
– Fassi non è più Fassi, vero? È cinese ora, giusto? – La stronza lo dice ad alta voce per farsi sentire.
Non comprendo fino in fondo il concetto di identità che vuole condividermi. La guardo. Imparerò con il tempo che c’è una precisa fisionomia umana che recriminerà per sempre la collaborazione coreana.
– Signora, le sembro cinese?
Resta ferma. Vicino a lei si sono avvicinate due coppie.
– Come cinese? – dice una ragazza.
La signora faccia di buccia riprende fiato. Il fiato che forse non usa per condividere la vita con qualcuno. Fiato acido di rabbia.
– La gelateria è cinese ormai e si vede, il gelato non è più quello di una volta.
Ecco. Questo sarà il mantra della categoria di cui sopra, umani soli che non hanno rapporti sessuali se non con sé stessi, una forte crisi di identità a causa di genitori iper protettivi e un mal gestito concetto di identità e appartenenza veicolato da una rabbia inconsapevole.
Tossisco. Questo, però, non so ancora gestirlo, mi servirà tempo. Vorrei spiegarle che io qui ci sto per caso, al massimo per un desiderio violento dentro di me, di sopravvivenza. Questo so, per adesso. Che è tutto un magma psicologico che dovrebbero sedersi in circolo con tutti i curiosi con la mia psicoterapeuta pronta a spiegargli tutto, come ai bambini.
– Collaboriamo con una multinazionale coreana dal 2002, gestisce i nostri franchising a Seoul. Sei mesi fa la mia famiglia ha deciso di vendere le quote societarie per sviluppare il marchio nel mondo; le mura e la gestione sono nostre, grazie al fatto che ci sia io nulla cambia.
Lo dico come un robot, ho imparato la frase e senza pause la sparo, non provo niente. Ci esco pure da eroe così, forse.
Vibra il telefono.
– Ceniamo insieme, devo parlarti. – È la mia fidanzata. Penso al gelato a San Lorenzo.
– Coreani!? Non cinesi?
Altra caratteristica razzista latente che ho riscontrato da quel tempo a oggi è il mischiare cinesi e coreani e a volte giapponesi. Come fossero un unico popolo, cancellando con un colpo di spugna secoli di storie. O anche, l’immediato collegamento con Esquilino Chinatown e Fassi cinese.
Però mi illumino. Gli occhi verdi con queste macchioline marroni restano il contorno di una pupilla piccola come uno spillo che, come un’aquila, mira la preda, la mia pupilla coglie il senso.
Questo è il Palazzo del Freddo. Una piazza del popolo, un luogo in cui le regole commerciali vanno in tilt. In cui affettività ed emotività si intrecciano nelle viscere degli avventori sciogliendosi come gelato al sole. Questa donna, come centinaia di altre, hanno poche certezze e tra queste c’è il gelato con la panna qui e temono che qualcuno possa distruggere questa certezza, cancellandola. Come si dice, “Tutto finisce…gelato con panna Fassi, no”.
Capisco in un istante come orientare il business plan. Sblocco il telefono. E mentre mi allontano grido:
– Non cambierà nulla finché ci sono io, sono qui per evitare il peggio. Non avrei mai voluto vendere nulla e sono qui per riempire questo spazio, per i romani, come fece il mio bisnonno. Poi penso, “e per riempire me”.
Vedo la buccia di arancio distendersi e diventare liscia, la signora l’ho conquistata. Le due coppie sorridono, tranquille. Chiamo Nico scrollando la rubrica. Risponde al secondo squillo.
– Pronto Nico, sono Andrea. Sì, il business plan. Ora ti spiego.