
Clelia Marchi e la vita su un lenzuolo
C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Nei capitoli precedenti:
Nono capitolo – Odessa
Dal bar sul porto di Odessa, dove siamo in sosta, si vedono nel mare enormi piloni di cemento. Sono a forma di X, piantati immobili a una manciata di chilometri dalla spiaggia. Formano il corrispettivo acqueo di una trincea, un muro marino per evitare che navi russe possano attraccare o che sistemi sottomarini, come missili ad esempio, possano colpire la costa.
Bevo un caffè americano.
Odessa splende come una donna reduce da una storia d’amore che le ha strappato il sorriso per sempre. Possiede, tra le strade pallide, quel riverbero di bellezza frammentata che la rende impalpabile; è una sirena vinta, pronta a un nuovo amore che giungerà in soccorso, sarà riparatorio ma lei non è quella di prima. È bella come una piccola perla.
Me ne innamoro. Rimarrà sempre dentro di me, anche quando sarò tornato in Italia. Odessa sedimenterà il suo fascino per via dei colori contrastanti di un porto gonfio di addii, per le sue opacità post sovietiche tra il grigio degli edifici e l’eleganza ottocentesca, per l’imprescindibilità della sua presenza sul territorio come snodo commerciale sul Mar Nero e la profonda potenza evocativa delle cattedrali. La tristezza che soffia tra i lunghi colonnati e i suoi luoghi inaccessibili è ancora con me oggi. Ma non ho tempo. È una città importante dai tempi dell’Unione Sovietica, crocevia di traffici commerciali e criminalità, ma io me ne andrò presto perché la guerra non è qui, adesso.
La città vive la guerra dopo un anno come un ricordo indelebile che, a tratti, ancora colpisce.
Io ho iniziato a parlare meno da quando siamo arrivati qui. Accettare la guerra, vederla, capire che è il riflesso di ciò che provo, mi toglie pian piano le parole.
Cerco di concentrarmi su pensieri più leggeri, la distanza che ci separa dal fronte è di poche centinaia di chilometri e non voglio arrivare troppo appesantito.
Già tutta intorno la guerra si percepisce più di prima, oltre i piloni, abbiamo incontrato diversi check-point; l’inasprirsi della presenza militare è un chiaro segno di pericolo. All’ultimo controllo, infatti, grossi camion militari sbarravano le strade uniti da filo spinato, circondati da soldati armati. Erano ragazzi, svogliati quanto spaventati. Ci hanno chiesto i documenti e, in silenzio, hanno guardato dentro al camper. Poi si sono parlati. Poi ci hanno fatto passare. Così ogni check-point.
Siamo a pochi metri dalla prima, vera tappa per cui siamo qui: l’ospedale pediatrico di Odessa.
Sfoglio il mio taccuino. Una pagina intera divide gli appunti, confusi. Scrivo tutto quello che vedo. Cerco i fili profondi della mia vita, sepolti come cavi immersi nel mare dove tutto tace, dietro piloni costruiti dentro di me in una vita intera. Chissà a Roma la gelateria come procede senza di me.
Qui fuori, in questa città, si convive con la percezione di essere in guerra. Le persone ignorano ormai il pericolo, consapevoli solo che c’è. Facendo di tutto perché sembri non ci sia. È in quella presenza della guerra che germoglia il disagio, la paura di accettarla, un po’ come vivo io.
Andiamo via dal caffè e in pochi minuti siamo all’ospedale pediatrico di Odessa.
I bambini non li incontro. Non ho paura di niente, ormai, se non in funzione di Amelia; ma mi basterebbe vedere un solo bambino vittima della guerra per esondare la diga costruita in trentanove anni rischiando di arruolarmi.
Ci raduniamo nel piazzale vicino all’entrata. Un ragazzo italiano, madrelingua ucraino, ci parla da un ballatoio. Traduce quanto il direttore dell’ospedale, un ometto basso e paonazzo accanto a lui, dice:
– Per prima cosa ricordatevi, vi prego, niente uso del cellulare e geolocalizzazione disattivata.
Poi prende fiato.
– Niente geolocalizzazione. Spero sia chiaro.
Percepisco una venatura di paura anche nella voce dell’interprete oltre che in quella del direttore che lo anticipa. Con maggiore calma, continua:
– Geolocalizzarvi in tanti attiva l’attenzione del nemico. Potrebbe capitare che droni russi reputino l’assembramento anomalo e scovino il generatore.
L’ interprete fa una pausa. Il direttore parla. L’interprete fa un lungo respiro:
– Distruggerebbero il generatore rischiando, inoltre, di colpire l’ospedale.
Resto fermo in mezzo al gruppo di persone che assiste all’inaugurazione. Il direttore sorride ora, ha il volto rosso, parla con le mani sul cuore e poi indica l’edificio.
E prontamente l’interprete:
– Non posso credere che siate qui. Avete tolto tempo alle vostre preziose vite per venire ad aiutarci. Con i vostri mezzi, i vostri soldi. Grazie. Il generatore che avete portato permetterà a questa struttura di rimanere attiva, anche in caso di attacco russo alla centrale elettrica.
Si blocca, parla il direttore e poi di nuovo lui:
– So che la vostra direzione è Mykolaiv, avete coraggio, l’Ucraina vi è amica ora e sempre.
Vorrei applaudire, ma non faccio in tempo.
In quel momento, dalla folla, una ragazza fa un passo in avanti ed estrae un telefono e lo punta sugli oratori e sull’ospedale.
Il direttore si blocca, inizia a gridare in ucraino. Non è un grido di rimprovero, è rabbia mista a terrore. L’interprete, anche lui stravolto in viso, traduce:
– Leva il telefono. Leva subito il telefono. Via il telefono. Giù il telefono.
Agitano le mani.
Il ragazzo, più giovane del direttore, scavalca con un balzo il muretto che divide loro da noi. corre verso la donna. Lei mi sembra abbia l’aria mortificata. La guardo, forse è imbarazzata, ha ritratto il telefono; ma lui la raggiunge le prende la mano e le stringe il polso:
– Cancella. Tutto. Non devono girare foto di questo momento.
Le strattona il braccio.
Io e gli altri indietreggiamo, il ragazzo ha il volto sformato dalla rabbia e dal terrore, rimaniamo tutti in silenzio, indecisi se intervenire o meno.
Fuori dal coffee shop di Amsterdam l’aria è fresca. Piccole gocce di sudore freddo mi colano sulla schiena freddandomi la pelle. Mi giro, il coffee è sfocato, mi tocco gli occhiali, all’interno delle grandi finestre che danno sulla strada il locale è pieno di acqua. Decine di boccali galleggiano, perdono strisce giallo oro di birra nel chiarore dell’acqua, cime di erba si sfilacciano, simili ad alghe, fluttuano intorno a uomini e donne con il volto da pesce che azzannano piccole pietruzze ricoperte di fritto. Mi gratto la faccia, strizzo gli occhi, il sudore è ovunque, sento la maglia bagnata, riapro gli occhi ma loro sono ancora lì. Ho la bocca arida, come se avessi masticato l’interno di una felpa. Intorno tutta la strada si fa liquida, sembra sciogliersi come in un quadro di Dalì.
Sento caldo, il fresco di Amsterdam passa, tutto si scioglie, voglio spogliarmi, voglio tuffarmi in questo fiume grigio che ha iniziato a scorrermi intorno, lo vedo fluire sinuoso. Avanzo, mi tuffo, mi gira la testa ma voglio immergermi, salto; due luci sono a pochi metri da me, mi sembra mi attraversino.
Un mano di colpo mi strattona, tira felpa e pelle e a me sembra di svegliarmi da un sonno profondo per via del dolore. Per un istante sento un clacson suonare a lungo, tanto forte che mi spaventa e mi sembra di vedere una macchina che mi sfiora, sento l’aria muoversi e freddarmi il sudore sulla fronte.
Una delle persone in viaggio con me mi tira sul marciapiede.
– Cazzo fai. – Dice.
Io ciondolo con le mani sulle ginocchia.
Ma la testa mi gira, pulsa, vorrei mi esplodesse il cervello sulla faccia di tutti loro che sono con me. Sale di nuovo calore, le tre persone ora hanno gli occhi lunghi che gli arrivano alle tempie, le facce con la bocca grande e ripetono:
– Sei solo.
– Sei solo.
– Sbaglierai.
– Sei solo.
– Morirai solo.
– La vita la consumerai nei rimpianti.
Si muovono tutti e tre a scatti, mi ruotano intorno, io non riesco a liberarmene, ho le mani sul viso, qualcuno mi chiama. Il telefono squilla.
I tre con me si muovono in loop, girano lenti. Ognuno ripete:
– Sei solo.
– Sei solo.
– Sbaglierai.
– Sei solo.
– Morirai solo.
– La vita la consumerai nei rimpianti.
Prendo l’iPhone, lo sento sulla mano ma lo vedo squagliarsi, sciogliersi e colare a terra in una macchia nera con un volto di donna. Il suono arriva dalla mia mano.
– Sei solo.
– Sei solo.
– Sbaglierai.
– Sei solo.
– Morirai solo.
– La vita la consumerai nei rimpianti.
Avvicino la mano all’orecchio.
– Andrea. Andrea!
Non riesco a rispondere. La bocca è serrata, solo il movimento mi fa venire su conati di vomito.
– Andrea sono io, ma cosa hai fatto?
Il cielo, ora, è verde. Il telefono continua a squillare.
– Andrea, stai calmo. Ascoltami.
– Perché mi avete fatto questo? – Dico. – Dico a voi che mi avete messo al mondo, a tutti voi, per quale motivo?
– Andrea. Amore. Stai calmo. Mi hanno chiamato i tuoi amici. Stai male, ma passa amore mio. Devi calmarti, io sono qui.
– Ma tu che vuoi? Tu che cazzo vuoi? Sono anni che vivo nell’ombra e tu sei una su mille.
Il cielo ora è viola. Un conato mi sale su e poi scende, gli alberi mi salutano con i rami secchi e bitorzoluti.
– Andrea. Io ci ho provato. Ci sto provando. Ti prego. Ora, calmati.
– Calmo un cazzo. Calmo un cazzo. Stronza che pure tu fai finta di vedermi ma di me non te ne frega un cazzo. Come a tutti, tutti.
Gli alberi si avvicinano si piegano scricchiolando:
– Sei solo.
– Sei solo.
– Sbaglierai.
– Sei solo.
– Morirai solo.
– La vita la consumerai nei rimpianti.
Metto l’altra mano sull’orecchio opposto, stringo le dita dentro i capelli.
– Andrea mi senti?
Ora, per terra, c’è una voragine enorme. Non sento più nulla, c’è un mare nero con schiuma bianca, dentro svettano grossi blocchi di cemento, dietro di essi, appare di nuovo il volto nero di donna che sbiadisce come una dedica sulla battigia.
Io la voglio guardare, la voglio vedere, sembra nuotare, è appena visibile, ha la coda nera lucente, i capelli come l’universo. La conosco da sempre, da vite intere, ma non riesco a raggiungerla. Svanisce dietro i blocchi di cemento.
Il cerchio si richiude, con acqua nera e piloni di cemento al seguito. Chiudo gli occhi, li strizzo così forte da far perdere sensibilità alle palpebre. Poi la testa mi sbatte su una superficie dura con un suono secco e tutto diventa buio.
Mi abbandono. Il telefono è silenzioso, le voci svaniscono e tutto è immobile. Finalmente.

C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Le carte della settimana sono: Forza, Papessa e Bateleur.
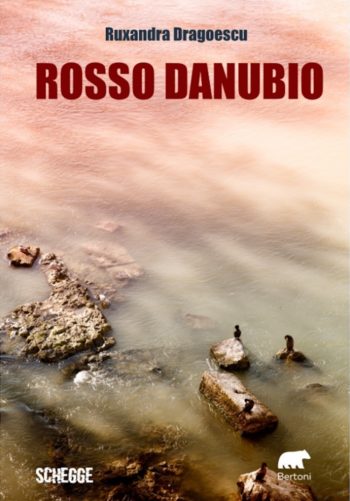
“Ho scelto un eroe collettivo. Ho una mia ossessione: capire, nella vita, come la Grande Storia assorbe la Piccola Storia, come vengono schiacciate le persone comuni dalle decisioni dei pochi”.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – [email protected]
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare