
Clelia Marchi e la vita su un lenzuolo
C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Nei capitoli precedenti:
Capitolo 4: Terra di nessuno
– Ma non devi andare a lavorare? Scusa eh, non voglio sembrare invadente, non ti conosco. Ma mi avevi detto di una riunione ieri sera, no?
Ho dormito fuori, non sono riuscito a mandare via il segno del cuscino sulla guancia. Ho provato con acqua fredda, schiaffi, pressione. Niente. Mi ha svegliato questa ragazza, da cui mi sono fermato la notte. Clara credo, o Claudia o Chiara.
Tra giorni fa era seduta in treno davanti a me con il figlio vicino, il bambino avrà avuto quattro anni. Il piccolo teneva in mano Capitan America. Io preferisco Iron Man.
Così gliel’ho detto e lui ha riso e ha detto che Capitan America è più forte, abbiamo riso e la mamma ha capito che amo i bambini, così ho giocato con lui in maniera spontanea, vera.
Eppure una goccia melmosa si muoveva dentro di me, pronta a ricordarmi che fosse tutto un piano architettato per arrivare a sua mamma, la goccia via via andava infiltrandosi nella mia spontaneità dopo una lunga caduta nel vuoto, facendomi sentire fasullo. È sempre così per me.
Questa mattina lei era già in piedi, avvolta in un asciugamano bianco da cui intravedevo uscire le gambe lunghe e lisce.
– Mi sa che ti ho fatto fare tardi eh? – Mi ha sorriso e, aprendo l’asciugamano con un movimento morbido, ha ondeggiato il corpo nudo.
Ricordo che ho guardato l’ora e, fin lì, ero ancora in tempo.
La gelateria è ancora chiusa, perché sono in ritardo. La strada, all’ombra, è piena di gente che raggiunge il tram. Davanti alla piccola porta laterale, quella con scritto ‘Casa fondata nel 1880’, un uomo contornato di lattine, cartacce, cibo, vomita.
Anche a me viene da vomitare. Avrei dovuto essere qui un’ora fa per una breve riunione organizzativa e poi per aprire, ho solo io le chiavi.
I ragazzi non sanno nulla di come andrà da adesso in poi la gestione, non sanno quale sarà il futuro dell’azienda, non sanno che ne sarà del loro futuro e io non ho dato importanza a questa riunione che ormai è saltata e la gelateria dovrebbe già essere aperta.
Mi vedo riflesso sull’ultima porta della gelateria.
Ho la faccia di chi si è svegliato da mezz’ ora.
Il clochard mi guarda, io salto tra la sua immondizia.
Per alcuni giorni, la gelateria non ha avuto un vero e proprio responsabile. Un periodo di tempo in cui il posto vacante rendeva il ‘Nautilus’ un grosso contenitore di sogni e competenza, senza Nemo. Un luogo di nessuno, abbandonato a una proprietà lontana di cui nessuno sa gli obiettivi, con un capitano entrante tronfio e gaudente per merito delle uniche due cose che gli danno sicurezza al momento: il modo in cui è riuscito a portarsi a casa una donna, come sempre, e il chiamarsi Fassi. Metto le mani in tasca, sento uno dei miei biglietti da visita appiccicato alle chiavi della porta di servizio della gelateria.
Tiro fuori tutto, chiavi biglietto, monetine e il biglietto da visita mi cade a terra, poco vicino al vomito del clochard.
‘Andrea Fassi, C.E.O. Chief Executive Officier.’
La prima cosa che ho pensato è stata farmi il biglietto da visita. Penso al film American Psycho. La scena in cui Christian Bale e i suoi compagni si scambiano i reciproci biglietti da visita, sentendone texture e finitura. Una tensione che ancora sento in corpo se ci penso. Guardo il vomito, penso il mio biglietto possa restare lì, ne ho pagati mille trenta euro.
Il clochard alza gli occhi, mi guarda:
– Stai bene?
L’uomo, raggomitolato sul marmo dell’entrata di servizio, si pulisce la bocca e mi guarda come se avesse davanti un fantasma. Io spalanco gli occhi.
Lo scavalco come si scavalcano delle pozzanghere troppo profonde, lascio a terra il biglietto ormai raggiunto dal vomito e infilo le chiavi nella serratura.
Tre ragazzi in divisa sono dietro al banco, in piedi, in attesa. Il cassiere è seduto con le braccia conserte e mi guarda, guarda la camicia. È raro ne indossi, uso sempre magliette. Poi mi guardo, è per metà fuori dai pantaloni e ha del trucco sul lato destro.
La metto in ordine spingendo la parte macchiata dentro i pantaloni.
Le luci sono accese, il gelato distribuito dentro al bancone e i Sanpietrini formano solide piramidi di semifreddo.
Scusate, vorrei dire. Ma forse è debole. Penso al ritardo, alla riunione saltata, alle loro aspettative su di me e alle loro e paure.
La causa è poco più alta di me, i capelli castani, gli occhi castani, il naso piccolo e dritto, le mani morbide, le labbra piene, gli zigomi morbidi, un bel sedere e ha un figlio. Non mi interessa che abbia un figlio, perché è un pezzo di figa raro. Sarei squallido se lo gridassi, lo dirò a Luca, il mio migliore amico. Ma relego lo squallore nel sicuro confine del pensiero, resto invece impeccabile nella dialettica.
Mentre attraverso la sala, penso a come non sentirmi inadeguato aggiustandomi il colletto della camicia. Sorrido, passo svelto.
– Scusate, ragazzi, una riunione improvvisa con la Corea.
Mi salutano tutti, ma nessuno accenna una risposta alla mia giustificazione. Ho la faccia impastata dalla notte, gli occhi gonfi.
In queste settimane in cui ho formalizzato il mio accordo con l’Haitai, la gelateria andava avanti da sé, tutto in mano al personale.
Cerco la chiave per aprire la porta d’ingresso, mi perdo tra quelle del magazzino, dell’ufficio, del magazzino sopra al bagno.
– È quella piccola e rotonda. – Matteo dice, con voce squillante.
La prima cosa da fare è rendere indipendente apertura e chiusura della gelateria, non possono dipendere da me. Sia per una scopata, sia per rendere l’azienda solida e allontanarla da un semplice concetto familiare.
Penso al profumo di arancia del balsamo di Clara, o Chiara e alle sbiadite lentiggini intorno al suo naso.
Estraggo la chiave dal mazzo, piccola, di ferro suggerita da Matteo. Penso alla chiave d’oro con le iniziali del mio bisnonno Giovanni. Un regalo di mia zia Daniela subito dopo la firma del mio contratto da Amministratore Delegato.
– Ti porterà fortuna. – Mi ha detto.
La chiave ora è al sicuro in una cassetta di sicurezza in banca.
Oltre che essere d’oro, ha un piccolo rubino rosso nel mezzo.
Fu la chiave che usò il mio bisnonno una sola volta, il primo giorno di apertura del Palazzo del Freddo nel maggio del 1928. Aprì la gelateria con quella chiave al pubblico, per poi custodirla e lasciarla in eredità. Fino a me.
Guardo quella che ho ora in mano, in ferro, per la mia prima volta. Un po’ rudimentale, priva di onore. La infilo nella serratura della prima grande porta d’ingresso con i vetri spessi e gli infissi resistenti e giro.
Stringo la chiave del camper pronto a mettere in moto, perché abboccherà il sallucchione. La chiave è rivestita di un grosso guscio di plastica da cui pende un laccio di stoffa e una bandiera ucraina con scritto ‘Stop the war now’. Ho una goccia di sudore sulla fronte. La luce artificiale degli uffici della frontiera ungherese illumina lo scuro degli occhi concentrati di Mariangela. Il poliziotto non ha ancora compreso se il camper sia omologato per sette o per nove. Sfoglia il libretto, poi lo chiude.
Guarda la strada, mi restituisce il libretto del camper e mi fa cenno di andare.
È andata. Cazzo.
Vorrei dirgli – ciao sallucchiò, limortacci tua, li mortacci vostra.
Mariangela si lascia andare sul sedile, dietro tirano un sospiro di sollievo, inconsapevoli della bugia che ho propinato al poliziotto.
– Beh, il nostro imprenditore eh!?!
Mariangela mi guarda e ride.
– Eh.
– Beh, ci hai fatto passare.
– Mah, non è stato difficile e poi, lo sai, lo avrei atterrato con un paio di ganci ben assestati.
– Fassi Fassi.
Ridiamo.
Superiamo a bassa velocità la barriera aperta dalla polizia ungherese. Ha smesso di piovere e il terreno è fangoso, sento il camper slittare.
– Questa, di mezzo, si chiama terra di nessuno.
Guardo Mariangela senza capire.
– C’è un pezzo tra le frontiere che serve come spazio di nessuno, non gestito, né da una parte né dall’altra. Serve come cuscinetto.
– A Gaza, ci sono due terre di nessuno, doppio cuscinetto e molto altro. La barriera con Israele ha recinzioni di filo, pali, varie zone cuscinetto o terre di nessuno, muri in acciaio. Fa impressione. Qui, alla fine, sono solo un bel po’ stronzi.
A inserirsi nel discorso è Raffaella. È giovane e le brillano gli occhi di intelligenza. Lavora spesso all’estero come mediatrice culturale e conosce in maniera approfondita il conflitto tra israeliani e palestinesi. Quando parla, oltre a brillarle gli occhi, le brilla il viso per le intenzioni che la muovono a fare il lavoro che fa. Desiderio puro di concretizzare ciò in cui crede.
– Madonna. – Tiro indietro la testa.
Guido tenendo il camper in seconda.
– Questa ‘No man’s land’ serve per sicurezza. Per questo l’Europa è il futuro, perché non esistono zone di nessuno, la vita fluisce tra gli stati, le persone si mischiano.
La penso come Raffaella. Guardo la zona di nessuno che ho intorno. È fango e terra e un paio di capannoni. Non c’è niente da vedere. Il buio la rende ancor più sinistra. Guardo dallo specchietto retrovisore, vedo nei miei occhi la terra di nessuno che c’è dentro di me. È il luogo percorso da quella goccia melmosa sempre presente. Penso però che finalmente si stia assottigliando, con un po’ di verità e consapevolezza in più. Questo viaggio spero mi aiuti.
– È triste.
– Sì, Andre, lo è.
Incontriamo la seconda frontiera, quella ucraina, dopo meno di un chilometro. C’è un camion verde scuro militare, qualche giovane soldato schierato e nessuna macchina che deve attraversare. Il van con gli altri del nostro gruppo ha già superato il controllo documenti, loro hanno meno aiuti di noi da far controllare.
Una donna bionda, alta, con gli occhi azzurri si avvicina. In tenuta militare, imbraccia un grosso fucile puntato a terra. Accanto a lei un militare più basso, rotondo e paonazzo con dei piccoli baffi biondo cenere saltella dietro a lei.
– Stop here. I need the documents and all your passports.
Mostro i documenti del camper, i passaporti e anche la lista di aiuti presenti a bordo. La donna guarda il camper, vedo che legge la scritta ‘Stop the war now’ e ‘Humanitarian aid’. Guarda la torretta con le telecamere e si aggiusta il cappello verde con la piccola bandiera ucraina ricamata.
L’uomo, che finora si è limitato ad annuire guardando la donna, si tira su con le spalle, guarda il mezzo in tutta la sua lunghezza e ci fa cenno di scendere, tutti.
Poi indica me.
– Come with me.
Non ho mai superato un confine di un paese in guerra e non conosco la prassi. Guardo Mariangela, anche il militare la guarda.
– Vengo con te, meglio.
Seguiamo il militare dietro la torretta di sorveglianza, il fango mi si appiccica agli stivali, sento freddo ora.
Dietro alla parte frontale dei controlli c’è un ufficio, saliamo e tutto intorno c’è il bosco scuro. Il bosco che si estende attraverso i confini ungheresi, nella terra di nessuno e poi in Ucraina, si estende senza interruzioni, secondo natura.
Il militare si tocca la cinta, gli traballa la pistola nera sul lato destro, tira fuori una chiave e apre una porta consumata dal vetro sottile e ci fa cenno di entrare. Entro prima di Mariangela, in quel momento, alle spalle, sento passi avvicinarsi veloci e gridare:
– Stop! Raise your hands.

C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Le carte della settimana sono: Forza, Papessa e Bateleur.
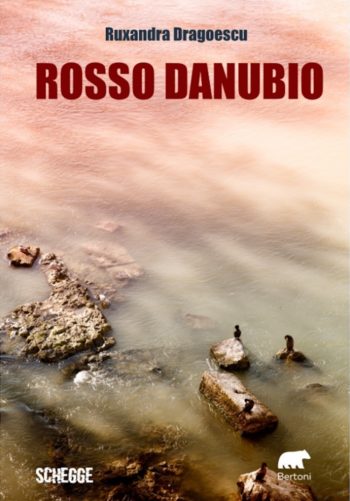
“Ho scelto un eroe collettivo. Ho una mia ossessione: capire, nella vita, come la Grande Storia assorbe la Piccola Storia, come vengono schiacciate le persone comuni dalle decisioni dei pochi”.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – [email protected]
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare