
Clelia Marchi e la vita su un lenzuolo
C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Papille, il seguitissimo critico gastronomico fuori dagli schemi, amato dal popolo e temuto dai più grandi chef, perde l’uso della lingua e del gusto per la vendetta di uno chef stellato.
Puntate precedenti
Capitolo 1 – Panace di Mantegazza
Capitolo 4 – Mignon vegani, alici, cacao e melanzana
Capitolo 6 – Pomodoro Ciettaicale
Capitolo 9 – Zuppa di pipistrello
Capitolo 10
Tramezzino pollo e insalata all’obitorio
I passi dentro l’obitorio rendono i piedi pesanti. Papille incede. Spera i piedi lo zavorrino fino a lasciarlo sprofondare in una voragine nel mezzo della sala, impedendogli di andare oltre. Come se non fosse successo davvero. Riconoscere di nuovo il corpo serve solo a non poter più mentire a se stesso. Ma è la prassi. La legge degli uomini che si erge cruda sopra gli uomini.
I luoghi dove si muore vivono densi di una corrente fredda, anche d’estate. È un soffio sottile che vibra dentro chi li attraversa perché ha perso qualcuno. Papille lo sente, un brivido gli accarezza il collo.
Alza prima un piede e poi l’altro, poi uno, poi l’altro. È molto giovane, vestito di un’eleganza che non capisce. Proprio come accade con la morte a quell’età.
La sala d’attesa dell’obitorio civico di Milano è un ospedale in cui non si combatte più.
Le mura sono bianche, opacizzate di grigio dal tempo. C’è una boiserie verde melma da metà muro fino a terra. Papille nota di sfuggita la guardiola con dentro un uomo, è concentrato su un grosso cartello: Sala Mortuaria.
La stessa mano che lo stringeva la sera in cui trovarono il corpo in strada, ora lo tira verso l’infermiere dalle rughe pendule e gli occhi annoiati. L’uomo accenna un sorriso stanco da dentro il gabbiotto. Lascia la sigaretta nel posacenere. Un pezzo di cenere cade dritto a terra mentre una parte grigia sottile svolazza lenta verso il pavimento. Prende il tramezzino mezzo smozzicato e da un morso. Mastica aprendo la bocca. Tra i denti storti si annidano pezzetti bianchi di pollo. Ai lati della bocca, della salsa densa colora il rosa delle labbra di un giallo ambrato. Quando il giovane Papille e la donna insieme a lui sono abbastanza vicini, l’infermiere posa il tramezzino, si pulisce l’unto con la manica, deglutisce e chiede ai due le generalità.
– Ah, il signor Papille. Quello morto dietro al ristorante dove lavorava. Stanza quattro letto dodici. Il figlio deve solo riconfermare il riconoscimento già effettuato.
Papille sente la mano che stringe la sua inumidirsi. Come se reputasse una minaccia l’abitudine alla morte dell’infermiere.
Un radiolina dentro la guardiola passa un classico di Mango:
Nonostante tu sia, la mia rondine andata via, sei il mio volo a metà, sei il mio passo nel vuoto… l’uomo abbassa il volume.
Papille non ha distolto un istante lo sguardo dalla grande porta a vetri che divide l’ingresso dalla sala mortuaria.
Forse un addio o forse no, ma tu che ne sai dei sogni… La voce di Mango si allontana. Lascia in coda un’eco di tristezza che Papille coglie ma non sa trattenere.
La mano lo trascina. Cammina con il cuore che inizia a scalpitare. La mano che lo stringe non è più umida. Ora la pelle è soffice e levigata. I passi sono ancora pesanti. Papille però non stringe la mano a sua volta. Guarda i numeri delle stanze sparse per il corridoio e si limita a una presa molle. A scandire il conteggio dalla stanza uno alla stanza quattro è il rimbombare dei passi sul pavimento di linoleum. Forti, sordi nel silenzio dell’obitorio.
Uno. Due. Tre. Porta numero quattro. Entrano. In fila a destra e a sinistra all’interno della stanza il giovane Papille conta otto letti e otto letti. Sedici in tutto. Più due sul muro lontano. Diciotto.
La numerazione parte da sinistra verso destra. I letti sono barelle con sopra le sagome di corpi levigate da lenzuoli bianchi. Escono fuori solo i piedi. Il numero uno ha i piedi pelosi e larghi, un uomo. Il due ha piedi sottili, di donna. Quelli del tre sono vecchi che quasi si vedono le ossa, sono di una donna. Il quattro ha piedi lunghi e affusolati dalle unghie curate, giovani. Il cinque e anche il sei sono piedi molto grassi, rotondi come pagnotte, di uomini. Il sette ha piedi bruttissimi, pensa Papille, storti e con bozzi sulle dita, sembrano di una donna. La otto è sempre una donna, sono piedi piccoli dalla pelle chiara.
Il muro di sinistra finisce. Papille è in mezzo alla stanza, sul muro nel fondo ci sono altre due barelle. I piedi del nove sono di un uomo, rossastri e lentigginosi, il dieci di una donna molto magra, ha le dita lunghe e le unghie piccole.
Respira. L’undici all’inizio del muro di destra sul lato opposto dell’entrata è di una donna. I piedi sono curati, senza smalto, sottili come la caviglia che si intravede.
Dodici.
Papille si avvicina. I piedi ancora pesanti, l’aria intorno gli sembra più fredda. La mano che lo accompagna si bagna. Papille vorrebbe ritrarla, ma non lo fa. Mantiene la presa blanda.
Riconosce subito i piedi di suo padre, per i nei e per la forma. Sul cartellino appeso per una cordicella c’è scritto “Ermanno Papille”. Andava spesso in giro scalzo per casa ricorda. Il lenzuolo accompagna la sagoma del corpo.
Le ginocchia ossute creano un’onda che si infrange sulle cosce magre poi fin su al rigonfiamento della pancia, non più piatta come quando Papille era piccolo. Le spalle non troppo larghe se le ricorda gracili. Il lenzuolo continua sul volto delineando bocca e naso. Dalla parte superiore spunta qualche capello.
– Sei pronto? – Dice la donna che tiene per mano Papille.
Con un cenno della testa, Papille annuisce.
Non è pronto a capire adesso quello che comprenderà solo anni dopo. Ossia che la morte sia una sottrazione all’eternità, un gioco della vita per presentarsi al nulla che ne consegue. Come mangiare, capirà poi.
L’infermiere silenzioso aveva seguito a distanza i due. Arriva anche lui alla salma dodici. Si avvicina e scopre il corpo.
Il volto livido del padre ha gli occhi chiusi. Papille non si muove. La barba incolta è brizzolata. Continua a crescere per un riflesso che dura pochi giorni dopo la morte. Il naso ha minuscole venature rossastre e viola e la bocca inizia ad avere il tipico gonfiore che si vede nei film.
Sul collo una grossa cicatrice è cucita perfetta da mani esperte. Troppo tardi per salvargli la vita, vorrebbe dire l’infermiere. Quello è solo il rattoppo che fanno i medici per rendere i morti presentabili.
Gli occhi di Papille riflettono impassibili il volto del padre.
Si ricorda di quando gli cucinava la domenica a cena perché il ristorante dove lavorava era chiuso. Era una festa. Pasta fatta in casa, sugo e uno spicchio d’aglio. Non cucinava mai altro. Solo durante l’inverno, capitava alle volte che il sugo fosse sostituito da un condimento di aglio e olio.
– Non serve esagerare piccolo mio – diceva – l’importante è stare insieme.
È grossa la cicatrice, pensa Papille. Non distoglie lo sguardo ma è come se volesse aprirla e con gli occhi cercare dentro il collo del padre uno spicchio d’anima per riportarlo in vita. Nel punto in cui i lembi di pelle sono uniti dal filo, la carne è violacea. Il viola sfuma in rosso e poi in rosa. Papille conta trentotto punti.
La ferita al collo dell’albanese zampilla sangue che le mani non riescono a contenere. La pelle si apre in una voragine. Sono lembi di pelle irregolari, frastagliati dal segno dei suoi denti. Non è un taglio netto come quello del padre, pensa Papille. Ma da lì, qualsiasi sia il taglio, la vita esce e se ne va comunque.
Dalla porta gli altri due albanesi corrono verso il connazionale. Papille questo non se l’aspettava. Credeva che la loro inettitudine si trasformasse in rabbia cieca nei suoi riguardi. Forse sono fratelli, pensa.
Con la bocca sporca di sangue e gli occhi vitrei raggiunge la porta. Nella corsa prende una piccola agenda dalla scrivania e la infila nel suo zaino. Spera all’interno abbia appuntati numeri utili o informazioni.
Mentre si allontana, ricorda senza un motivo preciso di quando uscì dall’obitorio quel giorno. Giurò a se stesso di non voltarsi. Avrebbe significato dire di nuovo addio al padre e no, non era pronto.
Si guarda indietro. I due albanesi non lo seguono. Corre via lontano dalla casupola, lontano dal campo. Incrocia la donna che aveva rubato un pomodoro.
Lei lo guarda. Nei suoi occhi non c’è un filo di coraggio.
Papille le si avvicina.
– Posso aiutarti, se tu aiuti me. Seguimi.
CONTINUA…

C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Le carte della settimana sono: Forza, Papessa e Bateleur.
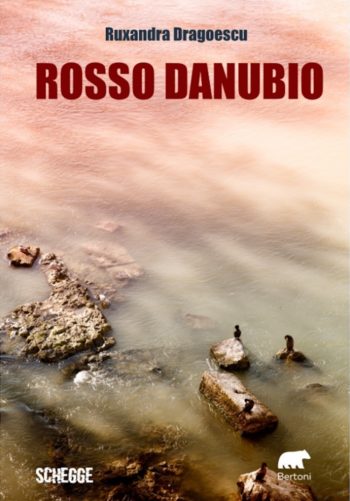
“Ho scelto un eroe collettivo. Ho una mia ossessione: capire, nella vita, come la Grande Storia assorbe la Piccola Storia, come vengono schiacciate le persone comuni dalle decisioni dei pochi”.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – [email protected]
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare