
Clelia Marchi e la vita su un lenzuolo
C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Papille, il seguitissimo critico gastronomico fuori dagli schemi, amato dal popolo e temuto dai più grandi chef, perde l’uso della lingua e del gusto per la vendetta di uno chef stellato.
Puntate precedenti
Capitolo 1 – Panace di Mantegazza
Capitolo 4 – Mignon vegani, alici, cacao e melanzana
Capitolo 6 – Pomodoro Ciettaicale
Capitolo 8
Sardine
Stringersi il più possibile, rimpicciolirsi fino a diventare sottili come sardine sotto vuoto e attendere.
Dentro il camion l’aria circola rarefatta tra i corpi sudati. Quando per via di una buca il rimorchio sobbalza, si creano spazi in cui respirare può essere più facile o quasi impossibile. Gonfiare la cassa toracica di quel poco in più che si riesce, inspirare, espirare sentendo il proprio corpo premere sulle magliette degli altri.
Papille sta dritto immobile stipato nel rimorchio insieme a decine di persone. Pensa che per lui sia solo una questione di resistenza, un periodo della sua vita necessario. Per gli altri sconosciuti là dentro si tratta di sopravvivenza, ogni giorno.
Il rimorchio sobbalza con forza sul terreno dissestato, un soffio di aria circola più veloce. Dopo pochi minuti, il camion si ferma, tutti dentro si accatastano su un lato.
I portelloni si aprono, tutti respirano aria come se saltassero fuori dall’acqua dopo un’immersione. Papille respira calmo, si guarda intorno. Il sole è lontano ma un chiarore bluastro presagisce l’imminente fine della notte. È lo stesso campo di poche ore prima, dove quel Mohoshin ha perso il braccio.
L’albanese con la grossa cicatrice alla guida del camion si avvicina alla terra coltivata, si cala i pantaloni e dando le spalle al gruppo inizia a pisciare con le mani sui fianchi. Un attimo dopo è lì in mezzo agli operai a comandare di iniziare il lavoro.
A Papille non viene spiegato nulla, mentre il gruppo si dirige verso il campo, un ragazzo giovane gli si affianca.
– Come ti chiami? – Chiede. – Io mi chiamo Sumon, io parlo italiano molto bene. Se impari l’italiano veloce veloce non ti fregano. Lo stipendio dico, sei euro al giorno. Pensa che io sto in Italia da solo quattro anni. Tu?
Papille ricambia accennando un sorriso.
– Sei di poche parole? A questi qui, i capi ma che poi capi non sono, gli piace quando parli poco. Guarda qua, questo perché io parlo troppo, è perché sono giovane. Dicono.
Il ragazzo si guarda intorno, l’albanese è avanti di diversi metri, guarda Papille, sul volto si arriccia una smorfia di sicurezza e alza la maglia all’altezza del fianco. Dune rosate si mischiano alla pelle scura. Poi si gira, altre due grosse ferite coperte di croste rossastre tagliano la schiena in obliquo dalla spalla fino ai lombi. Papille deglutisce, allarga gli occhi, fa cenno al ragazzo di ricoprirsi posandogli una mano sulla maglia.
– Questo perché io parlo troppo. Dico troppe cose e qui al campo bisogna stare zitti – ripete.
Papille si sforza, chiede al ragazzo se conosce i capi degli albanesi indicando l’uomo che indirizza il gruppo con un cenno del capo:
– Chi scono i loo capi?
L’albanese si è fermato, allunga il collo muovendo la testa per contare i componenti del gruppo.
– No. Il capo grande è una donna italiana, non si vede mai. Manda due tipi a controllare gli albanesi, di solito parlano là in quella casetta. E tu perché sei qui?
Papille lo osserva, poi guarda la casa di legno. Non risponde. Il ragazzo è un giovane indiano magro, ha le guance scavate i capelli sottili neri, corti. Sul viso non ha ferite, la pelle scura ha qualche pelo sparuto e gli occhi si tuffano nel marrone chiaro separati da un naso a patata, le labbra sottili lasciano intravedere file di denti ambrati.
– Sei qui per lavoro immagino. Lo capisco. Come tutti. Sai, tanti sono come te, non parlano. Poi li senti strillare come pazzi quando si pigliano le prime cinghiate e cadono a terra mentre raccolgono i pomodori e provano a fregarsene uno. C’è chi si è preso anche una pisciata addosso. Oppure quel Mohoshin, la voce è girata, s’è perso un braccio perché ha lavorato male, qui l’incidente sul lavoro è che ti scaricano davanti a un ospedale, a giro nei vari paesi vicini per non dare nell’occhio. Devi stare zitto e non farti vedere, devi essere invisibile.
Papille stringe i denti, l’arcata superiore preme su quella inferiore. Un lieve digrignare risuona al di fuori della bocca. Si ricorda di quel giornalista che, invidioso del suo seguito, un giorno scrisse riferendosi a lui:
– Un vero critico gastronomico deve essere invisibile, silenzioso, non un pagliaccio del web.
Era un trafiletto estrapolato in un lungo articolo sulla presentazione di una guida culinaria. Papille il giornalista lo conosceva, un tipo tutta coerenza e competenza, dalla carnagione olivastra e il desiderio di successo. Lui era invisibile sì, perché criticava per soldi, Papille lo sapeva bene.
– Invisibile – Ripete Sumon.
Papille spalanca le mandibole e mostra il moncone arricciando il naso.
Il giovane fa un balzo all’indietro, poi due, tre fino a scivolare a terra.
Il movimento allerta l’albanese che da lontano si avvicina, si fa spazio nel gruppo e raggiunge Papille, strattona Sumon da terra.
– Cazo fate. Caminate stronzi.
I due non rispondono e proseguono.
Il caldo inizia a farsi sentire già verso le sette del mattino. In tre ore Papille ha raccolto quattrocentocinquanta pomodori, due terzi del numero richiesto in quel lasso di tempo. Ha le mani lisce e levigate striate di graffi dovuti a piccoli sassi nella terra, il sudore goccia sul petto e negli occhi arrossati. Alza la testa, nessuno indossa i guanti o ha delle forbici per staccare i pomodori senza ferirsi o rovinare il ramo della pianta. Papille guarda la distesa di pomodori.
Il sole cresce, si arrampica nel cielo azzurro contornato da piccole nuvole bianche. Le scie di due aerei solcano lo spazio, Papille mantiene lo sguardo in aria. Ha sete e dalla casupola dove quel Mohoshin ha perso il braccio ha visto uscire l’albanese bevendo dell’acqua. Potrebbe essere l’occasione giusta per rovistare tra i documenti. Il primo giorno, sarebbe un colpo da maestro pensa.
Quando l’albanese si avvicina per un giro di controllo, Papille nota una donna poco distante che con le mani tremolanti si infila un pomodoro sotto la maglia, subito sotto il grosso seno. Papille la vede, lei vede Papille. Entrambi distolgono subito lo sguardo per bloccare ogni pensiero possibile testimone di quella scena. L’albanese è distratto, si avvicina bestemmiando Dio contro due indiani di almeno cinquant’anni, troppo lenti.
– Poscio avee acqua?
Papille non l’aveva guardato bene questo albanese qui. La grossa cicatrice lo fa apparire ancora più brutto di quanto non sia. Gli occhi neri leggermente incurvati all’ingiù sono vitrei, addormentati sotto un’unico sopracciglio nero disordinato. Il naso simmetrico piove dritto su una bocca dalle labbra pressoché inesistenti.
L’espressione, qualsiasi essa sia, non trasmetterebbe empatia nemmeno a un sensitivo, pensa Papille.
– Che ore sono? Nove venticinque, quanti pomodori hai raccolto? Fa’ vedere.
Papille mostra le due ceste.
– Come primo giorno, bela merda. Bevi quando lo dico io, quando ti impari a usare mani.
Il sudore bagna la fronte di Papille, i polpastrelli sono coperti di striature verdi. Le gambe sono pesanti.
Afferra un pomodoro con cura. Lo ruota, sente la pelle liscia e fresca del frutto, nonostante la temperatura, solleticargli il palmo della mano. Con un movimento sicuro in mancanza delle forbici, spezza l’ennesimo gambo subito sopra al calice, la foglia a forma di fiore sopra il pomodoro. I gambi sono ancora carnosi, è un buon raccolto pensa, accarezza il pomodoro e lo mette nella cesta.
Lo schioccare sordo di una corda seguito da un grido distrae Papille dalla raccolta. L’albanese è sulla donna che aveva preso il pomodoro. La tiene per i capelli con la mano sinistra mentre con la destra le tira all’altezza delle cosce tre cordate come se maneggiasse una frusta. La donna si dimena, piange e chiede scusa. L’albanese è solo con la sua violenza e di tutte le persone intorno, nessuno si muove.
Butta la corda, la tira per i capelli verso la casupola trascinandola a terra mentre lei continua a gridare scuse. Papille si muove d’istinto. Sumon, il ragazzo indiano, lo blocca.
– Se vai sei morto.
Papille lo guarda. Il ragazzo non gli sembra vigliacco, ma terrorizzato. Guarda la donna. Guarda di nuovo il giovane e si libera dalla presa.
Corre verso l’albanese e con una spallata sul fianco lo atterra, liberando la donna che singhiozzando con il volto tra le mani continua a ripetere:
– Cosa ho fatto. Cosa ho fatto io non volevo rubare io ho fame.
Il sole alto e grosso riscalda la terra. Le piante di pomodoro sembrano dipinte di un rosso che alla luce del giorno risplende come se volesse prendere vita.
L’albanese si alza, senza parlare, in pochi passi è su Papille che non ha il tempo di alzare le mani per evitare che un bastone gli finisca dritto sulla nuca facendogli perdere i sensi.
CONTINUA…

C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Le carte della settimana sono: Forza, Papessa e Bateleur.
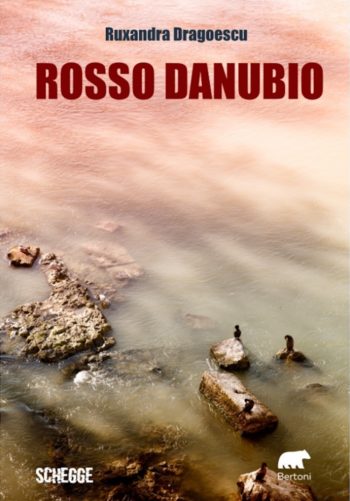
“Ho scelto un eroe collettivo. Ho una mia ossessione: capire, nella vita, come la Grande Storia assorbe la Piccola Storia, come vengono schiacciate le persone comuni dalle decisioni dei pochi”.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – [email protected]
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare