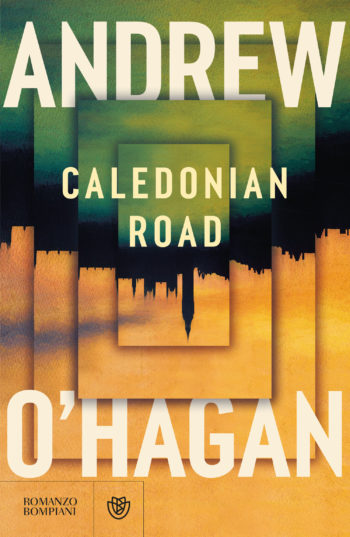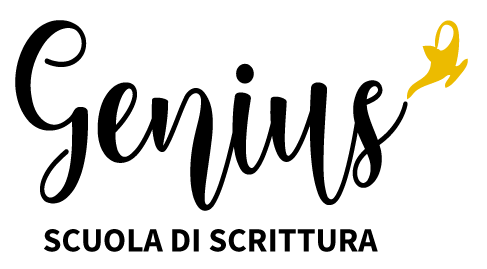Alle volte la versione cinematografica di un libro stimola la curiosità di leggere (o rileggere) l’opera da cui è tratto e di fare confronti, pur avendo chiara la specificità di ogni espressione artistica. È quello che mi è successo col recentissimo Tre piani di Nanni Moretti, ispirato all’omonimo romanzo di Eshkol Nevo (Neri Pozza editore 2017). La lettura del libro mi ha permesso di vedere le vicende del film da punti di vista differenti e di cogliere aspetti preclusi o difficilmente accessibili alla narrazione cinematografica. Parlo della voce interiore dei personaggi, delle loro riflessioni, dei flashback che ricorrono nei loro monologhi interiori e delle confessioni alle quali si abbandonano nei loro dialoghi immaginari, ma parlo anche di altri aspetti, direi strutturali e di ambientazione. Nel film le storie dei tre nuclei familiari, che abitano in piani differenti di uno stesso condominio, sono tra loro intrecciate e vengono narrate da un unico osservatore esterno. Nel libro sono separate, avendo pochi punti di contatto, e raccontate in prima persona attraverso tre diversi espedienti narrativi: il colloquio diretto al tavolo di un ristorante (in “Primo piano”), la stesura di una lettera (in “Secondo piano”) e il monologo davanti a una segreteria telefonica (in “Terzo piano”). Grazie a questi espedienti il lettore è empaticamente coinvolto nelle ossessioni, nei dubbi, nelle aspettative, nei rimorsi dei protagonisti, finendo per riconoscersi in essi. L’ambientazione è quella di un condominio di una zona residenziale e l’estrazione sociale delle famiglie è borghese (i protagonisti dei tre episodi sono rispettivamente un architetto d’interni, una designer e una magistrata). Se però nella versione cinematografica il condominio è situato in un quartiere ricco di una grande città (nella fattispecie Roma, ma potrebbe anche essere Milano, Parigi o Londra), nel libro si trova ai margini di Tel Aviv, in un contesto geografico e culturale al quale si fa continuamente riferimento e che dà una connotazione precisa ai personaggi (si parla di kibbutz, di sionismo, di immigrazione, di Shoa, di mafie locali, di accampamenti di protesta, di lunghe leve obbligatorie). Un altro aspetto che manca nel film è quello simbolico, che fa corrispondere i tre piani del condominio, in cui vivono le rispettive famiglie, con i tre piani nei quali, secondo Freud, è strutturata la psiche: l’Io, l’Es e il Super-io. Il protagonista del primo episodio, preso da un’ossessione incontrollabile, che lo porta a essere violento, è dominato dall’Es; quella del secondo, perennemente sospesa sul baratro della follia, è costretta a mettere in atto tutte le strategie dell’Io per tenere a bada da un lato l’impulso a lasciarsi andare, dall’altro gli ammonimenti di un Super-io minaccioso, che la perseguita con le sembianze di un barbagianni; quella del terzo si trova ad assistere con rimorso ai danni di un’educazione troppo severa, impartita al figlio in conformità ai rigidi precetti del marito.
Il libro nel suo complesso è pervaso da un profondo senso di solitudine, la solitudine di chi, vivendo chiuso nella propria casa, rischia d’impazzire. «Non si può mai sapere cosa succede dietro una porta blindata» dice il protagonista di “Primo piano”. In tutti e tre gli episodi si assiste al bisogno dei protagonisti di confidarsi, un bisogno che però nasce da motivazioni diverse: la paura per una minaccia nel primo, il senso di colpa per un immaginario tradimento nel secondo e la necessità di liberarsi dai condizionamenti di una figura oppressiva, ma amata, nel terzo.
In “Primo piano” il protagonista, Arnon, spinto dalla minaccia che venga svelata una sua infedeltà coniugale, confida all’amico la propria storia, cercando di giustificare l’errore commesso. Il suo rapporto con la moglie è andato in crisi da quando lui, tormentato dal sospetto che la figlia, Ofri, avesse subito molestie da un vicino anziano, incaricato con la moglie a fare da baby-sitter, ha cominciato a comportarsi in modo ossessivo e violento. I suoi sospetti, rafforzati dal comportamento strano della figlia (tendenza all’isolamento, ridotto rendimento scolastico, enuresi), a dispetto di qualsiasi tentativo di rassicurazione da parte di medici, psicologi e della moglie stessa, lo hanno portano a compiere gesti stravaganti e aggressivi fino alle soglie dall’omicidio. Le cose si sono complicate ulteriormente quando Arnon, pur di ottenere verità e giustizia, ha accettato l’aiuto di Karin, la giovane nipote della coppia di anziani, segretamente innamorata di lui. Nel film di Moretti c’è un’evoluzione, che si prolunga per diversi anni attraverso processi, separazioni, riconciliazioni e che fa quadrare il cerchio in modo, a mio avviso, un po’ artificioso e che riduce la vicenda a una mera sequenza di fatti. Mancano, in particolare, le dinamiche familiari che concorrono a spiegare gli strani comportamenti di Ofri (la nascita di una sorellina con problemi di salute, il rapporto conflittuale con la madre) e di Arnon (la rigida educazione paterna ricevuta). Manca anche una convincente caratterizzazione della personalità di quest’ultimo (possessività, tendenza all’autocolpevolizzazione, giustizialismo, adesione a un modello cavalleresco di mascolinità), che nel libro emerge chiaramente e che rende più comprensibili le sue ossessioni.
In “Secondo piano” la protagonista Hani, non potendo più rivolgersi alla sua psicologa di fiducia, che è morta, scrive all’amica Neta che abita negli USA. Ha il timore di impazzire, come è successo a sua madre quando lei era bambina, e da tempo ravvisa i segni premonitori di questo destino in strane allucinazioni che la colgono periodicamente: un barbagianni, che l’ammonisce a comportarsi bene, e la voce di un’amica morta, che la sprona a smascherare le menzogne della vita. Hani vive con i suoi due bambini, Liri e Nimrod. Liri ha un’amica immaginaria, un po’ in ritardo per la sua età, fatto che rafforza nella madre l’idea che tutte le donne della famiglia siano geneticamente predisposte alla follia. Hani ha un marito, Assaf, che è sempre assente per lavoro. Per questo nel condominio la chiamano “la vedova”. Anche lei aveva un lavoro, un lavoro che le dava soddisfazione, ma che ha dovuto abbandonare per dedicarsi alla famiglia. Era designer e prima ancora era stata una studentessa brillante in un’università prestigiosa. Ora la solitudine e la reclusione domestica la schiacciano e rischiano di annientarla. Lei però è forte e saggia e riesce a impedire lo sgretolamento dell’Io, attaccato su fronti opposti dal Super-io-barbagianni e dall’Es delle pulsioni liberatorie, anche quando queste si presentano sotto forma di un intruso, piombato un giorno a casa sua. Si tratta del cognato Eviatar, agente immobiliare braccato dalla polizia, dai creditori e dalla malavita locale. L’uomo, da anni disprezzato e ripudiato dal fratello Assaf per la sua condotta spregiudicata e immorale, si presenta sotto una luce diversa. È premuroso, gentile, disponibile, non solo con lei, ma anche con i suoi figli, al punto da impersonare quel marito e padre perfetto, che lei ha sempre visto con un pizzico d’invidia in Noam, il marito della sua venerata amica Neta. Quando, dopo avergli dato rifugio in un appartamento vicino, legge sul giornale le testimonianze delle persone che sono state da lui truffate dice: «Se fossimo stati in un film americano, avrei dovuto andare con il giornale all’appartamento dei vicini, affrontare Eviatar sbattendoglielo in faccia furibonda… e dirgli: alcune cose sono imperdonabili. Oppure: mi rifiuto di avere rapporti con un furfante come te. Invece, sono andata all’appartamento per avvisarlo che aveva alle calcagna anche la polizia.» Seguono pagine di intenso lirismo, di strazianti confessioni, di viscerali turbamenti, di appassionati aneliti d’amore, che portano la protagonista “sul bordo dello spaventoso abisso prima del cambiamento” e che lasciano il lettore sospeso in un territorio dove la distinzione tra realtà e fantasia perde di significato.
In “Terzo piano” Dovra, la protagonista, è un giudice, vedova di un altro giudice, che per buona parte del film è ancora vivo ed è impersonato da Nanni Moretti. Nel libro l’artificio letterario della segreteria telefonica, alla quale la protagonista parla dopo aver ascoltato il messaggio registrato del marito, fa comprendere bene quanto la donna sia stata (e sia ancora) da lui condizionata nell’interpretazione della realtà che la circonda, soprattutto quella familiare. Man mano che il suo monologo procede veniamo a scoprire il dramma che la sconvolge fin da quando il marito l’ha costretta a scegliere tra lui e loro figlio dopo che quest’ultimo, trasgressivo e ribelle fin da bambino, si è macchiato di una grave e irreparabile colpa. Lei ha scelto il marito, negando al figlio ogni scappatoia legale, in nome di quel rigore morale, unito al rispetto delle regole e a una virile assunzione di responsabilità, che l’uomo ha sempre anteposto all’empatia e all’affetto nell’educazione del figlio, chiamandoli presuntuosamente la “nostra strada”. Dovra confida nel suo monologo la propria angoscia per l’assenza di notizie del figlio fin da quando il ragazzo, espiata la propria colpa, ha voluto tagliare definitivamente i rapporti con i propri genitori. Il monologo della donna, tra paure e incertezze, assumerà sempre più i toni di un difficile e sofferto cammino alla ricerca non solo del figlio perduto, ma soprattutto della “propria strada”.
I tre episodi, che sono altrettante incursioni nell’intimità domestica di famiglie “normali”, chiuse nel silenzio e nell’ordine di un rispettabile condominio residenziale, ci mostrano con un linguaggio diretto e confidenziale e un’esposizione dei fatti graduale, disseminata di vaghe e stuzzicanti anticipazioni e illuminata da sorprendenti rivelazioni, i drammi che si consumano dietro a “porte blindate” non troppo dissimili da quelle dietro alle quali noi tutti viviamo.