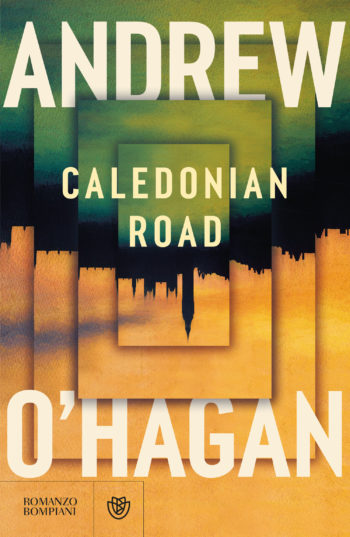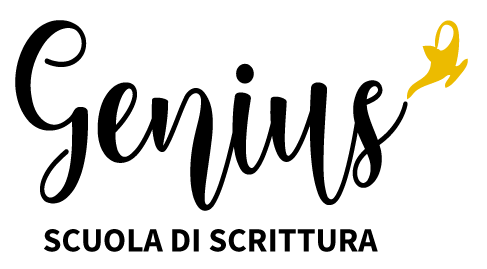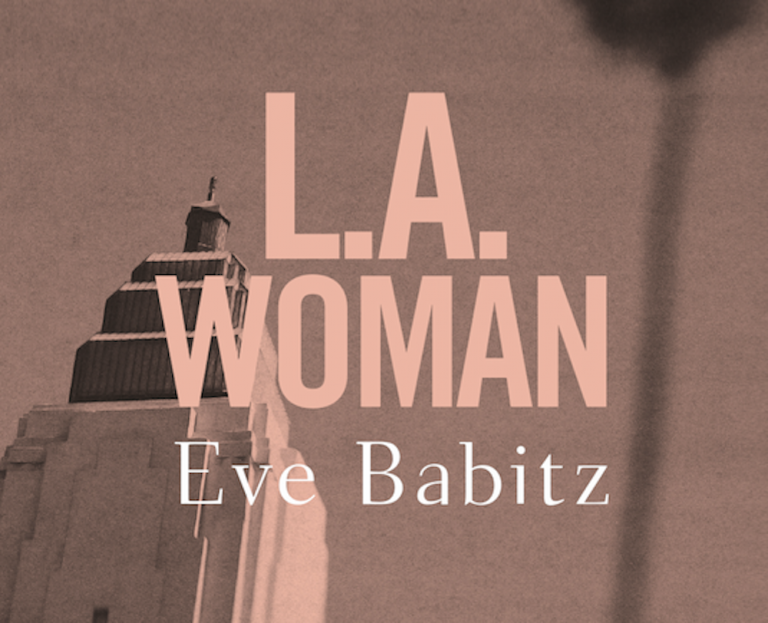Leggere Eve Babitz è come guardare una fotografia di attori e luoghi da sogno: bellezze bionde dalla vita inquieta, rock star distrutti dalla visionarietà e dalle droghe, palme che svettano verdi sullo sfondo di tramonti blu indaco che conservano un cuore color arancio.
Avere 20 anni per sempre è questo: pensare di essere troppo impegnata a vivere e provare nuove esperienze (sesso sfrenato e droghe e corse in tutte le città più interessanti) per decidere di iniziare a “fare qualcosa” o “trovarsi un uomo che ti mantenga”. Eve, in questo libro, un po’ diario personale e storia familiare, racconta il mondo magico e sospeso della Los Angeles degli anni 50 e 60, passando per la pioggia uggiosa di Parigi e per Cinecittà, il cui ingresso “sembra una caserma”.
Figlia di un violinista che suona solo Bach, e di una ragazza venuta a L.A. da un sobborgo del Texas con un vestito azzurro, Eve vive nel posto più sfrenato e più magico del mondo, nel momento in cui ogni idea può diventare arte e portare soldi, in cui la provvisorietà e la promiscuità sessuale ed emotiva non destano scandalo, né preoccupazione, ma anzi sono i nuovi nastri da tagliare nella ricerca dell’emancipazione femminile.
Per raccontare e raccontarsi Eve usa il nome di Sophie Lubin, ma gli eventi, confusi in una miscela di salti temporali, come scritti sotto acido, sono i suoi.
Sophie inizia la sua storia a 17 anni, il suo rifiuto netto di andare in New Jersey è il suo passaporto per entrare nell’età adulta, insieme alla ricerca di un’amica dei genitori abbastanza rispettabile per badare a lei. La trova in Lola, ex ballerina nel periodo della Grande Depressione, che la inizia ai piaceri dell’alcool e la spinge a coltivare il culto della bellezza e del divertimento.
Confesso di avere un debole per le ossessioni, quando sono pure e non offuscate da nessun tentativo di ragionevolezza, e in queste pagine ho trovato una vita alternativa ai miei 20 anni “ampiamente guastati” per citare T.S. Eliot.
Nel mio mondo ristretto c’era un sacco di studio, preoccupazione per un futuro impiego (tenuto a bada da una serie di letture) e una voglia di fuga realizzata almeno 7 anni dopo. Avrei voluto conoscere Sophie/Eve per sentire le sue storie rutilanti, del suo amore senza fine per Jim Morrison, la consapevolezza, improvvisa, che la gioventù è un dono destinato a finire solo se si vive abbastanza da perderla, e che essere grandiosi e immersi in una solitudine corrosiva è il prezzo, forse nemmeno eccessivo, per riscattarsi dalla normalità.
C’è gente che sarà sempre bella e giovane, e adeguatamente infelice o disperata, ma sempre splendida, nelle foto e nelle copertine dei dischi ritratte da Sophie/Eve, in un posto che somiglia a una favola, anche quando da rosa caramella, la casa che abitiamo, diventa, di colpo e senza nessuna soluzione di continuità, rosso scuro, come sangue rappreso.
Roba tipo gelosia, sdegno o altre orrende tattiche sessuali che erano state usate per reprimere ragazze come noi e impedirci di spassarcela per migliaia di anni adesso di colpo non funzionavano più perché Sheila e noialtre non restavamo incinte, non morivamo, e non ci beccavamo la sifilide, e non ci facevamo una pessima reputazione in tutta L.A., il posto dove una donna di L.A. aveva sempre messo tutto a ferro e fuoco come le girava.
E comunque potevi scordarti di essere gelosa se avevi intenzione di innamorarti di Jim.
E, se eri me, era così che facevi.
Eccolo lì in un locale malfamato dove andai una sera a ventitré anni e lui ne aveva ventidue e la poesia si arricciava come fumo intorno a lui. Puzzava di pelle e di alcool e di locali notturni ma sembrava cieco come una statua di marmo. Di fuori era su Sunset Strip ma dentro di sé viveva in un tempo preso a prestito. E io portavo delle gardenie.
Era il 1966 e volevo tutto. Subito.