Nessun prodotto nel carrello.

Dentro la lampada
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

Costringere il corpo ad obbedire alla mente è sempre stato un mio sogno.
Essere capace di muoversi come acqua su un palco, sotto le luci o tra la folla di un supermercato, le gambe allineate, compatte e fluide al tempo stesso, è un dono che nasconde estremi sacrifici. Tenere sotto controllo ogni grammo di cibo, ogni doloroso spicchio di frutta, ogni cucchiaio di brodo o di verdura cruda che si ingoia per sopravvivere, con fastidio. Spesso è questo quello che fanno le ballerine professioniste (e anche quelle non professoniste), decise a spiccare nel mondo come icone di plastica bellezza.
È così che vive la protagonista del romanzo, Anita, immersa in una icastica solitudine, tesa ad essere perfetta, e in una fortissima competizione con la sua compagna di casa e collega Miriam. L’amicizia è un sentimento sconosciuto che non ha casa tra chi lotta per avere un ruolo di primo piano, sempre attenta a spiare la bravura o gli sbagli della rivale.
Anita pensa di non avere il talento di Miriam, quando tutte e due vengono scelte per interpretare il ruolo doppio di Ondine, con una serie di varianti rispetto al copione originale. Attorno ad Anita e Miriam, poi, si muovono una serie di personaggi affamati di attenzione e di emozioni forti desiderosi della compagnia delle ragazze danzatrici.
Il ragazzo di Miriam, Giordano, che è in fissa con i corpi eterei delle due ballerine, e li intreccia e li plasma fino a renderli irriconoscibili; Bruno, un aspirante scrittore che non compra libri nuovi e rilegge quelli che ha, immerso nel tempo luttuoso della separazione da Teresa, e che passa le notti sul divano di casa di Miriam e Anita. Il fratello ritardato di Anita, Toni, che di fatto stalkera l’amica d’infanzia della sorella, Nina, che non ha abbastanza autostima nel credere nel suo talento, ed è convinta che il suo ragazzo sia un genio, e lo scopo della sua vita sia stare dietro a lui, come un’ombra. Ed Ettore, un uomo senza volto con cui Miriam scambia messaggi visivi in chat, e che incuriosiscono anche Anita.
Confidenze sul desiderio, e sul bisogno e la paura di esporre il corpo, che Anita finisce con lo spiare, spinta da una sorta di fame, come le accade sempre quando pensa che Miriam faccia cose interessanti che la escludono.
Quello che non sa ancora, e le verrà rivelato dalla mamma di Miriam, è che il suo sentimento di emulazione rischiosa era ricambiato: anche Miriam trovava Anita più talentuosa di quanto fosse lei, e la imitava, voleva comprare i suoi stessi body per la danza e gli stessi vestiti, e voleva imparare ad indossarli con l’identica noncuranza di chi sa di piacere e offre la sua immagine agli altri con regalità maliziosa.
In tutte queste vite il cibo è amato, goduto o rifiutato, considerato un piacere da divorare o una sana abitudine conviviale, o un modo insulso di passare il tempo.
Il nostro corpo ci appartiene o ci è stato dato solo in prestito, ripetendo una poesia di Ani di Franco, e abbiamo il diritto, oltre che la possibilità, di ridurlo a pura idea, farlo esplodere in una consistenza di luce, trasformando i suoi bisogni più semplici, elementari, prudenti, in vizi da negare?
La fame accompagna sempre chi rifiuta il cibo, diventa un’ossessione più potente di qualsiasi spirito d’amore, al punto da indurre al delirio da svegli, consumati da una sorta di febbrile spasmodica ricerca di perfezione che trascenda i confini della materia. Eppure, che ci piaccia no, il nostro corpo è parte del nostro stare al mondo. Intatti e graffiati, feriti, ma vivi. E questo, dolorosamente, Anita lo sa.
Ai ballerini devono vedersi le costole, diceva Balanchine.
Pericolosamente sottile, aveva scritto Ligeti.
E la Holmes, cosa mi consigliava? Di sembrare più sana.
Come se potessi sdoppiare il corpo e farlo corrispondere a modelli opposti in modo da soddisfare entrambi i requisiti.
Corpi malandati che perdono acqua. Un giorno anch’io avrei perso acqua e di me sarebbe rimasta una forma fossile, una pietra abbandonata sul cemento.
Il mio peso era la cosa di me che conoscevo meglio. Sentivo a volte la necessità organica di ingerire qualcosa, la smania di riempire una cavità che bruciava all’altezza dello sterno, ma questa doveva fare i conti con una nausea reale che sbarrava la strada. Come se il corpo si trovasse all’improvviso diviso in zone autonome non comunicanti: lo scomparto centrale, nel quale avvertivo il bisogno di riempire, e quello superiore, controllato da una centralina che impediva anche solo di avvicinare la bocca all’alimento, pur continuando a desiderarlo.

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
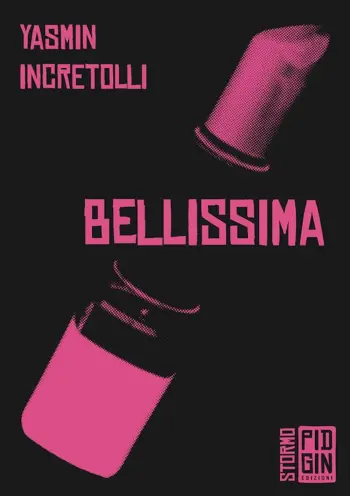
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare