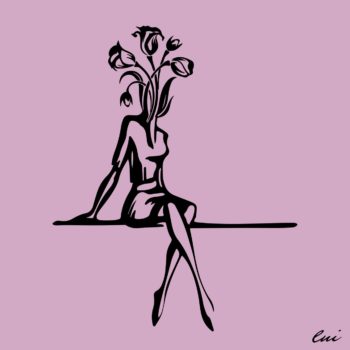
Virginia Woolf e la signora Dalloway
L’incipit di uno dei romanzi più conosciuti di un’autrice amatissima.

Uno degli aspetti più interessanti di quella che ormai possiamo definire, con un po’ di enfasi, la rivoluzione del podcast, è l’attenzione nuova che sta crescendo verso la narrazione attraverso l’audio. Il racconto sonoro della realtà sta diventando per molti ascoltatori un appuntamento abituale che – pur se non riesce a mettere in secondo piano l’onnipresente dominio delle immagini – trasmette emozioni originali e inconsuete, difficili da ottenere anche nella radio tradizionale. Sta diventando un’abitudine ascoltare la voce di un narratore, magari indossando la cuffia, in qualunque luogo preferisci, per esempio mentre sei a casa oppure mentre fai esercizio fisico. E ascoltarla per tutto il tempo che vuoi, nel momento in cui preferisci, senza bisogno di cercare l’appuntamento previsto da un palinsesto. Del resto l’autore stesso, libero dagli orari canonici e dalle durate prescritte della messa in onda, può dedicare al suo racconto tutto il tempo che ritiene necessario.
Così anche molti autori di trasmissioni tradizionali si dedicano oggi a questa nuova frontiera dell’audio. Come Marilù Merolla, giornalista del Gr Rai da molti anni, voce nota del programma “Inviato speciale” che ha prima voluto approfondire la conoscenza del mondo dei podcast con noi di Genius e ha poi realizzato “Radio terremoto” un podcast che potete trovare qui, su RaiPlay Sound. Si tratta della ricostruzione emozionante del lavoro che nel 1980 una piccola radio locale avellinese, “Radio Alfa”, ha portato avanti di fronte alla colossale tragedia del terremoto dell’Irpinia, attraverso le loro voci e le voci di quelli che via telefono o ai loro microfoni, hanno vissuto quell’esperienza. “Radio Alfa” divenne allora per tutti “Radio Terremoto” e Merolla ce la fa rivivere con efficacia. A questo punto dedicarle le domande della mia intervista della domenica è stato inevitabile. Ed ecco le sue risposte.
Prima di tutto parliamo di “Inviato speciale”, quanto ti dà questo programma?
“Inviato Speciale” è un programma storico di Rai Radio 1. È nato nel 1997 ed è un contenitore che negli anni ha raccolto i migliori reportage dei nostri inviati e corrispondenti. Oggi resiste, nonostante l’orientamento più diffuso privilegi la diretta, e i programmi registrati siano considerati dai più una sorta di retaggio del passato. “Inviato” ha un suo pubblico, io ci lavoro dal 2007 e per me è sempre stato un luogo in cui potevo raccontare storie, che poi alla fine è quello che mi piace fare.
Perché scegliere di affiancare alla radio un tuo podcast?
Mi incuriosiva provare a raccontare storie in un modo diverso. Qualunque mestiere, anche il mio che amo moltissimo, con gli anni diventa routine e fare un podcast mi ha dato una boccata d’aria fresca, una spinta a esplorare nuovi orizzonti.
Quali sono le differenze che hai trovato nel lavoro concreto sul podcast?
Nel podcast c’è maggior libertà. Il giornalista deve essere sempre fedele ai fatti, cercare di non interpretarli, raccontarli così come accadono. La “notizia” è verità perché “succede”. Nel podcast si è liberi di interpretare, di emozionarsi e di emozionare. Si può essere presenti nella narrazione e far “sentire” la propria presenza. E cambia anche la scrittura che diventa più personale, il podcast, insomma, è in fondo quel romanzo che non ho mai scritto!
“Radio Terremoto” perché?
Radio terremoto racconta la storia di una radio libera ma anche quella del terremoto che colpì l’Irpinia nel 1980. Due storie che per me sono state molto importanti. Le radio libere all’epoca erano luoghi di aggregazione, dove si incontravano persone e si faceva amicizia. E io le ho frequentate, come molti della mia generazione. Il terremoto dell’80 invece fu un evento davvero catastrofico, fece circa tremila morti e avvenne alle porte di casa mia.
Dov’eri tu in quei giorni?
All’epoca abitavo a Napoli. Avevo 18 anni e forse per la prima volta percepii quanto la vita potesse essere fragile. Quando ci fu la scossa stavo andando a visitare mio nonno, ricoverato in ospedale per la frattura del femore. Ebbi un fortissimo capogiro (lo racconto nel podcast) e immediatamente pensai di avere un problema di salute. Poi improvvisamente decine di persone si riversarono in strada, chi urlava, chi piangeva, io non capii più nulla, mi sentivo inebetita. Ci raggruppammo in un grande piazzale, lontano dai palazzi. Quella notte dormimmo tutti in auto, si formò un lungo serpentone di vetture… Nei giorni che seguirono andai a trovare mio nonno, il Cardarelli era un grande ospedale, il più vicino alla zona del disastro. E non dimenticherò mai la disperazione di un uomo che andava avanti e indietro lungo il corridoio di Ortopedia e non si fermava mai. Aveva gli occhi bassi e non parlava con nessuno. Veniva da Lioni, uno dei centri più colpiti, e nel terremoto aveva perso tutta la famiglia.
Le voci di quell’epoca sono emozionanti, cosa ti ha colpito di più?
Delle voci che ho usato nel podcast mi hanno colpito soprattutto quelle degli sposi nel primo matrimonio celebrato dopo il terremoto. In quelle voci si “sente” un disperato tentativo di tornare alla vita, di lasciarsi la morte alle spalle, ma anche l’incertezza, l’esitazione, la paura di osare troppo nel cercare di essere felici.
Nell’epoca del web, che sembra puntare tutto sull’immagine, c’è spazio per l’audio?
Credo che oggi più che mai ci sia bisogno di “audio” proprio perché c’è un eccesso di immagini. Siamo circondati dalle immagini… secondo me quello che conta è il racconto. Anche nelle narrazioni di guerra, dove le immagini si assomigliano tutte, quello che fa la differenza è il racconto, la storia delle persone.
Ti è piaciuto passare dalla scrittura giornalistica a una scrittura più narrativa?
Passare a una scrittura più narrativa mi ha dato un senso di libertà. Ho raccontato una storia vera della quale non ero solo spettatore ma anche protagonista. È stato molto divertente.
C’è qualcosa che ti piacerebbe raccontare e non hai mai fatto finora?
Mi piacerebbe raccontare la storia di una piccola comunità che si nasconde su un’isola sperduta del Mediterraneo. Dove la giornata non passa mai e tutto sembra sempre uguale… Ma questo è un vecchio sogno che resta nel cassetto.
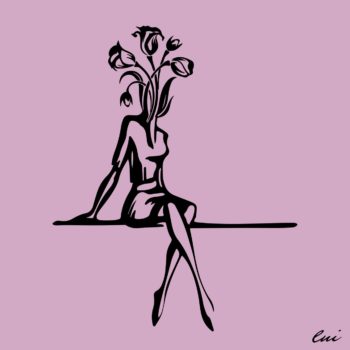
L’incipit di uno dei romanzi più conosciuti di un’autrice amatissima.

Le carte della settimana sono Giudizio, Imperatore e Stella
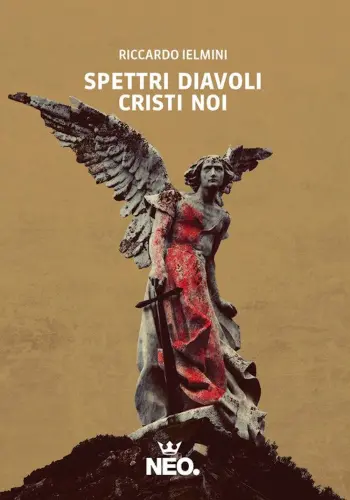
In questo romanzo un gruppo di ragazzini che tra loro si definiscono la Confraternita spiano luoghi che nascondono orrori, cadaveri, segreti indicibili e messe nere.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – [email protected]
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare