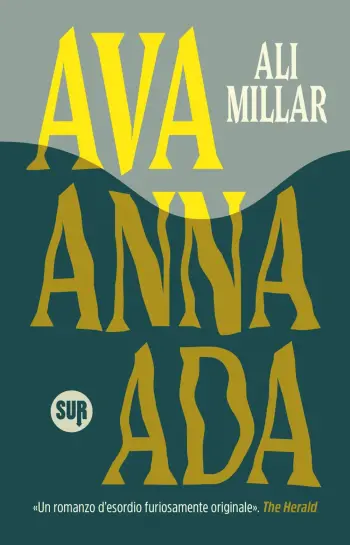Conosco Michael Sozzi da qualche tempo e l’ho osservato e seguito mentre scriveva il suo romanzo La complicanza che ora è stato pubblicato (Bertoni 2022). Sozzi è un medico e nel romanzo si racconta la storia di un medico, ma non è un racconto di vita lavorativa vissuta, anche se il romanzo indaga (e non uso questa parola a caso) i misteri e le abitudini spesso al limite della legalità di un grande ospedale, partendo da un tragico caso di cronaca, simile a tanti che capitano, una sfortunata complicanza appunto. È un romanzo che narra la vita di un uomo che pare sconfitto ma sta lottando per risollevarsi. La scrittura è limpida e scorre facilmente, ma è anche intima e riflessiva. Si scopre facilmente leggendolo che Sozzi è un lettore “forte” ma noi lo sappiamo già perché scrive anche recensioni per il nostro sito, e abbiamo potuto perfino immaginare di seguire le sue letture mentre stava scrivendo il suo romanzo. Chi legge La complicanza si trova ad avere a che fare comunque con un romanzo dal solido impianto tradizionale che indaga i fantasmi interiori e il percorsi psicologico di un uomo che è il protagonista di questa storia, ma somiglia anche a molti di noi. E adesso è arrivato il momento di cominciare il dialogo con l’autore, no?
Quanto tempo hai impiegato a scrivere questo romanzo?
Due anni.
Hai mai pensato che non ce l’avresti fatta a finirlo, visti i tuoi impegni professionali?
Più di una volta. Non solo per i miei impegni professionali, ma anche perché durante la stesura del romanzo mi è nato il secondo figlio: sicuramente una grande gioia ma anche una seria minaccia alla mia tranquillità sia diurna che notturna. Per fortuna ho potuto contare sulla comprensione della mia compagna e sono riuscito a ritagliarmi i miei spazi.
Pensi che vivere a Trieste, una città che ci appare ancora a misura d’uomo, e poi ricca di riferimenti culturali e letterari, da Svevo a Joyce a Claudio Magris, ti abbia in qualche modo aiutato come scrittore?
Sicuramente Trieste è una città a misura d’uomo e con un’eccellente qualità di vita. Sei sul mare, che per me è una linfa vitale, e nel giro di una o due ore puoi raggiungere le montagne. Hai l’altipiano carsico a portata di mano e poco più in là ci sono l’Istria e il Collio friulano. La varietà di questi paesaggi, concentrati su una superficie così ristretta, è per me fonte di continuo stupore e stimolo alla fantasia. Allo stesso modo lo è la varietà umana, etnica e culturale di questa città in cui si sentono contemporaneamente la profondità, la gravità e la problematicità della tradizione culturale centro-europea (non uso il termine mitteleuropea perché mi pare un po’ abusato) e la leggerezza ariosa e persuasiva del mondo mediterraneo. Qui mi sembra di vivere diverse vite o meglio diverse prospettive di vita come se guardassi in un caleidoscopio. Per quanto riguarda i riferimenti letterari, devo dire che fino ai trent’anni mi sentivo molto più attratto da tutto ciò che proveniva da lontano piuttosto che dai “mostri sacri” locali (Saba, Svevo, Stuparich, Slataper, ecc…) forse perché da giovani si subisce il fascino dell’esotico, che è tutt’uno con l’idea di esplorazione e di avventura. A quel tempo amavo gli autori americani (in particolar modo Hemingway e Fitzgerald) e i classici russi e francesi. Poi, grazie a Claudio Magris (ai suoi saggi e al suo bellissimo Danubio) mi sono affacciato al mondo culturale austriaco e tedesco, riavvicinandomi alle mie origini (sono nato in Germania e mia madre era tedesca). Ho così scoperto e amato autori come Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Hermann Hesse, Joseph Roth, Thomas Mann e altri. Ed è proprio grazie alla letteratura tedesca e a Magris, che me l’ha fatta conoscere, che mi è venuta la curiosità di leggere Svevo, le cui radici culturali affondano nel mondo d’oltralpe. Così, dopo aver fatto un giro avventuroso nella letteratura mondiale, sono approdato a casa mia e ho scoperto che, guarda caso, anche a Trieste c’erano autori degni di essere letti. Ancora oggi Svevo è uno dei miei scrittori preferiti, uno scrittore geniale, che ho letto molte volte e che, assieme a Proust, mi ha influenzato nella stesura del mio primo romanzo, La zattera. Per rispondere alla domanda, direi che Trieste mi ha insegnato ad apprezzare ogni genere di diversità (ambientale, umana, letteraria) e ha stimolato il mio desiderio di osservare, conoscere, confrontare e raccontare. Il dottor Drioli, protagonista del mio romanzo, ama passeggiare per Trieste, guardare l’architettura eclettica degli edifici e fantasticare sulle genti che fin dai tempi dell’istituzione del porto franco sono affluite qui da ogni parte dell’Impero Asburgico. In questo mi assomiglia.
La complicanza è un romanzo ambientato in un ospedale, possiamo dire che si tratta di una storia di malasanità?
In un certo senso sì, ma la questione qui è un po’ più complessa. Non voglio svelare nulla dell’evoluzione della storia. Mi limito a dire che le cose non sono esattamente come appaiono e che il tema dominante della vicenda è il senso di colpa, un senso di colpa accompagnato da una spietata e autolesionistica volontà di espiazione. Il contesto in cui si muovono i personaggi, più che essere quello di una malasanità, è quello di una sanità spregiudicata, intessuta di intrighi, di carrierismo, di piaggeria, di sopraffazione. L’ambiente è ospedaliero, ma le dinamiche umane che si sviluppano al suo interno sono sovrapponibili a quelle che si possono trovare in qualsiasi ambiente di lavoro.
Tu, da medico, sei mai stato coinvolto in una situazione simile a quella che capita al tuo protagonista?
No, ma un mio collega chirurgo, che conoscevo a malapena, sì. L’idea del libro è nata proprio quando ho saputo che questo collega, professore universitario, del quale avevo sempre sentito parlare bene, era stato escluso dall’attività chirurgica e relegato in un ambulatorio generico dopo una complicanza in sala operatoria per la quale era stato condannato. Sapevo solo questo, niente di più. Poi, basandomi sulla mia conoscenza dell’ambiente ospedaliero e sulle mie esperienze lavorative, ho inventato questa storia. L’idea che mi aveva sedotto era proprio quella del confine labile tra il bene e il male. Persone eccellenti possono macchiarsi di gravi colpe, vere o presunte, e avere la loro reputazione irrimediabilmente infangata come, viceversa, persone meschine e mediocri possono, per meriti anch’essi veri o presunti, ottenere dagli altri rispetto e ammirazione. È questo gioco delle parti, questo inestricabile groviglio di meriti e colpe, questa ambivalenza dell’animo umano che mi ha affascinato.
All’inizio lui è un uomo depresso, sconfitto. Ti sei ispirato a qualcuno mentre lo descrivevi?
I pensieri depressivi, pessimistici che invadono il protagonista mi sono familiari perché anch’io ne vengo ciclicamente invaso. È una sorta di “pessimismo cosmico” che si affaccia alla mia mente in certi momenti (soprattutto di notte) con schiacciante forza persuasiva, ma che poi refluisce e lascia il posto a uno straripante entusiasmo per le bellezze della vita, della natura, dell’arte, della scienza.
C’è stata qualche lettura particolare che ti ha accompagnato mentre scrivevi?
Direi che questa volta ho voluto sconfinare dal genere letterario che ho sempre amato (quello del romanzo psicologico-esistenziale) per avventurarmi nel campo del romanzo d’indagine. Non potrei dire che il mio libro sia propriamente un giallo – non ho la stoffa del giallista – ma una sorta di romanzo psicologico con risvolti investigativi. La lettura che durante la stesura del libro mi ha accompagnato è stata quella dei libri di Simenon, e in particolare quella del romanzo Gli intrusi, dove si narra di un avvocato stanco, rassegnato, intorpidito dal vino, la cui vita viene scossa dalla scoperta di un crimine consumato proprio a casa sua, in una stanza dimenticata del grande e antico palazzo in cui abita.
Tu sei un lettore appassionato, scrivi recensioni anche per noi, se dovessi essere messo di fronte alla scelta se smettere di leggere oppure di scrivere, cosa faresti?
Sarebbe davvero una scelta difficile. Dal momento, però, che la lettura è per me un nutrimento e la scrittura un’espressione del mio esistere, rinuncerei, pur con dolore, alla seconda. Si può vivere senza esprimersi ma non senza nutrirsi.
Nel tuo romanzo conta molto il rapporto che il protagonista, il dottor Drioli, ha con la figlia. È una relazione che ti interessa particolarmente?
Ho due figli: una ragazza di ventidue anni e un bimbo di cinque anni. Essere genitori è un’esperienza importante nella vita per molte ragioni, due delle quali, secondo me, sono fondamentali: è un eccellente antidoto contro l’egocentrismo di cui siamo tutti – chi più chi meno – affetti ed è una forte motivazione a vivere e a lasciare alla fine questo mondo senza troppi rimpianti. Quando il dottor Drioli sente sé stesso sprofondare nel vuoto della propria esistenza e in quello della vita in generale pensa alla figlia non come a un possibile appiglio ma come a una categorica e doverosa presa di responsabilità. Non può lasciarsi andare perché sua figlia ha ancora bisogno di lui e lui ha ancora tante cose da insegnarle. Anche nei momenti più cupi Drioli si sforza – e in questo risulta un po’ patetico – di mostrarsi alla figlia solido e affidabile. Nel suo rapporto con lei c’è poi la consapevolezza di un’affinità caratteriale e di interessi, affinità che gli dà una punta di soddisfazione, di autocompiacimento: qualcosa di buono di sé stesso, alla faccia della cattiva sorte che lo ha travolto, continua a vivere in lei e potrà dare ancora dei frutti. La figlia a sua volta, pur essendo ancora un’adolescente, ha nei confronti del padre un atteggiamento responsabile e maturo. Non si lascia ingannare dalla patetica immagine di solidità che lui cerca di trasmetterle e gli si avvicina con dolcezza, rispetto e discrezione per tentare di aiutarlo. C’è insomma tra i due, nonostante la differenza d’età e di ruoli, una relazione profonda e matura, improntata alla generosità e alla reciprocità, sotto alla quale, però, traspaiono i turbamenti affettivi di un’adolescente coi genitori separati e una madre poco premurosa e le angosce di un uomo che teme che il proprio fallimento professionale possa compromettere anche ciò che di più prezioso gli resta al mondo: il rapporto con la figlia.
C’è anche l’amore, no? Alla fine è questo il messaggio del tuo romanzo: è l’amore che ci può salvare?
Beh, di questo non vorrei parlare più di tanto per non fare spoileraggio (che brutto termine! Oggi però si usa e mi adeguo ai tempi…) Mi limito a dire che l’amore, inteso come passione tra due adulti di qualsiasi orientamento sessuale, è un elemento che non manca nel libro e che ha un ruolo determinante nell’evoluzione della storia. Voglio però sottolineare l’importanza che nel libro (e nella vita) l’amore ha nella sua accezione più vasta: amore per il proprio lavoro, amore per il sapere, amore per i figli, amore per la verità, e così via. Vorrei citare in conclusione il celeberrimo verso di Virgilio che Drioli ricorda quando sente rinascere in sé una vecchia passione: “Adgnosco veteris vestigia flammae”. Nel caso di Virgilio si trattava della fiamma d’amore, che s’accende in Didone alla vista di Enea, per Drioli della fiamma della conoscenza.