
Clelia Marchi e la vita su un lenzuolo
C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

A un ex professore di chimica in pensione viene commissionata una consulenza su una sconosciuta piantagione di caffè nel cuore dell’Africa.
Puntate precedenti
Seconda puntata
Seduto in attesa del decollo, Castelli ricorda una vecchia consulenza in Giamaica.
Gli richiesero infinite analisi tecniche su una piantagione di caffè Blue Mountain.
A commissionare il lavoro fu una multinazionale Lussemburghese desiderosa di acquistare un appezzamento di terra giamaicano; l’azienda evitò di condividere l’informazione più importante del progetto, il terreno si trovava sotto l’egemonia di una tribù giamaicana autoctona.
Sul posto Castelli e lo staff furono aggrediti più volte. Il lavoro venne sabotato e la permanenza del professore dai due mesi pattuiti divenne di quattro, poi una costola rotta, una relazione con una giovane giamaicana e la solita, immancabile, diarrea.
Chiude la pagina di Google dato che anche declinato per assonanza il nome Mac Hamay, il mittente della lettera per cui si trova sull’aereo, non suggerisce riscontri. Stesso esito per il timbro a forma di chicco di caffè, non fosse per una storica azienda romana che tosta caffè che ha un logo simile ma non uguale, su internet trova solo l’articolo di “Caffeine”.
Le hostess della compagnia KLM, servono con gentilezza del whisky, mediocre pensa Castelli. Per non parlare del caffè.
Il fatto che una compagnia di bandiera di una nazione con migliaia di caffetterie a terra, pensa, serva a bordo acqua da bidè, è orrendo.
Castelli nota un’assistente di volo osservargli gli aloni di sudore ai lati della camicia, e chiude d’istinto le spalle a guscio.
Avrebbe voluto avere più informazioni sull’entroterra keniota.
Sulla cultura chimica relativa alla terra spazia ben oltre i confini italiani, ma mai ha messo piede in Kenya, per giunta al confine con l’Uganda.
Però ha riconosciuto la provenienza della lettera dall’odore, il suo naso continua a essere attivo e regolare, come la sua diarrea e il suo sudore da stress.
Accenna un sorriso e in silenzio sorseggia altro whisky in cui non trova altro che note alcoliche, una tornatura leggera e disgustato guarda fuori dal finestrino.
Lo infastidisce l’idea di essere stato precipitoso.
Ho accettato per i soldi, curiosità. E se ci rimango? E se è una truffa e quel tipo vuole che io dica falsità per dare senso all’investimento? E se mi ricatta? Guarda le pellicine intorno alle unghie martoriate dai morsi.
Ripensa a quando venne colto dal timore di non essere all’altezza di un lavoro in Norvegia. Era atteso all’università di Tromso per tenere un corso circa l’”aging” di alcune tipologie di caffè. Le paure non erano altro che elucubrazioni di una mente tanto brillante quanto fragile.
Rimase seduto sulla tazza del cesso degli arrivi dell’aeroporto di Tromso un’ intera ora, per poi decidere di tornare in Italia la sera stessa.
Non è questo il caso, non è questo il caso, non è questo il caso. Non è questo il caso. Lo ripete tanto da farsi sentire dall’uomo seduto davanti a lui che si aggiusta sul sedile. E giù altro whisky.
L’aereo atterra all’aeroporto di Mombasa in orario. Castelli ha la pelle umida, gli occhi gonfi intorpiditi dalla pressione mentre si sciacqua il viso con l’acqua di una bottiglietta.
Al ritiro bagagli un giovane africano panciuto lancia valige da un carrello di legno verso il centro della grande sala degli arrivi.
L’aeroporto appare a Castelli fermo agli anni ’80. Fili elettrici simili a liane fluttuano nel vuoto, muri scrostati, guardie di servizio annoiate in divise militari, sudate, giocano con cellulari che in Italia a occhio e croce sarebbero appartenuti ad almeno mezza generazione precedente.
Per il visto d’ingresso Castelli sborsa cinquanta dollari, posa per una foto segnaletica a pochi centimetri da una vecchia webcam e scarabocchia una firma su un documento d’ingresso. Compila il documento spuntando il quadratino del turismo quale motivazione del suo viaggio in Kenya.
Ad attenderlo, come scritto nella lettera, c’è il giovane autista che di nome fa Hope. Ha un sorriso bianco che brilla sulla pelle nera e levigata, in mano ha un cartello con scritto a tratti incerti il nome Castelli Professore Signore. Castelli sorride. Fa un cenno al giovane che è subito pronto.
Il professore stacca la camicia fradicia dalla pelle, sente un brivido sul bagnato.
Costruzioni diroccate intorno all’aeroporto contornano le strade dissestate, Castelli guarda curioso tra cumuli di plastica e rottami di vecchie auto, dove incurante della mano umana cresce una fitta vegetazione autoctona che, un giorno, si impossesserà di nuovo della terra pensa.
L’aria condizionata gli fredda la schiena sudata.
La vecchia Mercedes, osserva Castelli, ha non meno di quindici anni. Una carcassa blu dagli interni beige consunti. L’odore di legno e tabacco, probabilmente del luogo, gli intasano le narici mentre Hope sorride, ingrana la prima e parte.
Ad accartocciarsi per primo è il tetto. Poi seguono schegge di vetro e tutto è sotto sopra più volte e più volte. Il rumore di lamiere stride quando la macchina esce di strada e si ribalta sulla terra arida.
Castelli riapre gli occhi. La testa gira, il naso sanguina un sangue scuro sopra sangue incrostato sulla pelle. D’istinto strattona il corpo di Hope per svegliarlo.
Non risponde.
– Dai amico suvvia non fare scherzi.
Altro strattone.
– Non puoi morirmi così, rispondimi.
La voce in falsetto, il sangue in bocca. Hope non risponde perché è morto, strilla una voce dentro la sua testa. Morto!
In strada è notte, la lucina interna della Mercedes e la luna sono le uniche fonti di luce. Castelli si tampona l’orecchio con le dita, il sangue gli scivola sui polpastrelli. Anche il sopracciglio sanguina. Ricorda di aver battuto più volte tra finestrino e tetto, finestrino e tetto, tetto e finestrino. Ma è vivo.
Si tocca il corpo fino a calmarsi quando ogni arto, giuntura, osso, cartilagine risultano intatti.
Impregna la camicia beige di sangue e sudore per asciugarsi. Pensa. Devi pensare. Devo pensare. Più cerca di concentrarsi, più guarda il corpo senza vita di Hope. Decide di frugare nella tasca del morto, ma prima cerca conforto nel suo taschino. Eccola. La piccola e deliziosa boccetta di whisky scadente sfilata alla hostess sull’aereo. Esce forzando la portiera e fa il giro di ciò che resta dell’auto; non ha mai visto un uomo morto e sa bene di dover prendere il suo cellulare per chiamare aiuto. Le gambe che gli tremano a vista d’occhio che qui non si regge in piedi.
Il ragazzo non ha più di vent’anni. Un vetro del parabrezza gli si è conficcato in un occhio, la testa ricoperta di sangue è riversa sul sedile, le dita di entrambe le mani sembrano spezzate.
Il sudore si fredda, lo stomaco si contrae e il senso di oppressione al petto spinge Castelli ad arretrare di qualche passo per vomitare.
Si pulisce la bocca con la manica prima di tornare al suo adoperarsi con la camicia sudata di Hope. Il corpo ancora caldo mantiene piccole gocce di sudore incollate tra pelle e stoffa; il telefonino, un vecchio Ericsson 2g è nel taschino, acceso e funzionante.
La mano trema, apre il telefono e spinge il pulsante delle chiamate. L’ultima è a un numero non salvato, le altre riportano la dicitura Mum e Sophia.
Tenta con il numero senza nome. Sta per spingere il tasto “Call” quando una macchina della polizia locale si accosta alla Mercedes. Benedetta polizia.
I due grossi poliziotti sono tutto un parlare tra di loro. Guardano lo sfacelo dell’incidente e parlottano, bisbigliano e guardano Castelli intento a sorreggersi tra le lamiere.
– Do you speak english? Do you speak english? – Grida.
Un no con il volto.
Una vertigine. Si avvicinano, sono salvo. Imbracciano entrambi il fucile, Castelli prova a scandire la parola “help” ma il colpo arriva secco, il calcio del fucile gli finisce dritto sul volto, un vuoto alle gambe, il naso sanguina e il fiato si accorcia, poi è buio.

C’è un lenzuolo che custodisce la storia di una vita…

Le carte della settimana sono: Forza, Papessa e Bateleur.
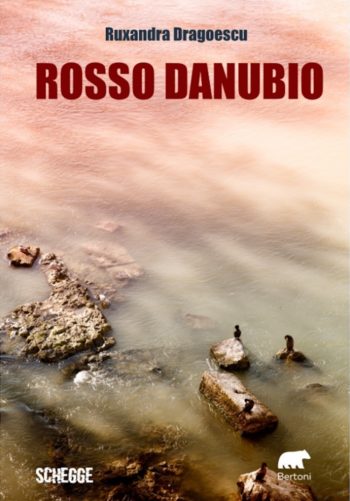
“Ho scelto un eroe collettivo. Ho una mia ossessione: capire, nella vita, come la Grande Storia assorbe la Piccola Storia, come vengono schiacciate le persone comuni dalle decisioni dei pochi”.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – [email protected]
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare