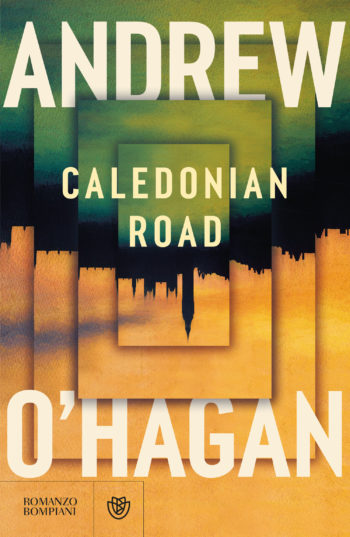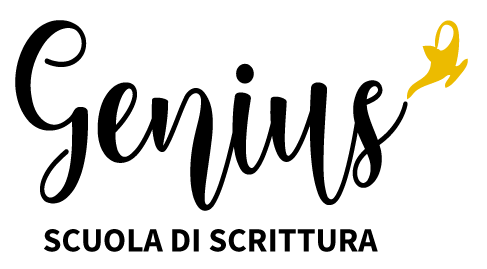Qualche anno fa, nella casella di posta elettronica che riceve le mail degli aspiranti scrittori, giunse un racconto di Antonietta Toso, alcune pagine inviate per richiedere una valutazione. Si poteva leggere già dalle prime righe l’energia di un personaggio e di una scrittura che non ce la facevano a rimanere chiuse in una storia breve. C’era bisogno di dargli aria, molte più parole, doveva svilupparsi quasi naturalmente una storia più complessa. Spuntava fragorosamente di fronte agli occhi del lettore la figura di Joannin, bambino orfano di madre, poi ragazzo innamorato della figlia dell’uomo al quale il padre lo cede perché non ce la fa a crescerlo, giovane appassionato di astrologia, frequentatore di biblioteche, quindi soldato durante la guerra, e ancora uomo maturo, ormai sposato, bizzarro, passionale, infine malato. Un piccolo uomo che cerca di vivere con la forza di un gigante, malgrado le difficoltà che attraversa nell’esistenza. Adesso il romanzo è stato pubblicato ed è appena uscito, s’intitola appunto Joannin (Bertoni 2021) e l’autrice (che ho accompagnato in questa sua avventura letteraria) è pronta per rispondere alle domande della nostra intervista.
Hai scritto la storia di un ragazzo, poi uomo, che attraversa anche la storia nazionale del nostro paese. L’avevi deciso fin dall’inizio oppure la forma della storia ti è venuta scrivendo?
Il romanzo Joannin nasce da un racconto di poche pagine che ti ho spedito nella speranza di poter accedere ai corsi di scrittura.
Avevo fin da subito deciso che Joannin nascesse all’inizio degli anni venti, a cavallo fra la prima e la seconda guerra mondiale. Era dunque importante se non essenziale, affinché la sua storia fosse credibile, che lo rendessi partecipe della società di allora, anche se non sapevo se avrebbe avuto un ruolo attivo, o se l’avrebbe solo subita.
La scelta la fa Joannin stesso che, come a scriversi da solo la propria storia, si tuffa nel mondo di allora in entrambi i modi.
Joannin è un personaggio complesso, sensibile, capace di amore, ma anche pieno di contraddizioni, è ispirato a qualcuno?
Sì, Joannin assomiglia, per quanto possibile a mio padre che non ho conosciuto.
Da quello che mi è stato raccontato, me lo immagino un bimbo solo, costretto a causa di alcune dinamiche famigliari a prendersi cura di se stesso, ad arrangiarsi e a dover cercare la propria strada nella vita.
Nella sua mente colma di fantasia irrompe da subito la figura del moschettiere Athos, un’immagine mentale, non reale, che rappresenta però il suo unico amico, perché hai scelto proprio questo personaggio?
Un bimbo che soffre la solitudine, del senso di mancata appartenenza, di protezione e che vive l’infanzia in balia di se stesso, sviluppa problemi di autostima, d’insicurezza di ogni genere che si rilevano nel suo comportamento, nel suo modo di parlare. Ecco allora venirgli incontro Athos, una figura nobile e bella, una figura amichevole e nello stesso tempo paterna, molto protettiva nei confronti di d’Artagnan che considera come un figlio, una figura di cui Joannin si può fidare. Il fatto che Athos stesso anneghi i suoi dispiaceri nel bere, proprio come fa il padre Primo, ho pensato che lo avrebbe fatto sentir ancor più reale e vicino. Meno solo.
Joannin e le donne. Cosa cerca e cosa trova nella storia che hai scritto?
Qui mi sono lasciata trasportare dalla fantasia. Mi sono affidata alla presupposta conoscenza delle esigenze fisiologiche di ogni ragazzo alle sue prime esperienze sessuali, con la differenza che, per poter porre in evidenza i complessi d’inferiorità di cui Joannin soffre, avevo la necessità che egli si dovesse sentire attratto, a livello inconscio, da una figura femminile raffinata, appartenente all’alta società che lo portasse lontano dal suo stato di bimbo nato povero, che lo liberasse dalle catene delle sue umili origini entro le quali si sente prigioniero.
Ma Joannin è anche un ragazzino orgoglioso e intelligente. Una volta individuata la donna da conquistare, capisce che se la deve meritare o lei non lo avrebbe neppure degnato di uno sguardo, se non di disprezzo.
Questo è quanto Joannin racconta a se stesso per giustificare quelle scelte che nel tempo gli si rivelano errate come quando afferma: “Avevo diciotto anni. A quell’età si agisce d’impulso. Si agisce sotto la pressione che è l’insieme degli eventi. La sintesi della tua storia”.
In realtà, tutto ciò che Joannin realmente anela è di amare e di essere amato come si deduce da questo passo:
“Joannin percepiva pure come amare fosse il più grande atto di coraggio che l’essere umano potesse compiere e lui non si sarebbe tirato indietro”.
Come hai fatto a far convivere le azioni reali che si svolgono nella storia all’invenzione letteraria dei tuoi personaggi? Insomma, cosa è finto e cosa è vero nel romanzo?
Novantanove per cento di ciò ho scritto è frutto della fantasia. Ogni avvenimento, ogni personaggio, da Rudi a Marilena, da Ernesto a Nello, da Felix a Gennaro e perfino Andrea detto Penna Bianca, è entrato, oppure uscito, dalla esistenza di Joannin per dare vita ai tormenti, alle utopie di un ragazzo che deve crescere, che vuole emergere, evolvere, diventare uomo allontanandosi dalle condizioni di vita in cui era nato e da quelle in cui via via, va incontro.
Ogni personaggio che entra nella sua vita, perché è lui a cercarselo, a sceglierlo, ha lo scopo di farlo progredire, sia culturalmente, sia umanamente. Ogni interprete possiede un peso importante per lo sviluppo e la conoscenza di Joannin intesa anche in senso più ampio e rasenta l’esoterico quando chiede lumi ad Athos.
Quell’un per cento che è reale, si riferisce alle date tratte dalla lista di mansioni scritta a mano, su di un foglio protocollo, che mio padre doveva compiere, così come il numero di matricola che è riportato nel romanzo e con cui, Joannin soldato, viene identificato.
Mio padre non ha lasciata scritta alcuna notizia sulle sue vicende militari che sono quindi frutto di ricerca e poi romanzate.
C’è qualcosa nell’esperienza di vita di Joannin che si collega alla tua esistenza, ti ritrovi in lui? Potresti dire, come nella famosa frase di Flaubert “Joannin c’est moi”?
Credo che ci sia qualcosa nella natura di Joannin che mi abbia rassomigliato molto in passato e qualche altra che mi rassomigli tuttora. A tratti, sento, vivo la sua interiorità come fosse la mia. Le sue angosce, le sue fantasie, i suoi slanci, le sue passioni, il suo desiderio di essere visto e riconosciuto, il suo orgoglio mi assomigliamo. Abbiamo attraversato, a livello caratteriale, gran parte del romanzo insieme. Lo capisco anche quando fa scelte che, nel tempo, giudica sbagliate. Capisco il suo umano tormento.
Arriva poi il momento in cui Joannin deraglia, e noi ci separiamo. Joannin si allontana da me nel momento in cui si lascia travolgere dai suoi stessi disastri, dalle conseguenze delle proprie scelte. Non accetta di aver sbagliato, di sbagliare. E’ molto severo, duro con se stesso e nello stesso tempo poco riflessivo anche se non se ne rende conto.
Noi ci ricongiungiamo, più tardi, quando Joannin raggiunge la consapevolezza che per liberarsi dalle angosce che lo attanagliano, che popolano le sue notti, deve cercare da solo, ancora una volta, la via d’uscita fuori dai quei labirinti mentali, una nuova strada.
Mentre scrivevi questo romanzo, avevi in mente qualche autore di riferimento, qualche classico italiano o straniero?
No, nessuno. Seguivo una mia voce interiore, tutta mia, solo mia. Percorrevo la mia strada. L’unica, la sola che infine mi ha portato alla meta.
Come racconteresti la tua esperienza di scrittrice?
Non per essere modesta ma è una parola grande.
Tuttavia volendo assecondarla è una esperienza che vorrei non finisse mai.
Quella appena fatta con Joannin è stata un insieme di gioia, soddisfazioni, ma anche di tormenti.
Ci sono stati giorni in cui scrivevo e scrivevo senza, oserei dire, fermarmi mai. Le idee si accavallavano, le dita sulla tastiera s’incrociavano. Sbagliavo. Dovevo correggere e mi arrabbiavo perché così perdevo il filo. Poi decidevo di non correggere, l’avrei fatto dopo. E così andavo, andavo, non sapevo come, se bene, se male, ma neppure me lo chiedevo tanta era la frenesia di buttar giù quel mare o quel miscuglio di roba che avevo in testa.
Quando i giorni della frenesia si placavano, continuavo a scrivere il mio romanzo con studiata calma in attesa di quell’idea che sapevo, solo scrivendo, sarebbe arrivata all’improvviso. Era la scintilla che accendeva la pagina per dare luce al personaggio sul palcoscenico del momento.
Non sono mancati i momenti in cui mi sarei arresa perché di pagine bianche, che non volevano farsi scrivere, ce ne sono state molte. In modo particolare alla fine di ogni capitolo, o subito dopo che ti inviavo correzioni e aggiornamenti.
Rimanevo, allora, lì ferma, davanti al computer a chiedermi:
“E adesso? Cos’è che devo scrivere? Come continuare questa storia? Di che cosa ha bisogno Joannin?”
Osservavo il cielo, come se mi aspettassi di trovare stampata lassù la risposta. È così, per esempio, che è nato questo paragrafo, guardando fuori, era gennaio, la neve cadeva.
Si fermò a un lato della strada ad ammirare il mondo ricoprirsi di bianco. La neve attutì lo scalpiccio degli uomini della milizia che camminavano dietro di lui. Joannin guardava verso il basso, quando accanto alla bicicletta, vide un paio di stivali sporchi di terra bagnata. Ne vide un altro macchiato di bianco. Per Joannin, l’insostenibile leggerezza, purezza di quei minuscoli cristalli di ghiaccio assumeva, su quegli uomini, una connotazione immorale. Innaturale.
Scrivere è una esperienza che dà e toglie molto. Isola. Spesso bisogna dire di no a una gita già programmata. Non cogliere un invito. Prendere una telefonata e dire:
“Non posso, sto scrivendo.”
“Uffa” la risposta.
“Non posso” insisto il giorno dopo.
“Perché, cosa stai facendo?”
“Sono al pc” adesso dico, perché vedo che lo si accetta meglio.
Capita di dovermi alzare all’alba perché mi è venuto in mente che quella frase, scritta così, non va bene e la devo subito aggiustare, oppure aggiungerne un’altra. Ma bisogna farlo adesso, non dopo, al risveglio, quando bella e rilassata ho fatto pure la colazione. Non sarei contenta di non sapere più qual era il sentire, la parola così particolare che tanto nella notte mi piaceva.
Male o bene che si scriva, la scrittura è tiranna. Ti vuole o ti vorrebbe sempre al suo cospetto. Se le dai retta, mangi male e senza regole, sbocconcelli un panino mentre tamburelli sulla tastiera con accanto un bicchiere d’acqua. No, non esagero. La scrittura è anche solitudine.
Per me è stato così, ed è tuttora così solo che adesso ho imparato o sto cercando ad imparare a seguire dei ritmi scadenzati, ma è dura. Per chi ama scrivere, o forse per chi non sa ancora scrivere, è molto più semplice e naturale essere schiavi della scrittura, che è la loro despota.
Nel momento in cui percepisco di aver scritto una bella pagina, la soddisfazione che sento scendere dalla testa fino agli occhi, alla gola, ai polmoni, rilassa come avessi appena assunto un introvabile calmante, fa sì che ogni altra mansione, impegno, rapporto sia facile e leggero.
Tuttavia, a onor del vero, questo non capita spesso, ma quando avviene regala una sensazione che vorrei durasse per sempre.
Ti piace di più leggere o scrivere? Preferisci perderti nelle storie scritte da altri, oppure inventarne di tue?
Al momento mi piace più scrivere romanzi. Non vado pazza per la mia autobiografia anche se la maggioranza dei miei personaggi parla un po’ di me sotto mentite spoglie.
Ciò che più mi affascina, invece, è la qualità della scrittura.
La genialità di alcuni scrittori che con la parola scritta riesce a disegnare quadri, a mostrare i volti dei protagonisti, a far sentire il rumore dei loro passi, lo scoppio delle bombe o riesce perfino a illuderti di trovarti alla luce della luna piena mentre è mezzogiorno, mi lascia spesso senza fiato e a pensare. Mi tocca profondamente.
Le storie le leggo, anzi, le studio, per tentare d’ imparare come si costruisce un romanzo. Tentativo spesso vano, ed ecco che qui entri in gioco tu che mi fai capire dove manco, e mi insegni come aggiustare il tiro. A non liquidare con due righe, idee e analisi di per sé complesse, oppure a non protrarmi su argomenti già stabiliti.
Hai vissuto a lungo fuori dall’Italia, so che stai scrivendo una storia ambientata in Australia, cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Pensare all’Australia significa richiamare alla mente tante storie, personali e non che confluiscono in una sola che ha un unico obbiettivo.
Immagina il delta formato dai fiumi che corrono verso lo stesso mare, così é la mia storia. Ogni storia australiana confluisce con quelle di milioni di immigrati per canalizzarsi in altrettante storie che sono fiumi con una sola meta: il mare. Il mare del benessere economico e sociale. Il mare dell’ordine, dell’organizzazione, della disciplina, del materialismo dentro a un mare di spazio.
In Australia, come scrivo in queste nuove pagine, si sente il profumo della libertà. Io l’ho conosciuto. L’ho respirato il giorno stesso che sono scesa dall’aereo all’aeroporto di Adelaide. È un profumo che pur non avendolo mai sentito prima lo si riconosce forse perché è rimasto impresso nell’atavica memoria delle cellule, non so. Di scienza non me ne intendo, ma so che esiste perché io l’ho potuto sentire, odorare.
L’Australia non ti lascia mai, è sempre dentro di te. Possono passare secoli, ma che tu sia nato australiano o che tu lo diventi attraverso le pratiche burocratiche, sarai per sempre, nel bene e nel male, segnato da quella terra, dalla sua cultura nello stesso modo in cui la tua terra ti rende diverso da chi è nato altrove.
Dal momento che diventi australiano, specie se immigrato, stenterai a capire esattamente che cosa sei, a quale terra appartieni di più e per davvero.
Dapprima non ti poni la questione. Poi inizi a chiedertelo, quindi lo fai sempre più spesso senza sapere cosa risponderti perché quando canti Waltzing Matilda sei australiano purosangue. Quando ti trovi davanti al cioccolatino Bacio, hai l’acquolina in bocca e non per quella nocciolina in cima a quel bon bon, ma perché adesso sei italiano, e stai lì fermo a pensare alla tua gente, al tuo paesello. Quello sì che è un gran bel guaio di ricordi incancellabili, di emozioni, di addii che ti porta ad aprire la porta del negozio e a salutare con un “good bye” ben educato, un good bye australiano.
Adesso sai la confusione che nasce da una relocation come la chiamano oggi. Nessuno ne parla però. Pochi ne parlano. I problemi per gli australiani sono altri. Quello più risaputo è non sapere di non averne. Quindi perché parlarne? Presto o tardi gli immigrati faranno figli ad agire da barriera, a spezzare irrimediabilmente i passe-partout del promesso, ambito, ritorno in patria.
Per me che sono riuscita ad abbattere quella barriera, a procurarmi nuovi passe-partout, e rientrare quindi in Italia e viceversa, essere italo- australiana ha significato, per lungo tempo, trovarmi a viaggiare contemporaneamente su due binari paralleli. Con i piedi mi trovavo su di uno e con la testa su quell’altro. Ti chiederai forse come abbia fatto a vivere in una dicotomia di quel tipo, continua e stridula. Come l’abbia risolta, se l’ho risolta.
Raccontarti come abbia fatto a viverla è complicato, significherebbe riuscire a trasmetterti la portata di conflitti e dualismi che si nascondevano nel quotidiano, che non si mostravano, significherebbe parlarti del brutale risveglio.
Ti posso dire però che per risolverla, non esiste altro modo che affrontarla in maniera concreta, tangibile, sapendo di rischiare di perdere l’orientamento.
Nel momento in cui riconosco nuovamente il punto cardinale Nord, e tiro un sospiro di sollievo, me ne sto lì a guardare, ad ammirare l’oceano Pacifico, le sue gigantesche onde e gli spumosi flussi, con altri occhi e provo emozioni nuove. Per quanto quella terra mi rimarrà per sempre dentro, so che sono italiana, solo italiana, sento la mia italianità avvolgermi dappertutto, ce l’ho sotto la pelle e oltre.
Credo tuttavia che la maggioranza degli immigrati italiani, pur collegandosi con la RAI ogni mattina, pur anelando di vedere le competizioni di Miss Italia, pur assistendo a tutte le trasmissioni in mondo visione, Santa Messa inclusa, e nonostante quella lacrimuccia sempre appesa sulle ciglia, si ritenga felice.