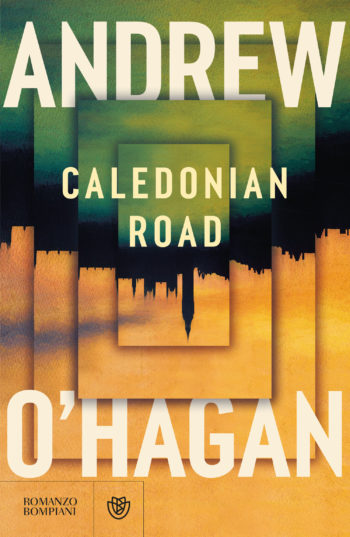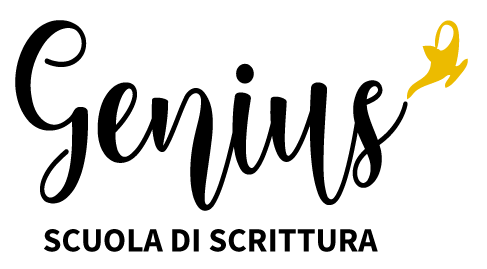Andrea Carraro, scrittore, nasce a Roma. Se avesse ricevuto un euro ogni volta che sui media hanno usato il termine “il branco” per parlare di uno stupro di gruppo, citando il titolo del suo romanzo più noto, oggi sarebbe ricco. Invece è “solo” uno scrittore tra i più bravi. Romanziere, autore di racconti e di poesie, nasce a Roma nel 1959. Ha pubblicato i romanzi:
A denti stretti (Gremese, 1990),
Il branco (Theoria, 1994), diventato un film di Marco Risi,
L’erba cattiva (Giunti, 1996),
La ragione del più forte (Feltrinelli, 1999),
Non c’è più tempo (Rizzoli, 2002) (Premio Mondello),
Il sorcio (Gaffi, 2007),
Come fratelli (Melville, 2013),
Sacrificio (Castelvecchi, 2017) e le poesie narrative
Questioni private (Marco Saya, 2013). Ha pubblicato anche due raccolte di racconti, confluite nel volume
Tutti i racconti (Melville
, 2017). I suoi giudizi critici, sensibili ma affilati quando serve, lo rendono un lettore del cui parere fidarsi con tranquillità.