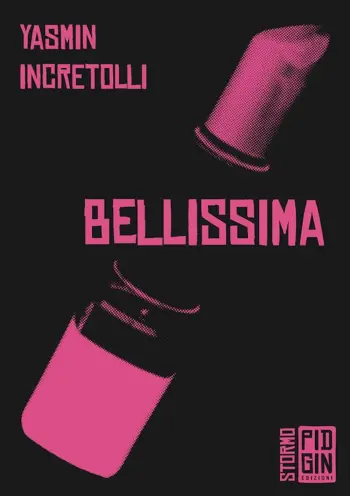Le vie attraverso le quali scopriamo un autore o un libro sono spesso fortuite: una copertina o un titolo sullo scaffale di una libreria, una trasmissione radiofonica, il consiglio di un amico, l’inserto culturale di un giornale, ecc… Ed è alle volte proprio da queste vie fortuite che nascono delle affascinanti scoperte che rendono la vita del lettore avventurosa come quella di un esploratore. Recentemente mi è capitato di assistere a uno spettacolo teatrale (Un momento difficile) di un autore, Furio Bordon, del quale, pur essendo mio concittadino, non avevo sentito parlare se non come direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Ho trovato lo spettacolo talmente avvincente che sono andato a cercarmi tutte le opere di questo autore e mi sono imbattuto in un romanzo, Il canto dell’orco (pubblicato per la prima volta da Longanesi nel 1985 e edito di nuovo da Sellerio nel 2007), che ho messo in valigia, assieme ad altri libri, partendo per le ferie. Gli ozii balneari non sono salutari se non si accompagnano a un adeguato distacco dalla quotidianità. Così, cullato dalla risacca e dal canto delle cicale, ho cominciato le mie letture proprio con questo romanzo non recentissimo, scoprendone il fascino e l’attualità. In questi anni, nei quali si tende a considerare superate certe antinomie ideologiche (destra-sinistra, fascismo-antifascismo, nazionalismo-internazionalismo, segregazione-integrazione) e a invocare un generico buon senso comune per risolvere i problemi questo libro è un utile strumento di riflessione. L’autore stesso definisce molto appropriatamente il romanzo un “noir morale”, suggerendoci una lettura critica su una vicenda di truci delitti commessi in tempo di guerra (ma anche di pace) sulla spinta di ideali come la fedeltà alla patria o di pulsioni primordiali come il bisogno di vendetta e di giustizia sommaria.
Il libro ci insegna, più che a riconoscere la “banalità del male”, per dirla alla Hannah Harendt, a smascherare i pericoli di un vitalismo apparentemente sano, sensato e genuino ma di fatto morboso, ottuso e ambiguo. Il codice comportamentale che guida Martino, l’orco cui si riferisce il titolo del romanzo, si basa su di un sommario e barbaro giustizialismo che punisce nel sangue ogni trasgressione di quei valori di lealtà e di fedeltà che, svuotati della loro dimensione umana, diventano solo degli astratti principii – nella migliore accezione cavallereschi, nella fattispecie più propriamente tribali – da difendere in quanto tali.
Martino, detto anche il “boia di Cavalta”, è un omaccione violento e istintivo, un orco appunto, che è stato condannato e poi amnistiato per un atroce delitto commesso durante la seconda guerra mondiale dopo aver aderito alle SS italiane in segno di fedeltà a Mussolini ed agli alleati tedeschi. Uccide uno per uno, con un colpo di pistola alla nuca, cinquanta civili di un paesino (Cavalta appunto) delle Alpi Apuane, che sono stati catturati per rappresaglia. Il destino di Martino si incrocia con quello di Luca Simoni, giovane e promettente giornalista di cronaca nera in perenne caccia di scoop, in occasione della morte misteriosa (suicidio o omicidio?) di Francesca, la donna di cui Martino è innamorato e che questi, in un macabro delirio di possesso, veglia per mesi dopo la sua morte in una casupola sul litorale laziale. Luca subisce il fascino dell’orco Martino, condividendone le peripezie di latitante, anche dopo un altro delitto da lui commesso, quello di uno psichiatra, il dottor Ferroni, che aveva ricoverato Francesca nella propria clinica per curarla di una grave forma di depressione e l’aveva messa incinta per poi dimetterla precocemente nonostante un tentativo di suicidio che lei aveva commesso durante il ricovero. Ed è qui, in questa fascinazione ambigua e morbosa, che risiede, a mio avviso, l’attualità del libro. L’orco Martino, una volta conosciuto da vicino, rivela aspetti che mal si accordano con la sua fama di “boia fascista” e che portano Luca a dubitare dei suoi delitti, perfino di quelli per cui è stato già condannato. Le indagini del giornalista, che prendono gradualmente la forma di un’ostinata e disperata ricerca di elementi per attenuare le responsabilità di Martino, lo porteranno a entrare in contatto con numerose figure, tra cui Anna, la figlia di primo letto di Francesca, che è sempre stata la principale accusatrice dell’“orco”, responsabile di aver sedotto, portato via e corrotto sua madre, un senatore, già esponente di rilievo della Repubblica di Salò, un ex-professore di Martino e alcuni suoi ex-compagni di scuola, tra cui un ebreo, soprannominato “Tegolino” che, fidandosi dell’amicizia e della protezione che Martino gli aveva sempre dato, era finito in trappola ed era stato deportato nel campo di concentramento di Dachau. Da queste testimonianze, dalle indagini che Luca compie a Cavalta, dalla convivenza sempre più stretta con Martino, condotta fino alle soglie di una colpevole complicità, emerge un ritratto sempre più ambiguo dell’orco. Succede allora al lettore di avere di fronte una di quelle figurine di plastica zigrinata nelle quali un leggero cambiamento dell’angolo visuale modifica radicalmente l’immagine percepita. Così l’esecuzione sommaria e crudele dei cinquanta civili di Cavalta si trasforma in un atto misericordioso per delle persone che erano già state sottoposte alla tortura di una morte lenta per strozzamento, l’uccisione del primario diventa la comprensibile (anche se legalmente e umanamente inaccettabile) vendetta per un crimine commesso ai danni della persona amata da parte di un uomo arrogante che approfitta della propria posizione di potere, la morte di Francesca assume le sembianze di un suicidio. A queste interpretazioni assolutorie conducono anche certi aspetti della personalità di Martino, dai quali Luca viene suggestionato: la sua devozione assoluta alla memoria dell’amata perduta, la sua inclinazione al pianto, le sue velleità poetiche che lo portano a dettare a Luca in uno stile retorico e sentimentalistico una sorta di memoriale per Francesca, nel quale lui, oltre a dar sfogo ai propri sentimenti, espone le proprie argomentazioni auto-assolutorie.
Da tutto questo emerge un relativismo, che però è solo apparente, in quanto le responsabilità storiche restano oggettive, inappellabili, immuni da ogni revisionismo. Non c’è alcun tentativo di annacquarle con argomentazioni umane e psicologiche, che finiscono sempre per fornire un alibi a tutto e che rischiano di avvicinarci in modo empatico, acritico e pertanto pericoloso proprio a quelle personalità che per loro natura (impulsività, semplicità, sicurezza di giudizio, facilità alle decisioni, sentimentalismo, retorica) sono dotate di un grande ascendente.
Naturalmente nel libro c’è molto altro. Ci sono gli intrecci, le atmosfere, le emozioni, gli orrori di un vero noir, la ricchezza di vicende, la varietà di ambienti e personaggi, la velocità d’azione di un romanzo d’avventure e, non da ultimo, il resoconto toccante di una crisi esistenziale, quella di Luca, che, andando alla ricerca di una verità ultima delle cose, si abbandona ad una sorta di regressione adolescenziale. Belle in proposito le pagine in cui Luca si unisce nella latitanza a Martino ed alla sua nuova compagna Christiane. È un idillio vissuto nella campagna lucana tra bevute, canti e recite di Christiane, sedute di pesca, nuotate nell’acqua fresca di uno stagno, passeggiate tra gli ulivi; un idillio nel quale la regressione liberatoria e deresponsabilizzante di Luca raggiunge il culmine.