
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

È parte del mio lavoro di editor selezionare pagine letterarie dalle quali prendere ispirazione, soprattutto quando devo leggere in aula qualcosa che possa dare una scossa agli autori che curo. Ma in realtà è un mio vecchio pallino: sto ancora cercando la pagina perfetta, la pagina che racchiuda tutto il senso dell’esistenza.
Questa settimana mi è venuto in mente Il deserto dei Tartari, riflettendo sull’attesa di un destino eroico. È proprio quello che succede al tenente Giovanni Drogo, il protagonista del romanzo di Dino Buzzati. In questo brano, dove il massimo è espresso con il minimo, l’inizio della consapevolezza si accende nella testa del tenente Drogo e nella nostra testa di lettori.
Buona lettura.
Il deserto dei Tartari
Cap VII
Giunse finalmente dalla città la cassa con i vestiti del tenente Drogo. Fra l’altro c’era un mantello nuovissimo, di straordinaria eleganza. Drogo lo indossò e si guardò pezzo a pezzo nel piccolo specchio della propria stanza. Gli parve quello un vivo collegamento con il suo mondo, pensò con soddisfazione che tutti lo avrebbero guardato, tanto splendida era la stoffa, fiero il panneggiamento che ne risultava.
Pensò che non doveva sciuparlo per il servizio di fortezza, nelle notti di guardia, fra le umide mura. Era anche di malaugurio metterlo lassù, per la prima volta, quasi ad ammettere ch’egli non avrebbe avuto occasioni migliori. Pure gli dispiaceva di non farlo vedere in giro e, benché non fosse freddo, volle indossarlo almeno per andare fino dal sarto del reggimento, da cui ne avrebbe comperato un altro di tipo comune.
Lasciò quindi la camera e si avviò giù per le scale, osservando, dove la luce lo permetteva, l’eleganza della propria ombra. Tuttavia, man mano ch’egli scendeva nel cuore della Fortezza, il mantello sembrava perdere in qualche modo il suo primo splendore. Drogo inoltre si accorse che non riusciva a portarlo con naturalezza; gli pareva una cosa strana, da dare nell’occhio.
Ebbe perciò piacere che le scale e i corridoi fossero quasi deserti. Un capitano che finalmente incontrò rispose al suo saluto senza uno sguardo in più del necessario. Neppure i rari soldati voltavano gli occhi a osservarlo.
Scese per una angusta scaletta a chiocciola, tagliata nel corpo di una muraglia, e i suoi passi risuonavano di sopra e di sotto come ci fosse altra gente. Le preziose falde del mantello battevano, oscillando, sulle bianche muffe dei muri.
Drogo giunse così ai sotterranei. Il laboratorio del sarto Prosdocimo era appunto allogato in una cantina. Uno spiraglio di luce scendeva, nelle giornate buone, da una piccola finestretta al livello del suolo, ma quella sera avevano già acceso i lumi.
«Buonasera, signor tenente» disse Prosdocimo, il sarto reggimentale, appena lo vide entrare. Nello stanzone solo alcuni piccoli tratti erano illuminati: un tavolo dove un vecchietto scriveva, il banco dove lavoravano tre giovani aiutanti. Tutt’attorno pendevano flosci, con sinistro abbandono da impiccati, decine e decine di uniformi, pastrani e mantelli.
«Buonasera» rispose Drogo. «Vorrei un mantello, un mantello da non spendere molto, vorrei, basta che duri quattro mesi.»
«Mi lasci vedere» disse il sarto con un sorriso di curiosità diffidente, prendendo un lembo del mantello di Drogo e traendolo verso la luce; egli era di grado maresciallo ma la sua qualità di sarto pareva concedergli di diritto una certa ironica familiarità coi superiori. «Bella stoffa, bella… l’avrà pagata un occhio, immagino, laggiù in città non scherzano» diede un’occhiata complessiva da uomo del mestiere, scosse il capo facendo tremolare le guance piene sanguigne «peccato però…»
«Peccato che cosa?»
«Peccato che il collo sia così basso, è poco militare.» «Si usa così adesso» fece Drogo con superiorità.
«La moda vorrà il collo basso» disse il sarto, «ma per noi militari la moda non c’entra. La moda ha da essere il regolamento e il regolamento dice “il collo del mantello stretto al collo, foggiato a cintura, alto centimetri sette”. Lei forse crede, signor tenente, che io sia un sartucolo da poco, a vedermi in questo buco.»
«Perché?» fece Drogo. «Tutt’altro, anzi.»
«Lei probabilmente crede che io sia un sartucolo da poco. Molti ufficiali invece mi stimano, anche in città, e ufficiali di riguardo. Io sono quassù in via as-so-Iu-ta-mente prov-vi-so-ria» e scandì le due ultime parole come premessa di grande importanza.
Drogo non sapeva che cosa dire.
«Da un giorno all’altro io aspetto di partire” continuava Prosdocimo. «Se non fosse per il signor colonnello che non vuole lasciarmi andare… Ma che cosa avete voialtri da ridere?»
Nella penombra infatti si era sentito il riso soffocato dei tre aiutanti; adesso avevano chinato la fronte, esageratamente intenti al lavoro. Il vecchietto continuava a scrivere, facendo parte a se stesso.
«Che cosa c’era da ridere» ripeté Prosdocimo. «Siete dei tipi un po’ troppo svelti voi. Un giorno o l’altro ve n’accorgerete.»
«Già» disse Drogo «che cosa c’era da ridere?»
«Sono degli stupidi» disse il sarto. «È meglio non badarci.»
In quel momento si udì un passo scendere dalle scale e comparve un soldato. Prosdocimo era chiamato di sopra, dal maresciallo del magazzino vestiario. «Mi scusi, signor tenente» fece il sarto. «È una faccenda di servizio. Fra due minuti sono di ritorno.» E seguì il soldato di sopra.
Drogo si sedette preparandosi ad aspettare. I tre aiutanti, partito il padrone, avevano interrotto il lavoro. Il vecchietto finalmente levò gli occhi dalle sue carte, si alzò in piedi, si avvicinò zoppicando a Giovanni.
«L’ha sentito?» gli chiese con strano accento, facendo un segno ad indicare il sarto che era uscito. «L’ha sentito? Sa, signor tenente, da quanti anni è qui alla Fortezza?»
«Mah, non saprei…»
«Quindici anni, signor tenente, quindici maledettissimi anni, e continua a ripetere la solita storia: sono qui in via provvisoria, da un giorno all’altro aspetto…»
Qualcuno borbottò al tavolo degli aiutanti. Doveva essere quello il loro abituale oggetto di riso. Il vecchietto non ci badò nemmeno.
«E invece non si muoverà mai» disse. «Lui, il signor colonnello comandante e molti altri resteranno qui fino a crepare, è una specie di malattia, stia attento lei, signor tenente, che è nuovo, lei che è appena arrivato, stia attento finché è in tempo…»
«Stare attento a che cosa?»
«Ad andarsene appena può, a non prendere la loro mania.»
Drogo disse: «Io sono qui per quattro mesi soltanto, non ho la minima intenzione di rimanere».
Il vecchietto disse: «Stia attento lo stesso, signor tenente. Ha cominciato il signor colonnello Filimore. Si preparano grandi eventi, ha cominciato a dire, me lo ricordo benissimo, saranno diciotto anni. Proprio “eventi” diceva. Questa è la sua frase. Si è messo in mente che la Fortezza è importantissima, molto più importante di tutte le altre, che in città non capiscono niente».
Parlava adagio, tra una parola e l’altra faceva in tempo ad insinuarsi il silenzio.
«Si è messo in mente che la Fortezza è importantissima, che deve succedere qualcosa.»
Drogo sorrise. «Che succeda qualcosa? Vuol dire una guerra?»
«Chi lo sa, può darsi, anche una guerra.»
«Una guerra dalla parte del deserto?»
«Dalla parte del deserto, probabilmente» confermò il vecchietto.
«Ma chi? chi dovrebbe venire?»
«Cosa vuole che io ne sappia? Non verrà nessuno, si capisce. Ma il signor colonnello comandante ha studiato le carte, dice che ci sono ancora i Tartari, dice, un resto dell’antico esercito che scorrazza su e giù.»
Nella penombra si udì un ghignare ebete dei tre aiutanti. «E sono ancora qui che aspettano» proseguì il vecchietto. «Guardi il signor colonnello, il signor capitano Stizione, il signor capitano Ortìz, il signor tenente colonnello, ogni anno ha da succedere qualcosa, sempre così, fino a che li metteranno a riposo.» Si interruppe, piegò la testa da un lato come per ascoltare. «Mi pareva di sentire dei passi» disse. Ma non si udiva nessuno.
«Non sento niente» fece Drogo.
«Anche Prosdocimo!» disse il vecchietto. «È semplice maresciallo, sarto reggimentale, ma si è messo con loro. Anche lui aspetta, sono già quindici anni… Ma lei non è persuaso, signor tenente, lo vede, lei sta zitto e pensa che sono tutte storie.» Aggiunse, quasi supplichevole: «Stia attento, le dico, lei si lascerà suggestionare, anche lei finirà per restare, basta guardarlo negli occhi», Drogo taceva, gli pareva indegno di un ufficiale confidarsi con un così povero uomo.
«Ma lei» disse «e lei cosa fa allora?»
«Io?» fece il vecchietto. «Io sono suo fratello, sto qui a lavorare con lui.»
«Suo fratello? Suo fratello maggiore?»
«Già» il vecchietto sorrise «fratello maggiore. Anch’io ero militare una volta, poi mi sono rotto una gamba, sono ridotto a questo.»
Nel silenzio sotterraneo Drogo allora sentì i colpi del proprio cuore che si era messo a battere forte. Dunque anche il vecchietto rintanato nella cantina a fare conti, anche quell’oscura e umile creatura aspettava un destino eroico? Giovanni lo fissava negli occhi e l’altro scosse un poco la testa con amara mestizia, come a significare di sì, che non c’era proprio rimedio: cosi siamo fatti – pareva dire – e mai più guariremo.
Forse perché in qualche parte delle scale era stata aperta una porta, adesso si udivano, filtrate dai muri, lontane voci umane di indeterminabile origine; ogni tanto cessavano lasciando un vuoto, poco dopo riaffioravano ancora, andavano e venivano, come lento respiro della Fortezza.
Ora Drogo finalmente capiva. Egli fissava le ombre multiple delle uniformi appese, che tremolavano all’oscillare dei lumi e pensò che in quel momento preciso il colonnello, nel segreto del suo ufficio, aveva aperto la finestra verso il nord. Era certo: in un’ora così triste come quella per il buio e l’autunno, il comandante della Fortezza guardava verso il settentrione, verso le nere voragini della valle.
Dal deserto del nord doveva giungere la loro fortuna, l’avventura, l’ora miracolosa che almeno una volta tocca a ciascuno. Per questa eventualità vaga, che pareva farsi sempre più incerta col tempo, uomini fatti consumavano lassù la migliore parte della vita.
Non si erano adattati alla esistenza comune, alle gioie della solita gente, al medio destino; fianco a fianco vivevano con la uguale speranza, senza mai farne parola, perché non se ne rendevano conto o semplicemente perché erano soldati, col geloso pudore della propria anima.
Forse anche Tronk, probabilmente. Tronk inseguiva gli articoli del regolamento, la disciplina matematica, l’orgoglio della responsabilità scrupolosa e si illudeva che ciò gli bastasse. Pure se gli avessero detto: sempre così fino che vivi, tutto uguale fino in fondo, anche lui si sarebbe svegliato. Impossibile, avrebbe detto. Qualche cosa di diverso dovrà pur venire, qualche cosa di veramente degno, da poter dire: adesso, anche se è finita, pazienza.
Drogo aveva capito il loro facile segreto e con sollievo pensò di esserne fuori, spettatore incontaminato. Fra quattro mesi, grazie a Dio, egli li avrebbe lasciati per sempre. Gli oscuri fascini della vecchia bicocca si erano ridicolmente dissolti. Così pensava. Ma perché il vecchietto continuava a fissarlo e con quell’espressione ambigua? Perché Drogo sentiva il desiderio di fischiettare un poco, di bere vino, di uscire all’aperto? Forse per dimostrare a se stesso di essere veramente libero e tranquillo?

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
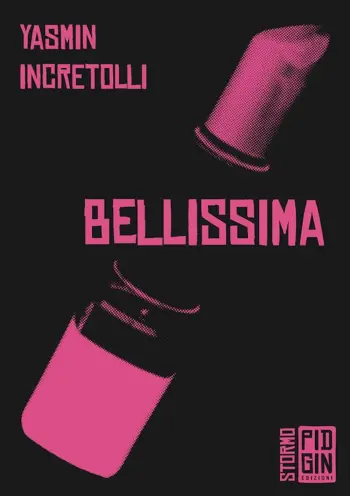
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare