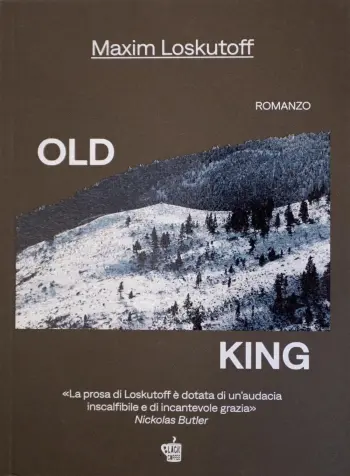Bisogna pensarci cento volte prima di fare la scelta di usare il dialetto!
Il mio consiglio è usarlo solo se è davvero necessario. Grazie al cazzo, direte voi, i più raffinati, ma chi la stabilisce quella necessità? Siamo noi, siamo sempre noi a decidere, io posso dirvi il mio criterio. Perché ogni scrittore ha il suo. Io l’ho sempre usato – il dialetto romanesco più o meno sporco e contaminato – non solo nel Branco, anche in altri racconti o reportage di ambientazione popolare, in una chiave soprattutto morale, per raccontare la violenza, la brutalità, spesso sostitutiva della violenza fisica reale, che tendevo invece a sottrarre all’attenzione morbosa del lettore, a nascondere (non amo la violenza troppo esibita, lo splatter!). La lingua dialettale può essere molto aggressiva, offensiva, lesiva, come un’arma, se usata in un certo modo… E nella violenza di gruppo del Branco verso le due ragazze tedesche violentate questa violenza del linguaggio era eclatante. A tal punto che nel film in alcuni casi dovemmo smorzarla già in sceneggiatura, certe parole che erano presenti nel romanzo sparirono… Per esempio, le bestemmie sono state eliminate in fase di sceneggiatura. L’argomento, il contesto, erano già di loro scandalosi e non conveniva esagerare. Anche per non incorrere in problemi di censura. Già così fu vietato ai 14 anni.
Nelle ambientazioni borghesi e piccoloborghesi ho usato invece una lingua media, con qualche rara intonazione dialettale in occasioni di scontri, litigi, violenze (vedi il mobbing del Sorcio)… quindi per me ha avuto sempre una funzione che ho definito morale, dicevo, il dialetto romanesco borgataro. Ma esso può servire anche in una chiave diversa, più espressionistica, ritmica, musicale, per così dire. Pensiamo a Gadda, e al suo Pasticciaccio, al suo virtuosismo linguistico e sintattico, al suo “barocchismo” – come qualcuno lo ha definito – fondato sull’uso di più livelli di scrittura (dal dialetto popolare, ai termini arcaici, manzoniani, fino all’invenzione di vocaboli), oppure pensiamo a Pasolini, che reinventa poeticamente il linguaggio dei suoi borgatari ragazzi di vita. Sentite come lo spiega bene Pasolini. “Nella letteratura, – scriveva Pasolini, che come forse saprete era anche un grande critico letterario –, il dialetto può entrare a incastro, a inserzione, a reagente, con due diverse funzioni: una che potremmo chiamare soggettiva, e un’altra oggettiva”. Del primo caso abbiamo un esempio così tipico e clamoroso, che basta da solo a colmare un piatto della bilancia. È il caso di Carlo Emilio Gadda… nella mimetizzazione del suo monologo interiore: chi monologa è Gadda. …Gadda s’impossessa con una vorace zampata di un brandello di anima dialettale-realistica e la schiaffa sanguinolenta e piccante nel mosaico. L’altro caso, quello a funzione oggettiva… comprende la produzione neorealistica, ed è di origine e forma interna verghiana… Da ciò risulta chiara la sua funzione oggettiva: il calarsi cioè dell’autore al livello del suo oggetto”.
Credo che non si debba aggiungere altro. Se volete fare un esercizio utile, provate a raccontare qualcosa – un pranzo in trattoria fra due o tre amici, una serata in discoteca, una pausa caffè al lavoro –, usando, nei dialoghi, il dialetto del vostro luogo, del luogo dove vivete, e poi una seconda versione in italiano, e confrontate le due versioni, e vedete quale vi convince di più. Alla prossima.