
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

Dire il proprio nome significa dare a chi lo ascolta un potere su di te. Per questo Annis/Arese, non rivela il suo nome vero, lasciando che il mondo emerso la chiami con la versione anglicizzata in Annis. Ed è solo sua madre che la chiama, in disparte, con il suo nome segreto. Nipote di una guerriera amazzone africana e frutto di uno stupro, Annis vive con la madre nella piantagione del padre, che chiama sire, in Carolina, e appena può, ascolta le lezioni impartite dal precettore alle sue sorellastre. Quando ascolta le terzine dell’Inferno di Dante, Annis sente una profonda affinità con la sua vita oscura, che assume i colori densi e perturbanti del sangue rappreso quando la madre viene venduta, destinazione New Orleans. Di lei non avrà più notizie. Non passa molto tempo, forse una stagione o due e il padre, infastidito dal suo legame con un’altra ragazza, anche lei schiava, le vende entrambe. Ancora New Orleans. La città dei vivi, la città dei morti, e di quelli che stanno in mezzo, come le rivela lo spirito dell’acqua che assume il nome di sua nonna Aza, sopravvissuta alla traversata dall’Africa alle coste americane. Di quel viaggio, e della sua permanenza a New Orleans, trattata ovunque come un oggetto, utile come un animaletto, o rivalutata per la sua conoscenza delle erbe officinali e le loro proprietà curative, Annis/Arese vivrà, quasi in parallelo con il viaggio di Dante, una discesa agli inferi, nel cieco mondo, privo di speranza.
Il suo legame con il mondo e la natura la salverà dalla follia, dalla cattiveria e dallo strapotere di chi pensa, come se fosse un diritto, di poter disporre di vita e sentimenti di altre persone. Le ragazze più carine e Annis, frutto di mescolanza razziale, lo è, rischiano di essere destinate ai bordelli, ed è la sua familiarità con lo spirito che vede il futuro a farla decidere di tirare fuori la sua abilità come erborista e a farsi scegliere da una donna depressa, autoritaria e patologicamente gelosa del marito fedifrago. Ai margini della piantagione dove sarà condotta vivono gli schiavi che sono riusciti a fuggire, tra alligatori e foresta inospitale, altra metafora del cieco mondo che, come l’inferno fatto a cono rovesciato, offre, all’improvviso e dopo la perdita di ogni sicurezza conosciuta, una forma peculiare di libertà. Il cielo che si vede tra gli alberi e che lascia filtrare la prima luce, dopo la notte più difficile mai vissuta.
Il lirismo del linguaggio usato dall’autrice fa da contraltare alla brutalità esposta e cruda degli schiavisti, personaggi inseriti nel loro tempo e nella loro pelle di sopraffattori, convinti che infliggere lavori pesanti e punizioni umilianti fosse un dovere per la correzione dei prigionieri. Esiste infatti qualcosa di peggio della privazione della libertà ed è la perdita dell’identità, dei legami con chi è venuto prima di te. Per questo ogni colonizzatore vieta la lingua originaria dei sottomessi, perché il linguaggio è potere, è la rivendicazione ultima di chi, privato di ogni diritto sul proprio corpo e sui propri figli, mantiene integro almeno quello con il proprio passato e i propri pensieri.
“La prima arma che ho mai impugnato è stata la mano di mia madre. Ero piccola allora, avevo la pancia morbida. Quella notte mia madre mi ha svegliata e portata nei boschi della Carolina, sempre più in fondo tra gli alberi che mormoravano, neri per il congedo del sole. Lontano dal mio sire, che è bianco quanto mia madre è nera. Lontano da quell’uomo che dice di essere il nostro padrone, da quell’uomo che fa diventare mia madre un filo nero nella trama scura della sua cucina, dove lei trascorre quasi tutte le ore di veglia a lavorare per nutrire lui e le sue figlie panciute e giallastre. Io avevo ossa da uccello, sfioravo appena la spalla di mia madre.
Mia madre mi ha raccontato di come il mio sire l’ha violata. Di come l’ha incontrata da sola in uno dei corridoi ai piani superiori della casa, fuori da una camera da letto vuota. Di come l’ha spinta in quella camera spoglia e l’ha buttata sul pavimento. Di come ha scorticato le sue parti più delicate.
– Vieni – dice lui – toglimi gli stivali.
Lui solleva un braccio, fa per prendermi la testa, i capelli, per attirarmi verso il suo grembo, ma io mi alzo di scatto e corro via prima che possa toccarmi anche un solo capello. Eppure vedo come fissa la mia bocca, i capelli che scendono folti e lucidi, impervi alle trecce, e che hanno i suoi stessi riflessi di rame.
Me li raserei tutti, senza lasciarne neanche uno.“

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
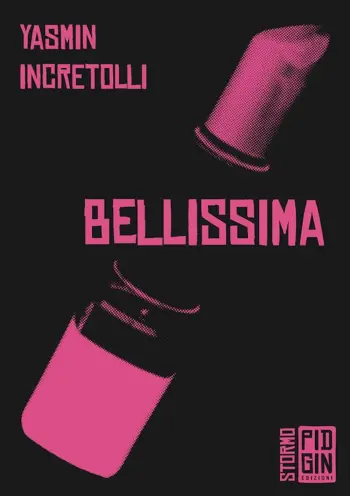
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare