Nessun prodotto nel carrello.

Dentro la lampada
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

È un tempio la finestra
che dà sul cortile interno,
come morta la città dorme,
immota guardo i tetti e il cielo,
il campanile e il gelso,
ricordo il tuo odore
senza sperare, senza sognare,
solo l’immagine sbiadita di te,
una sagoma nell’acqua,
sul presente una croce.
Questi versi compaiono nella raccolta CITTÀ METAFISICHE, l’ultima pubblicata finora da Ilaria Palomba, la sua terza. Ilaria Palomba si divide tra prosa narrativa e poesia, tra blog e ricerche su temi che hanno a che fare con la malattia psichiatrica e il disagio sociale. In realtà non si divide affatto, si distribuisce semmai, e si completa. Attraverso una scrittura che classicamente trova forme e stilemi secondo una variatio che ha tutte le qualità trasformazionali del caso, e soprattutto con una felicità di scrittura, una limpidezza e incisività di dettato che trovo, personalmente, sempre stupefacente. Possiede, Ilaria, una chiarezza di diagnosi, mi verrebbe da dire, che sorprende, però questa esattezza non toglie margine, per esempio, alla sua formulazione poetica – viceversa facilita e rende possibile una porosità della parola che lungi dall’essere un elemento di instabilità o di opacità espressiva rende attuale il transito e il travaso tra piani contigui di significato governati con mano ferma da un IO stabile benché dolente, lucido. L’IO peraltro non rifiuta di farsi plurale e non esita a confrontarsi con un TU con cui appare in una profonda intesa sensibile, che tende a farsi coincidenza, e autorizza a delle invocazioni imperative che hanno l’affettuosità e la carezza dell’invito.
Di questo precipizio, sono giardino
e non ho cura delle foglie,
lascio che franino sulla terra riarsa,
lascio che il vento se le porti.
E sarò vento, porterò con me
le foglie, le lascerò sui bacini di terra,
aspetterò la notte.
Poi si resta soli,
il prima è una fotografia strappata.
Se hai giocato a ucciderti una volta
sai cosa significhi accoglierla.
Cerchi ancora un rifugio
e sei il rifugio
ma ne sei anche l’usurpatore.
Dicevi che questo mio dire
non fosse che lingua
smarrivo l’aurora
tornavo a marcire
coperta di occhi.
Nel gioco del mare
rincorrevo le ore
la pioggia sui passi.
Dicevi partire
svanire fuggire
tra quiete di stanze
vuote nel vespro.
Un sole che brucia
orme sulla sabbia.
Attraversa il silenzio,
il lungomare fino al faro,
voltati a guardare il sole
nelle increspature del mare,
nuvole vermiglie e sabbia
sporca di bottiglie, l’inverno.
Da questa manciata di versi si colgono alcuni aspetti di questo disperante poetare.
Il piano simbolico è molto forte, tende a imporsi, si fa prevalente, predomina. È anche possibile cogliere lo scarto anzi la svolta sottile e fendente cioè quella lama di spazio e di luce in cui accade il miracolo: il tradursi dell’esperienza in quadri di senso e in testi di segno del pensiero sensibile che costruiscono edifici dalla struttura leggera ed elastica, armonici nell’assecondare ogni urto tellurico. La forza che sorregge questi edifici (il loro slancio, la loro tenuta), è tuttavia figlia della stanchezza. Testimonia i traffici inesausti eppure inani di una umanità mai doma benché l’istinto residuo sarebbe di mollare la lotta e di contare e valutare le macerie. Esiste in questa poesia, contemporaneamente, una dimensione complanare: è come assistere a una misteriosa partita a scacchi e seguire una mano che sposta i pezzi con la crudeltà involontaria e indifferibile del destino, maneggiato da una dea ex-machina. C’è dentro il sacro, più che del dolore, del fato – e un teatro, una scena delimitata da muri e sponde, delle quinte tra le quali la tragedia avviene, ed è resa appena opaca dalla prevedibilità del suo accadere. Proprio questo conferisce un diffuso senso di stanchezza. E anche la ribellione a un fato ineludibile, quasi atteso al varco, è lenta, stanca, rassegnata. INANE.
Sono malata, forse?
Al mattino uno spiraglio
poi clausura, siamo
diventati deboli, fiacchi.
Tutti i giorni sono uguali,
stiamo perdendo il senso.
Ci sfugge il coraggio.
Mi sono arresa, forse?
La resa non è una
fuga recente, era
nell’aria da tempo
e adesso viene ad
accecarci.
Mi accarezza le mani,
accarezza i miei
gesti. Nonostante
la ferita, ho ancora
un dono chiuso a chiave.
Le città vuote, surreali,
non sono che rimandi
e il tempo tornerà fecondo
dopo il veleno, un’altra
volta il sole sui campanili.
Che cosa vuol dire coraggio?
Tornare.
Se fossimo simili alla materia
sapremmo riconoscere la luce,
il primo annuncio del giorno.
Io non sono come te,
nella notte annullo ogni gesto
e al mattino ricordo
ferma nella stanza.
Le mille
facce della morte.
Glissandi nel buio.
Muta, voglio risuonare,
melodia antica, indecifrabile stagione
d’assenza.
Ricomponi questo
scheletro che si fa sabbia.
Questi due passaggi sono distanti tra loro più di venti pagine eppure si parlano. Non solo per la forma simile, cioè lo stratagemma della domanda e della implicita formula dubitativa, che li connota entrambi, ma anche perché si chiamano reciprocamente a definire uno spazio dentro cui il destino umano si dà, e si dà soprattutto il pensiero attorno ad esso, la pena, l’interrogarsi, il questionare. LE CITTÀ METAFISICHE del titolo ci pongono proprio una questione quasi architettonica. E ci fanno immaginare delle figure umane che varcano lo spazio, lo incidono del proprio incedere, lo solcano e lo abitano, si muovono al suo interno. Vengono in mente, prepotentemente, i quadri di De Chirico, che poneva questa precisa questione con insistenza: definire la collocazione delle figure umane negli spazi a seconda di come gli elementi fisici (gli edifici, i riquadramenti costituiti dalle piazze – le proverbiali piazze italiane, i confini che costituiscono sponda e limite al movimento come alla stasi). Una questione che trova spazio, è il caso di dire, anche qui, perché l’avventura umana si svolge in uno spazio e in un tempo. Trova posto in aree su cui insiste la luce come il buio. Dopotutto si pone qui anche la classica triade della metafisica: dio (diviso tra destino e il Padre), anima e mondo. Però viene in mente anche l’endiadi wit&conceits dei metafisici cioè di poeti barocchi inglesi come John Donne: l’acume cioè la vivezza sensibile del pensiero che interroga il destino e il mondo (wit), e le figure, le immagini, la sofisticata essenzialità (conceits) che sorregge e alimenta la traduzione di questa indagine nel sentire capire e vivere le questioni di fondo suggerite di continuo nell’esperienza in una versificazione che si traduca ancora in rinvenimento di senso.
Non ricordo altro
delle cene solitarie
se non la musica,
Passione secondo Luca,
Bach,
e la tua voce, Icaro.
Non sapevi altro
di noi, se non l’amore
di chi muore per sfidare la vita
dell’acqua che trapassa la luce,
bruciavi nell’assenza del sole,
metafisica della pioggia.
Questo libro, uscito per Ensemble e in libreria dal 15 ottobre, è di freschissima stampa: credo proprio sia evidente in molti passi che lo compongono se non in tutti, anche in modo a volte indiretto, l’eco della figura di Gabriele Galloni, sia attraverso forme di personificazione e/o di chiara coincidenza dell’autrice col fraterno amico, sia per riferimento aperto come nel caso del passo citato qui sopra in cui Gabriele è chiamato Icaro, come già nella dedica fuori e dentro il libro. Ed è lo stesso Gabriele Galloni a firmare la fulminante prefazione al libro: qui, con splendida intuizione e per consonanza artistica con Ilaria Palomba, Galloni svela che questo terzo testo poetico conclude un’ideale trilogia,
“Se Mancanza (2017) esplorava la Perdita e Deserto (2019) raccontava le sue conseguenze, Le Città Metafisiche è una cartolina dall’Abisso. […] Intendo dire che dopo Le Città Metafisiche la poesia di Ilaria Palomba non potrà che essere altra, tanto è dirompente questa opera.” Anche l’esergo tratto da Hölderlin dopotutto documenta un passaggio ad altro stato, un cambiamento di condizione da cui non si può tornare. Si può solo andare avanti, andare oltre, ma non si è più uguali. Si è decisamente gravati da tutto ciò che il passato ha sedimentato in noi. Così oscilliamo tra una innocenza trattenuta con le unghie e con i denti e una diversa sensazione di noi, onusti di ciò che l’esperienza ci ha inciso nella carne, trasformati e come minimo stanchi contro la nostra stessa volontà.
Al mattino l’assenza
è una specie di morte.
Al mattino mi allungo
Sul tuo spazio vuoto.
Al mattino non ho difese
dimentico di essere stata.
[…]
Sotto la pelle non scorrerà più sangue.
E la vita sgorgherà altrove”.
Ho paura che i fiori siano ringhiere,
l’innocenza del sangue
stilla ancora, la prima notte e il cielo,
catturo falene nel vestito rosso,
ho nascosto l’imbrunire nella cesta dei serpenti.
Oggi chiamami altrove
e insegnami a morire
senza piaghe.
[da Deserto, Fusibilia 2019]
Alzarsi al mattino è la prima battaglia,
non di sola luce è composto il giorno,
c’è una guerra silenziosa con i demoni del mattino,
come se dietro la porta mi attendesse un inferno
e guardo negli occhi tutti i corpi
che transitano tra il sonno e la veglia,
sono corvi e più d’ogni cosa li sento gracchiare.
Stammi vicino in questa furiosa battaglia
mentre s’alzano i confini del muro immondo,
tra le pareti sorrido agli oggetti e sono polvere
uncinata al ricordo di un mondo in frantumi.
I corpi sono il martirio del creato,
i corpi desiderano e soffrono – di questo cieco volere
ed è prossimo il massacro.
Che tu sia il peccato, Didone – donna di Luna ferita
Nessuno ascolterà le tue grida,
nessuno laverà le vesti insozzate dall’infamia
e tornerai – serva tra le serve
lontano dal suo volto assente,
lontano dal sangue di questa Luna
che adesso si apre a ventaglio sui copri
del Primo Uomo e della Prima Donna
che amando s’uccisero.
Abbiamo pagato con i corpi
fino all’ultimo centesimo,
di questa battaglia sterminata
non restano che foglie di ruggine,
il movimento obliquo delle falene sull’acqua,
la luce crepuscolare che muore sul fondo del lago,
sul fondo dell’ago ti guardo scivolare
e scivolo anch’io
nella dissoluzione del presente,
una silente protesta
contro la volontà di vivere.
Noi amanti dei deserti
abbiamo giudici feroci dentro
e granelli di sabbia negli occhi,
tra lacrime e bruma,
il cielo si sfoca in un biancore irreale
eppure sappiamo accogliere
ogni genere di bufera
rialzandoci sempre
con o senza corpi.
Di quanta stolida morte
è imbevuto il mattino.
Nel ventre immenso del cielo
si spalanca l’altrove
ci schiude e ci inghiotte
in un afflato.
Ma il corpo mi dimentica e si slabbra
e per sentirmi devo avvelenarmi
e lasciarlo fuori dai nordi
prima che il mattino mi assalga.
Si sgretolano i corpi
invasi dall’assenza
nelle pozzanghere,
stralci di cielo,
stingono,
siamo ombre
su scaglie di terra,
in gola la memoria del deserto.
[da Mancanza, Alter Ego / AUGH!, 2017]
La fotografia in questa pagina è di Dino Ignani

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
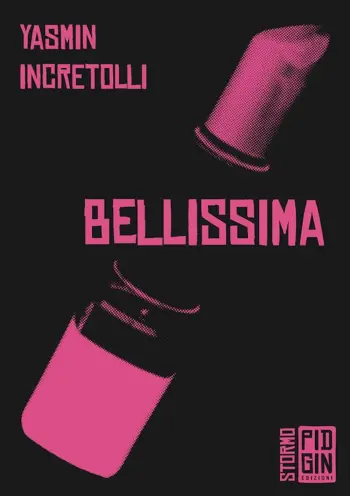
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare