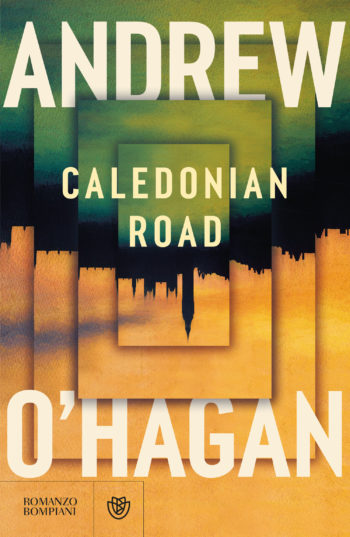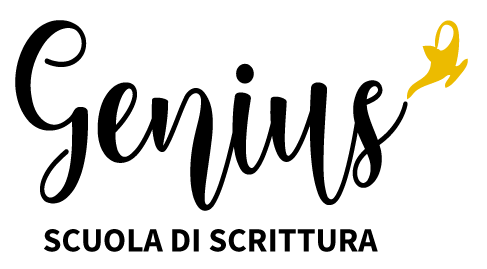Ero tornato quel giorno a casa riportando una formella in terracotta su cui era disegnata in bassorilievo un ancora. Il suo colore era di un rosa antico. Traeva origine da quelle disegnate e poi colorate con una tinta rosso sangue, da parte di un fedele officiante gli antichi riti cristiani nelle catacombe di Santa Domitilla. A me piaceva così però, impallidita. Non erano duemila però gli anni che mi separavano da quel richiamo simbolico alla speranza, ma solamente due. Mi ero detto che se aveva funzionato per la Fede di migliaia di persone, allora, avrebbe potuto funzionare per un matrimonio già alla deriva. Il mio. Vidi in quell’ancora sbiadita una possibilità remota, più per Fede che per scaramanzia, che volevo gettare nella nostra casa.
Così appena rientrato in quel pomeriggio domenicale, trovai lei ancora seduta sul divano nel soggiorno, intenta a guardare un programma televisivo di intrattenimento. Rieccomi! Dissi, cercando di dimenticare le discussioni di quella mattina. Rispose con un mezzo sbuffo come a significare: se non fossi rientrato, forse era meglio. In mano avevo la mia formella con su l’ancora scolpita.
“Ho fatto un giro per Roma, sono sceso a visitare le catacombe” e aggiunsi “ho comprato qualcosa di bello per noi, la vuoi vedere?”. Mi guardò, voltandosi da quella posizione seduta più per farmi un favore che per curiosità. E infatti: “Mica avrai speso altri soldi per cose futili?”. Non ebbi al momento la forza di rispondere.
Quella domenica mattina mentre facevamo colazione in cucina, la comparsa di un ennesimo scarafaggio in casa aveva riportato lei nel suo fortino d’insoddisfazione, e me all’ennesimo tentativo di mistificare un po’ la cosa, pregandola di scendere da quell’altana guardinga in cui si era ritirata da qualche mese.
“Io te l’ho detto che in questa casa non ce la faccio a vivere… voglio che ce ne andiamo!”. Iniziò subito così lei, mentre io procedevo allo schiacciamento dello scarafaggio impertinente come non mai: “È la terza volta che ne vedo uno da quando siamo qui! È chiaro che stando al piano terra con il giardino te lo dovevi aspettare…”
“Certo capisco è un problema, però in sei mesi che ci abitiamo qui faccio fatica a ricordare un tuo gesto d’amore verso questa casa. Ok l’ho comprata poco prima del nostro fidanzamento, ma dopo che mi hai chiesto di sposarti cosa avremmo dovuto fare? Ci siamo presi il nostro tempo…”
Durò così tutta la mattina quell’assalto alla vita condivisa. Si concluse con un pranzo stile mensa aziendale, dove l’unico rumore udibile era l’andirivieni di piatti e posate dal cassetto. Poi al distacco post prandium, sopraggiunse in me un rigurgito sonnecchioso della memoria e dei rimorsi. Quelli di una scelta ormai sull’orlo del fallimento. Chiusi gli occhi per un po’.
Lei in realtà non ci voleva stare in quel pianterreno. Una volta, alla presenza di mia madre, lo aveva detto chiaramente. L’estate di due anni prima in spiaggia seduti sulle sdraio, nel chiacchiericcio tipico dei litorali romani, il sorriso di mia madre fu presto spento quando lei disse: “Certo Bruno ha trovato la casa… però tutto sommato poteva risparmiarselo… la casa dove abito con mio padre è molto più grande e accogliente!”.
La povera mamma fece solo notare come quella casa era il frutto di sacrifici fatti da loro e ora da me, che mi ero accollato un mutuo, anche pensando al matrimonio prossimo a venire. Cercai di minimizzare la cosa. Sapevo del grave lutto che aveva sconvolto lei, allora mia fidanzata, pochi anni prima con la scomparsa della madre e il conseguente attaccamento al padre, uomo di buone maniere che reclamava in modo un po’ subdolo però, le attenzioni della figlia in procinto di diventare sposa. La pagliuzza effettivamente divenne poi un trave e feci male a non rimuoverla subito. Avrei evitato l’abuso dei sacramenti e i patemi a mia madre.
Con lei due anni prima al lavoro, ci eravamo adocchiati per un paio di mesi, finché tra un cambio turno e l’altro sorridendo e scherzando nel tepore di un lontano giugno romano, la invitai a uscire con me. Iniziò bene quella relazione, tra le antiche strade di Roma e un bacio inziale ricercato da entrambi sull’affaccio serale del Campidoglio che volge sui Fori. Mi ricordo ancora il profumo naturale della sua pelle e i bagliori luminosi fra i ruderi romani sui cui mi soffermo ogni tanto con nostalgia.
Iniziammo a volerci bene nella praticità delle cose. Lavorare un po’ insieme e accettarsi un po’ per come eravamo. Non provammo un colpo di fulmine, ma non saremmo stati né i primi né gli ultimi, pensai. Lei con i suoi pregiudizi spiccioli uniti a una cura dei dettagli, io più largo di vedute e con l’anima più transumante. La mia casa in affitto, in procinto di essere lasciata per la nuova, si adattò a un comodo luogo, dove, in un grande letto matrimoniale o su un divano segnato dalle mie abitudini libertine di quegli anni, ci ritrovavamo facendo sesso pomeridiano un po’ sbrigativo. Lo reclamavano i trent’anni dei nostri corpi in quell’estate afosa. Facevamo sempre un caffè dopo. Non fumavamo e quindi le chiacchiere e le coccole del dopo, si diluivano nel gustare la miscela arabica sul bordo di quel letto. Il sorriso fortunatamente predominava ancora sulle pretese di entrambi. Non rimaneva molto altro da fare se non uscire. In quei pomeriggi l’idea della casa che avevo comprato giù alla Pisana, non era argomento che la dilettasse. Per lei bolliva altro in pentola.
Pensò bene però di ospitarmi spesso anche lei nella sua casa, quella di famiglia, dove venivo sistemato lì nella stanzetta degli ospiti, in attesa della sua venuta per una sveltina o una cenetta di tutto punto. L’ampiezza di quella casa, al piano nobile della vecchia e prestigiosa Monteverde, con i suoi oltre 150 metri quadrati e un arredo di valore in molte delle cose esposte, inducevano in me un comportamento un po’ subalterno. Insomma, io lì in braghe di tela non potevo girare. Lo sentivo come un confinamento forzato, anche per suo padre presente lì, come il vero padrone della casa. Il servizio era perfetto ma mi sentivo un alloggiato. Quando poi lei si rivolgeva a me in sua presenza diceva, ecco è arrivato anche “zio” Bruno. Simpatica cosa, detta una volta, ma ripetuta in quel modo preludeva a uno strano e ambiguo rapporto che sminuiva il mio innamoramento.
Non c’era molto altro effettivamente. Uno slancio, una poesia, un gesto liberatorio, una risata fuori dai denti nel nostro ménage semplicemente non la ricordo. Ricordo però quella sua proposta di matrimonio. Fatta lì sul divano in casa mia. Ebbi l’impressione che facesse parte di un percorso a tappe pianificato. Me lo disse così: “Io vorrei sposarmi il prossimo anno… ti va?” “Magari aspettiamo qualche altro mese… stiamo anche bene così per adesso!”. Deglutii con difficoltà e distolsi lo sguardo. Così risposi, provando a prendere tempo per una decisione che temevo.
Fui alla fine sopraffatto dalle affettate maniere e dalla pratica volontà di lei, che nei mesi a seguire cercò di facilitare per me ogni cosa. Pur non convivendo ancora, si preoccupava di porre attenzione alle mie esigenze personali.
È stato forse quello il periodo migliore della nostra storia. Ci fu tanto mare, tanta voglia di non pensare. L’acqua sembrò unirci molto. Alle terme ischitane, o sulle bianche e sassose spiagge del Monte Conero, passeggiate e risa, condivisione con amici comuni. Le battute vicendevoli fra noi in quei momenti, sembravano far prevalere l’ironia sopra ogni cosa. Peccato quel graffio su mia madre, pensavo però in me.
Poi ci fu il ritorno alla vita autunnale per pianificare il matrimonio. Lei lo voleva religioso ovviamente come tutte le donne. Quello era il giorno della consacrazione, il suo punto di arrivo e ripartenza. Per me non so. Era una materia su cui ero scivolato molto nelle mie storie precedenti. Conobbi però il parroco della sua diocesi, un certo Don Battista che ci obbligò al percorso catecumenale per celebrare quel matrimonio.
Mi resi ben presto conto che con i Sacramenti non si poteva scherzare. Io poi ero solito al fascino della parola narrante, parabolica anche retorica magari. Però frequentando Don Battista, sentivo che quel percorso ci avrebbe dato in dono un valore importante, quello che lui chiamava “agape” che in combutta con “eros” avrebbe dovuto costituire il cardine imperituro del matrimonio.
Più facile era far vivere “eros”, la fiamma ormonale che si propagava di suo in quei mesi, mentre non riuscivamo molto ad attivare “agape”, la dedizione e la volontà, in fin dei conti il sacrificio. Insomma poteva forse esserci un po’ di cuore in quel matrimonio prossimo a venire, ma la croce sembrava proprio che nessuno voleva accollarsela. Più il corso avanzava e più diventavamo occhiuti, e puntigliosi sulle scelte, sugli invitati, sui parenti, sul matrimonio. L’eros cominciava a essere in affanno e la dedizione diventava una sopportazione che raffreddava gli animi. Il buon Don Battista ci stava spalancando le porte di un baratro che non volevamo riconoscere come tale. Ma ci eravamo messi di tigna, come diciamo a Roma.
La casa poi. Esplose prima del matrimonio. Me lo disse chiaramente: “Senti io credevo che tu avessi capito l’importanza per me di vivere nella casa di famiglia, perché vuoi che andiamo a stare lì, alla Pisana, in quel bilocale? Non vedo nessun vantaggio né pratico né economico!”
Ero ormai convinto dopo quel corso su Eros e Agape che invece avevamo bisogno di misurarci io e lei da soli. Uno spazio senza interferenze dove il matrimonio poteva esprimere la pienezza di quel Sacramento così evoluto sul piano spirituale.
Non ero affatto sicuro che l’intesa fra noi funzionasse. “No” risposi. E argomentai così la mia risposta.
Quel matrimonio. Prima da lei fortemente voluto e poi messo in dubbio addirittura il giorno prima. Ci fu ancora una sua impuntatura. Espresse a quel punto tutti i suoi dubbi. Lì commisi lo sbaglio più grande della mia vita. Ero ancora illuso che avremmo superato una volta insieme le sue ansie e paure, magari cercando insieme una gravidanza che certo lei in fondo magari desiderava.
Erano partiti gli inviti, pagato il ristorante, i testimoni ai nastri di partenza. Il mio orgoglio si sentiva maledettamente ferito e prese il sopravvento sul buon senso. Non riuscii a vedere altro quel giorno.
Si celebrò il rito si cantò e si ballò. Sì ci divertimmo quel giorno di festa e di fasti.
Fu un fuoco fatuo. La sera il ritorno a quella casa con la dismissione dell’abito da sposa, riposto sbrigativamente nelle ante di un armadio ancora anonimo per i pochi vestiti da lei traslocati, avvenne con un senso di disagio che contaminò i giorni a seguire. Ricordo poi che non facemmo l’amore. Ognuno scavò così il suo argine dove fece scorrere i suoi pensieri e i suoi dubbi. Ci affacciavamo dagli argini ma non ci tuffavamo nel fiume dell’altro. E nel frattempo il fossato era diventato più grande.
Questo era il film trasognato che scorse nella mia testa ridestandomi dopo l’imbarazzante pasto di quella domenica.
Improvvisa subentrò una sensazione panica. Una dannazione che sembrava riproporsi ormai a piè sospinto dopo gli estenuanti litigi. Quel mezzo inferno che scatenavamo puntualmente ogni due o tre giorni, avevo bisogno di visitarlo per davvero. Magari una via di mezzo. Qualcosa che mi facesse scendere nelle viscere della terra, nei meandri di una coscienza maltrattata e perseguitata. Evidentemente volevo sentirmi fino in fondo un dannato e mi sovvenne l’idea della catacombe. Perché le catacombe? Chissà volevo alimentare ancora un barlume di speranza là in prossimità della morte ipogea. Era per quel sentimento diventato poi un Sacramento ormai in dissolvenza, a cui mi ero in qualche modo legato che me lo chiedeva. Andai. Vidi allora, tra i tanti simboli rituali di quel cristianesimo antico e mistico, l’ancora. Simboleggiava la speranza di avere fede in qualcosa di divino. Nel mio caso era appunto un amore, un matrimonio accelerato e poi ora rinnegato, meritevole anch’esso di misericordia, lo speravo. Rimasi raccolto e in silenzio di fronte a quei simboli evocativi, apotropaici per certi aspetti.
Presi allora quella formella. Andava messa lì sopra l’entrata della porta di casa, così prima di uscire nei giorni successivi, pensavo, avremmo potuto insieme dare un ultimo sguardo a quel simbolo di fede e di speranza. La mia rassegnazione era quasi pronta a salpare. Rientrai a casa e dopo un po’ cercai il martello e un gancio. Era come se volessi ormeggiare per l’ultima volta la mia casa. E così le chiesi: la fisso al lato o sopra la porta, che dici?
Non spense la televisione, non si avvicinò neanche, si voltò un attimo dal divano con uno sguardo di ammonimento. Sembrò in procinto di redarguirmi come se avessi oltraggiato l’uniforme che indossava abitualmente al lavoro. Dilatò le narici e serrò i denti. Riuscì solo a schiacciare il telecomando per cambiare canale guardando altre immagini alla TV. Alle spiagge caraibiche erano subentrate le montagne d’Abruzzo.