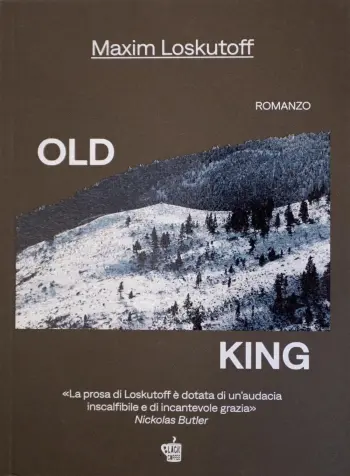Quando Grazia Marchese mi disse che avrebbe voluto scrivere una storia di fantascienza, con astronavi, androidi, robot, viaggi interstellari, ecc., mi sono un poco stupito. Fino ad allora aveva scritto racconti con i piedi ben piantati sul pianeta Terra, ma poi, mentre continuava a scrivere la sua storia, sono andato convincendomi sempre di più che aveva trovato la narrazione adatta a lei. E infatti la possiamo trovare in libreria con il suo romanzo dal titolo Daniel (Affiori 2024), storia di un androide diverso dagli altri (molto diverso) che a poco a poco scopre con struggente disperazione e qualche sprazzo di speranza qual è il motivo della sua diversità. Con tutto il corollario tipico, dall’intelligenza artificiale alla corruzione e ai rischi della scienza. A pensarci bene, come sempre succede con la buona fantascienza, si tratta di un apologo che può essere letto alla luce di molte situazioni contemporanee, senza costringerci a volare troppo in avanti nel tempo per comprenderlo. Ne parlo con l’autrice.
Grazia Marchese, come mai ti sei avvicinata a un genere così particolare come la fantascienza?
Ci sono almeno tre ragioni. La prima è che adoro questo genere: credo di aver letto quasi tutte le opere di Asimov, buona parte di quelle di Bradbury e un certo numero dei romanzi di Philip K. Dick. Trovo che la fantascienza di questi autori sia intelligente, stimolante, a volte poetica, come nel caso di molti scritti di Bradbury, densa di significati importanti per il genere umano. La seconda ragione è che sono curiosa, avida di ciò che ancora non conosco e quindi del futuro: penso alla morte con rammarico, non tanto perché, genericamente, non ci sarò più, ma soprattutto perché non riuscirò a vedere dove ci avranno portato tutte le scoperte scientifiche, assolutamente straordinarie, che vedo profilarsi in questi anni. La terza ragione, forse la più profonda, è quella che riguarda la mia scrittura: collocare la mia storia in una ambientazione fantascientifica mi ha aiutato a “prendere le distanze” da quello che stavo raccontando; l’ho scoperto solo dopo, ma credo che mi sia servito per rendere sopportabile la sofferenza che ha comportato mettere in scena i turbamenti, i dolori, le passioni che agitano i miei personaggi.
Nel creare un androide, hai tenuto conto di come li hanno sviluppati questi autori classici della letteratura sui robot, appunto per esempio Asimov e Dick?
Assolutamente sì! Sono grandemente debitrice a entrambi gli autori che hai citato, ad Asimov soprattutto: i miei androidi sono governati dalle tre “leggi della robotica” da lui create; riflettono e agiscono secondo queste leggi. Il confine tra le loro riflessioni e azioni e quelle di un essere umano è evanescente, come lo è nei romanzi della quadrilogia di Asimov che amo di più: Abissi d’acciaio, Il sole nudo, I robot dell’alba, I robot e l’impero. Si tratta di romanzi “psicologici”, dove il tema principale, a mio parere, è proprio quello della differenza tra la logica robotica e quella umana, che, se pure diverse, finiscono per avere pari dignità. Mi sono invece lasciata ispirare da Dick per i lati più inquietanti dei miei androidi, quelli in cui il loro essere “macchine” emerge con prepotenza, quasi con ferocia, anche quando appartengono alla schiera dei “buoni”.
Chi è Daniel? E chi è Jenny?
Daniel è un androide ed è il protagonista maschile del romanzo: Jenny è un’umana ed è la protagonista femminile. Pur essendo così diversi hanno in comune un tratto fondamentale: sono entrambi dei disadattati. Daniel si sente diverso dai robot suoi colleghi, che lo annoiano profondamente e talvolta persino lo irritano; Jenny odia gli uomini e ha giurato a sé stessa di non incappare mai più in una storia d’amore, o anche solo di sesso, con uno di loro. Sarà proprio questa diversità-affinità, che solo apparentemente è una contraddizione, a farli incontrare e a cambiare i loro destini.
Anche tra gli androidi sembrano comparire gelosie, invidie, e forse qualcosa di simile all’amore, vero?
Certo: è proprio così. Ho tentato di far sviluppare queste capacità “sentimentali” ai miei androidi un po’ alla volta, imparando da Daniel, che fin dall’inizio le possiede pienamente e anche per questo soffre, e da Jenny, un’umana capace di entrare davvero in relazione con loro.
Pensi che la scienza sia vicina a realizzare quello che hai ideato tu nel tuo romanzo?
Credo che non sia vicinissima, ma di certo è sulla buona strada. Per esempio, ho scoperto solo recentemente, a romanzo concluso, che in Cina si sta tentando di fare, certamente in modo ancora embrionale, quello che il team di scienziati della mia storia ha fatto con Daniel e il suo cervello. Sono rimasta allibita: non avrei mai pensato che quella che a me sembrava l’invenzione narrativa più lontana in assoluto dalla realtà fosse invece già oggetto di sperimentazione, qui e ora! Ma su questo non voglio dirvi di più, adesso…
Già, non facciamo troppi spoiler… nel mondo della tua storia, comunque, c’è una legge che impedisce alcune operazioni. Bisogna mettere dei limiti alla ricerca, secondo te?
Questa è una domanda difficile, a cui si dovrebbe rispondere con l’aiuto dei filosofi della scienza, ma provo lo stesso ad abbozzare qualche idea. Penso che la ricerca teorica pura non abbia bisogno di limiti: finché le teorie restano tali non possono nuocere a nulla e nessuno; dunque nessuno dovrebbe sindacare su chi sviluppa teorie, in qualunque campo del sapere, e si dovrebbe essere aperti a prendere in considerazione, per metterle alla prova, ogni genere di teoria, anche la più eterodossa, perché è solo così che il sapere può davvero avanzare. Si può obiettare che le teorie hanno bisogno di osservazioni e sperimentazioni per essere avvalorate o confutate: qui comincia a entrare in gioco l’etica e dunque a porsi il problema dei limiti. E qui, secondo me, l’etica del ricercatore deve assolutamente fare da guida: il rispetto per la persona umana, la salvaguardia dell’ambiente naturale, la difesa della verità e la trasparenza dovrebbero essere dei “must” imprescindibili. Ma sarei molto cauta nell’introdurre limitazioni ex-lege: l’ideale sarebbe poter calcolare sempre il rapporto costi/benefici di una data sperimentazione, ma nella ricerca i benefici quasi mai sono noti fin dall’inizio e lo stesso si può dire, almeno in parte, per i costi. Dove non ho dubbi che dei limiti imposti dall’esterno siano necessari è nelle applicazioni tecnologiche della ricerca, ma per fortuna questo è anche il terreno dove il rapporto costi/benefici è più facile da calcolare.
L’intelligenza artificiale ti spaventa oppure ne vedi i lati positivi?
Non sono affatto spaventata dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale. È uno strumento fondamentale, che porterà a rapidi e grandi progressi in ogni campo del sapere, perché moltiplica enormemente le capacità di analisi dei dati di un determinato problema. È anche uno strumento che può aiutare moltissimo nell’organizzazione del lavoro, accrescendo l’efficienza e aumentando la produttività; questo vuol dire che l’I.A. potrebbe “liberare” gran parte del nostro tempo e consentirci di dedicarlo a ciò che più amiamo, a patto, naturalmente, che chi è padrone del nostro tempo di lavoro sia disposto a lasciarci a disposizione il “tempo liberato”…
Certo, l’I.A. può imitare molto bene la realtà e creare un assemblaggio di menzogne pressoché indistinguibile dalla realtà stessa (pensiamo ai deep fake). Ma noi, a differenza dell’I.A., sappiamo pensare, riflettere! Abbiamo la capacità di mettere in discussione quello che ci propone e di smascherarla se mente. Non c’è alcun motivo di temerla se coltiviamo il nostro pensiero critico. Non bisogna imbrigliare il suo sviluppo, ma potenziare le nostre capacità di analisi critica! E naturalmente ben vengano leggi che puniscano severamente chi usa l’I.A. per ingannare il prossimo. Inoltre, non sono un’esperta del settore, ma credo che si possano identificare norme tecniche specifiche per evitare o almeno limitare un uso pericoloso dell’intelligenza artificiale, nei termini che ho cercato di definire.
La tua è una storia sulla diversità, Daniel in fondo potrebbe essere un qualunque individuo con una particolarità unica, non credi?
Certamente! È proprio quello che intendo suggerire con questa storia. Purtroppo, chi è in qualche modo diverso tende a essere allontanato dai cosiddetti “normali”, perché non è compreso e dunque fa in qualche modo paura. Ma la sofferenza dei diversi è grande e merita di essere accolta. Bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo quando si incontra la diversità e se si riesce a farlo la diversità stessa si dissolve. Per riuscirci ci vuole una mente libera da pregiudizi: non è un caso che ai bambini riesca molto più facile che agli adulti. Dovremmo tutti tornare un po’ bambini: l’umanità sarebbe migliore.
All’inizio del libro inserisci una citazione di Isaac Asimov: “La stranezza è nella mente di chi la percepisce”. Questa stranezza è una cosa che riguarda solo i personaggi estremi come Daniel, o l’hai incontrata anche nella tua vita?
Ho incontrato la “stranezza”, alias la “diversità” nella mia vita, anche molto da vicino, anche in persone che ho amato e amo molto. Quando ho cominciato a scrivere questa storia non ne ero affatto consapevole, ma credo che la molla interiore fosse proprio il bisogno di catarsi, a seguito di queste esperienze umane toccanti.
Mi sembra anche un romanzo sulla nostalgia del pianeta Terra e della sua umanità, no?
Sì, in un certo senso lo è, ma è nostalgia per una Terra idealizzata e un’umanità idealizzata, come nelle visioni di Daniel, come anch’io vorrei che fosse. L’umanità vera è un po’ diversa da così.