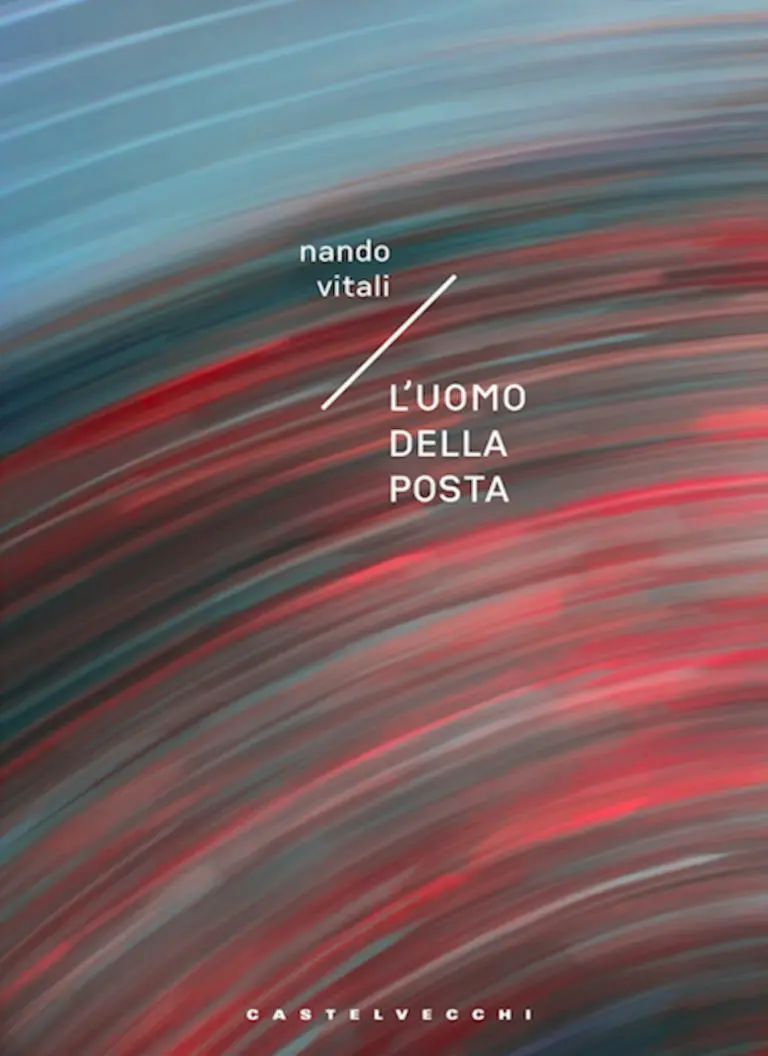È appena uscito per i tipi di Castelvecchi un nuovo romanzo di Nando Vitali, L’uomo della posta. Questo mi offre l’occasione per fare una chiacchierata con lui, che è autore prolifico di diversi romanzi: L’uomo largo (Terra del fuoco 1987), Chiodi storti – da Ponticelli a Napoli Centrale (Compagnia dei trovatori ed. 2008 poi Castelvecchi 2022), I morti non serbano rancore (Gaffi 2011), Bosseide (Gaffi 2015), Ferropoli (Castelvecchi 2017), Fratelli di sangue (Readaction 2022), e raccolte di racconti. Nando Vitali è anche il direttore di una rivista letteraria che esplora in profondità la cultura contemporanea, “Achab”, il cui ultimo numero dedicato a Pasolini ha avuto recentemente un ampio riscontro di critica e lettori. La lettura di questo romanzo, L’uomo della posta, non lascia indifferenti, sembra navigare dalle parti del realismo, della vita quotidiana più comune già dal titolo e poi improvvisamente ci porta subito da un’altra parte, ci fa inabissare nelle zone profonde dell’immaginario e di una visione aumentata della realtà, come il sommergibile, la cui immagine potente, al limite del surreale, apre la narrazione, che oscilla frequentemente dal piano del realismo a quello del fantastico. Devo dire che – per quel che vale il mio giudizio – questo romanzo mi sembra perfino più toccante e profondo degli altri suoi precedenti, o almeno ha toccato me in modo particolare.
Nando Vitali, chi è l’uomo della posta?
Un uomo apparentemente sotterraneo, quasi già morto, seppellito in un lavoro ripetitivo che detesta. Ma cova dentro di sé il sogno della scrittura (sta scrivendo un romanzo), legge molti libri, con un matrimonio naufragato alle spalle. Vive da solo. Però il destino aveva già una volta bussato alla sua porta quando, nato per uno scambio casuale durante la seconda guerra mondiale, suo padre si trovò a essere vivo per miracolo. Scampare alla morte gli permetterà di mettere al mondo Lorenzo, protagonista del romanzo: l’uomo della posta. Luogo di arrivi e partenze, lettere e misteriosi convegni nelle stanze segrete del direttore. Lorenzo, uomo qualunque, si troverà di fronte a una materia più grande di lui. La materia oscura della predestinazione.
Il romanzo si apre con l’immagine di un sommergibile inabissato, è un reale evento storico?
No. È inventato. Mi serviva per giustificare una serie di concatenazioni del caso. Eventi misteriosi, gioco di dadi che pare preordinato per i protagonisti che non possono sottrarsi alla nemesi, al gioco dell’immaginazione e della paranoica ricerca di un tempo perduto.
A un certo punto il tuo personaggio dice: “L’uomo non funziona e avrebbe bisogno di riparazioni”, la scrittura può essere un modo per provare a ripararlo?
Chi scrive cerca di riparare con polvere d’oro le ferite, la necessità di liberare la porta chiusa del proprio corpo. Come per le Prigioni di Michelangelo. Dare forma al dolore: è in questo la complessità della scrittura. Lotta con l’inafferrabile pagina perfetta che genera storie quasi sempre allegoriche. Una città nova dove si è carnefice e vittima come in Dogville di L.V. Trier. Linee tracciate sulle pagine alle quali dare ordine. Disciplina al caos interiore.
C’è un continuo dialogo tra il protagonista e un bambino morto, ma non solo con lui. È un personaggio che parla con i morti, come in altre opere della tradizione, non solo partenopea, a cui ti senti legato?
Probabilmente sì. Penso ad Annamaria Ortese del Cardillo addolorato, o a un certo Compagnone. Ma sono stato letteralmente fulminato dalla letteratura sudamericana degli anni Ottanta. Napoli somiglia molto alla Colombia di Màrquez per esempio, anche se Napoli è spiritualmente più catacombale. Scrivere a Napoli è immergersi nella città sommersa, quella delle caverne, sotterranea, dove vivono i suoi fantasmi che possono emergere in qualunque momento. Eros e Thanatos in questa città si fondono nello stesso crogiuolo. Non puoi restarne immune.
Ma io considero Bagnoli la mia piccola patria. Un posto di luce e di mare magico. In fondo uno scrittore non ha radici, se non le proprie, quelle che hai dentro di te. Parlare coi morti è parlare con se stessi.
È un testo che sembra partire dal realismo per approdare a un mondo fantastico e talvolta surreale, sei d’accordo? Penso alla mosca che a un certo punto gli si poggia sulla mano, vista quasi al microscopio.
Le paranoie di Lorenzo da entomologo sono la malattia del fastidio di chi è perseguitato da un terribile segreto, la sua viltà, che lo porta a frequentare un centro per alcolisti anonimi, dove avrà un incontro fatale.
Il realismo è solo un punto di partenza che si rifrange in mille sfumature dove l’immaginazione e il sogno si confondono con la vita reale. Forse la vita è sogno come lo è la scrittura.
Tuttavia l’arte può essere il ricongiungimento fra le bassezze dell’uomo e la grandezza dell’arte. La bellezza che nasce dalla riparazione del male attraverso la catarsi. Sono affascinato per esempio molto dal cinema, e penso a Maria di Metropolis che si sposta fra il nulla e il tutto. O a Melancholia, tornando a Von Trier.
Bagnoli è la mia Spoon River, dove è ambientata in gran parte la storia.
Arriva a un certo punto l’incontro con gli alcolisti anonimi, nasce da qualche incontro che hai avuto?
Un mio carissimo amico ha avuto la vita rovinata, rubata, da un omicidio stradale. Ho pensato a lui quando il romanzo prende l’avvio. Quella è stata l’idea propulsiva. Un dolore al centro del corpo e dell’anima e un senso di colpa che non sai in che direzione può sfociare.
E poi arriva Maria Pesce, chi è?
Naturalmente non possiamo dire chi è veramente perché fa parte del gioco a incastro che ho architettato. La sua vita tormentata da un figlio perduto, la dipendenza dall’alcol si intrecciano col protagonista. È una madre che non vuole rassegnarsi a questo dolore, fino a intrattenere un rapporto telefonico col bambino morto. È l’anima, il cuore misterioso delle donne, in particolare le madri del sud. A volte mute e fatali, a volte vendicative, ma capaci di amare e pensare l’impossibile infilando il braccio nel corpo dell’amato fino a ucciderlo.
In un momento molto intenso il tuo protagonista dice: «Anche tacere può essere utile alla storia». C’è qualche volta bisogno di non dire tutto? Anche quando si narra?
Il non detto, la prossemica, il corpo, le velature nella narrazione sono secondo me una grande risorsa, soprattutto nei dialoghi e nel rapporto fra gli attori in campo. È anche la maniera di stabilire una complicità forte col lettore, facendolo partecipe di una vicenda che lo riguarda.
Penso a Flannery O’ Connor, Edna O’ Brien, o la memoria come luogo di rimozione e ricreazione di dettagli modificati, vicende che mutano col tempo della riflessione. Ho visto di recente un film davvero bello su questo tema: Le cose che non ti ho detto.
Cosa rappresenta in questo romanzo l’Argentina?
È il pensamiento triste del tango di Borges. Un luogo per ricominciare come se la scrittura e la vita stessa fossero una danza, un suono. Ogni frase per me è anche un fraseggio, custodia di note che si liberano nella storia. Il suono stesso di questa città così cara agli italiani è un canto.
Secondo te c’è un fil rouge che percorre tutte le tue opere, sapresti riconoscerlo?
Nella figura totemica del padre e nell’infanzia. La solitudine come luogo segreto dove elaborare un raccordo fra malinconia e felicità. Invenzione, come direbbe Herman Hesse, nella quale il rumore si trasforma in musica. Le mie storie nascono quasi sempre dall’ampliamento di un dettaglio, o una ossessione che preme per uscire allo scoperto e “fare” forma quasi autonoma. Poi inizia la battaglia fra me e la pagina.