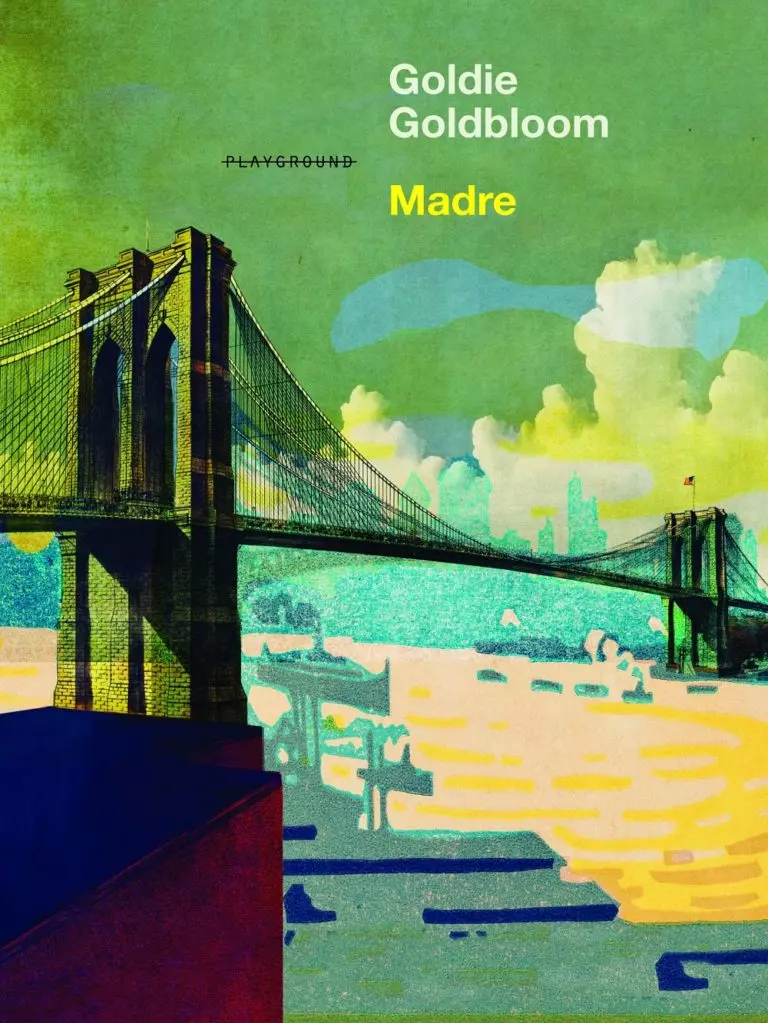In una comunità di ebrei chassidici, cioè ultraosservanti, di Williamsburg, un sobborgo di New York sull’East River, vive Surie, con il marito Yidel, e nello stesso palazzo i suoceri, la figlia più grande e numerosi nipoti.
Surie, come molte delle sue amiche, si è sposata a 16 anni dopo aver incontrato il futuro marito una volta sola per circa mezz’ora, si è sottoposta ai riti matrimoniali, il mikveh (bagno rituale di purificazione), la rasatura dei capelli e da quel momento in poi ha fatto tutto quello che si richiede a una donna ebrea nella sua situazione: fare molti figli, farli crescere, pregare, indossare la parrucca e il foulard o il turbante ogni volta che è fuori casa (i capelli veri vengono rasati appena cominciano a ricrescere, per conservare la modestia ed evitare che siano uno strumento di seduzione vietato alle donne sposate). Di questa vita e dei suoi 10 figli e 32 nipoti, all’età di 57 anni, Surie è molto contenta, o meglio, è contenta quanto può esserlo una madre che nasconde alla comunità intera il dolore per il figlio più amato, Liba, allontanatosi perché gay e contagiato dall’HIV. In un mondo così chiuso, dove le parole pericolose non vengono pronunciate, Liba non sapeva neppure a cosa servissero i preservativi, e del resto perché meravigliarsi visto che i chassidim non parlano neppure inglese ma solo lo yiddish, l’aramaico e il dialetto ungherese della loro terra originaria. Surie è molto legata alle tradizioni e alle scelte della sua comunità, è strutturata in base alle esigenze degli altri, e pertanto l’inattesa gravidanza, addirittura di 2 gemelli, a un’età in cui il sesso dovrebbe essere un ricordo, la getta nel panico. Per la prima volta nella sua vita, Surie si vergogna del desiderio sessuale che prova per il marito, cosa della quale non ha mai fatto parola, da brava ebrea, e soprattutto ha paura dell’ostracismo nel quale potrà gettare la sua famiglia quando si saprà che ha l’età di una nonna e ha concepito un altro figlio, anzi due. All’inizio sembra più facile non dire nulla, e il suo sovrappeso e i vestiti lunghi l’aiutano, ma poi il segreto diventa per lei un modo per rivendicare una sorta di identità separata e autonoma rispetto al ruolo che si è fatta costruire addosso. In una sorta di dialogo muto con Lipa, Surie capisce perché lui abbia preferito scappare, fino a togliersi la vita, considerato un reietto da parte di tutto il micromondo familiare. La diversità di Lipa è un’onta che è ricaduta sulla famiglia, tanto che si teme per i matrimoni delle nipoti e dei figli più giovani, e a questa disgrazia non può aggiungersi una gravidanza geriatrica di una donna che ormai è destinata a essere solo una nonna. Nelle visite di controllo all’ospedale, Surie scopre una parte di sé che non pensava di avere: la parte di una donna che pensa e desidera cose diverse da quelle che le hanno insegnato essere adatte a una donna, scopre di avere talento per l’ostetricia, e che il suo tocco gentile può aiutare altre donne chassidim, che non capiscono l’inglese e non possono farsi toccare da persone impure.
Il parallelismo tra l’allontanamento di Lipa e la gravidanza vista come una vergogna spinge Surie a una serie di riflessioni potenti quanto amare: la comunità respinge gli scandali, anche quando si tratta di coprire un pedofilo, ed è disposta ad accettare solo chi perpetua la sudditanza alla comunità stessa, negando ogni barlume di identità individuale, ogni minima forma di distinzione dall’omologazione al ruolo che ha, alle ricorrenze e ai precetti. Surie non vuole ribellarsi, vuole continuare a essere un’ebrea devota, ma la devozione non si concilia con la constatazione che alle ragazze è proibito studiare, e che la sua nipotina intelligente e curiosa, Miriam, verrà fatta sposare a 16 anni, e farà quello che ci si aspetta da lei, senza esitare né cercare possibilità migliori. Perché non esiste destino migliore per una donna che quello di essere madre. Eppure, Surie si chiede: “Ho amato davvero mio figlio o l’ho rifiutato perché gay”? E i membri della famiglia ti amano perché sei uguale a loro, e smetterebbero in caso si trovassero di fronte una persona diversa da quella che faceva loro comodo vedere? La crepa è aperta e Surie inizia a intuire le ambivalenze nascoste dietro l’osservanza cieca alle regole non solo nella comunità ma nella sua famiglia, nel suo matrimonio.
I mesi passano scanditi dalle stagioni, dalle ricorrenze e festività, dai preparativi del venerdì per lo Shabbat, e Surie continua a tacere sulla sua gravidanza, sperando che il marito se ne accorga, ma questo non succede. Il rigido protocollo di separazione dei letti non incoraggia l’intimità e quindi Yidel, immerso nelle certezze illusorie, non capisce nulla di quel grasso in più al punto vita. Questo segreto è la rivendicazione del suo essere ancora donna, desiderabile e sessualmente attiva, e per questo Surie non riesce a decidersi a rivelarlo, perché non vuole essere sottoposta al giudizio miope e spietato di chi dovrebbe amarla e invece la condanna, esattamente come è accaduto a Lipa, mai dimenticato, anche se le sue foto sono state strappate e il suo nome non viene più pronunciato.
Cosa dobbiamo perdere per fare spazio alla nostra vera natura? La comunità è una comfort zone perenne, e quando ce ne stacchiamo rischiamo di perdere il nostro passato e i nostri affetti. È un prezzo molto alto che non tutte le persone sono disposte a pagare. Ma solo trovando sé stessi si trova il mondo. Quando si oltrepassano i muri si può morire, ma anche, grazie a Dio, vivere.
“Si voltano e cominciano a camminare per la strada. La pioggia continua a scendere, lavando lo sporco tra i ciottoli e dietro gli anfratti di Williamsburg, trascinando i detriti verso il basso, e, in un crescendo di rumori, facendoli precipitare nel fiume, che poi li sospingerà nell’immensità dell’Oceano Atlantico”.