
La Tarologa e lo Scrittore: NON AVERE PELI SULLA LINGUA!
Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.
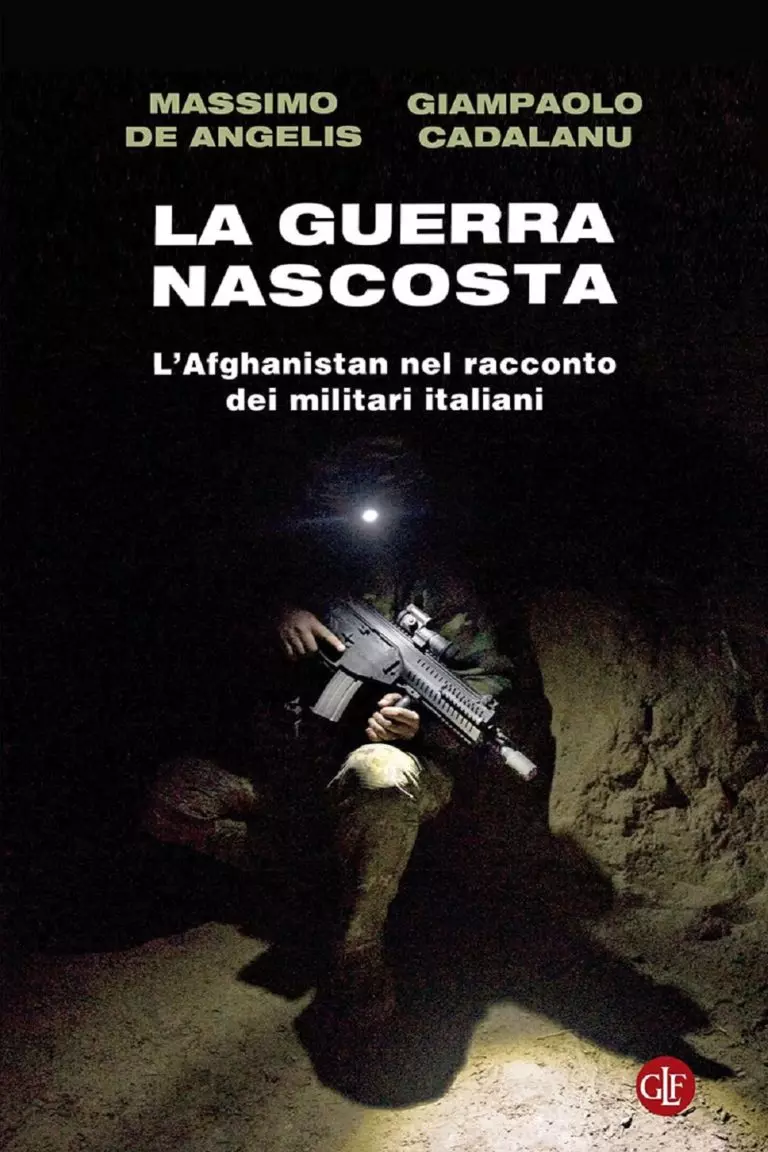
Ci sono libri necessari perché anche nella scrittura ci sono mestieri necessari. In questa categoria rientra il lavoro dei giornalisti degli esteri che fanno gli inviati di guerra, quelli che si occupano dei conflitti, non solo sulle prime pagine per gli eventi eclatanti, ma per raccontarli dal di dentro, talvolta anche quando sono scomparsi dalle cronache. E oggi che stiamo subendo le narrazioni interessate delle due parti in causa nella guerra tra russi e ucraini, dove ciascuno dei combattenti racconta solo quello che gli fa comodo, nel modo che gli fa comodo, può essere solo un bene indagare su una guerra che è finita da pochissimo e che ormai sembra appartenere alla storia passata. Il libro in questione s’intitola La guerra nascosta. L’Afghanistan nel racconto dei militari italiani (Laterza, 2023) ed è stato scritto da Massimo de Angelis e Giampaolo Cadalanu. Una ricostruzione davvero unica del ruolo avuto dai militari italiani, e dall’Italia tutta, in questa operazione bellica presentata come azione di peace-keeping ma che era a tutti gli effetti un’operazione militare. Tanto ci sarebbe da scrivere sulle nostre missioni di pace nel mondo, e Cadalanu e De Angelis hanno dato vita a un passo concreto per iniziare a farlo. Conosco e stimo Giampaolo Cadalanu, non solo come giornalista (le sue cronache per “La Repubblica” e gli altri media mi hanno spesso spiegato gli avvenimenti più lontani da noi) ma anche come docente di giornalismo, capace di infondere la passione per questo mestiere negli allievi, anche se fa di tutto per metterli sull’avviso sui tanti rischi, le inevitabili delusioni, le poche gioie che li aspettano. E allora ci ho fatto una delle mie solite chiacchierate.
Parlare dell’Afghanistan oggi sembra quasi fuori tempo, tutto si dimentica così in fretta?
I ritmi della vita sono sempre più veloci, l’attenzione si sofferma il minimo indispensabile, ma i libri come questo servono proprio per consentire un approccio rallentato, con la dose di meditazione appena sufficiente per dare il giusto valore agli avvenimenti. Mi illudo che se questi ultimi sono ancora vicini nel tempo, come nel caso dell’intervento in Afghanistan, un’analisi approfondita possa convertirli in insegnamento. Insomma, non è più cronaca ma nemmeno storia: speriamo possa essere esperienza.
Il libro contiene tantissime testimonianze molto interessanti, quanto vi ci è voluto per raccoglierle?
Questo libro è di fatto la riscossione dei crediti ottenuti in vent’anni. Massimo de Angelis e io abbiamo incassato la fiducia da parte dei militari che ci hanno conosciuto sul campo, che magari prima avevano storto il muso davanti ai giornalisti e poi alla fine avevano imparato a fidarsi. È un equilibrio delicato, fra le ovvie esigenze di riservatezza degli affari militari e le necessità dell’informazione. Credo che entrambi possiamo fare un bilancio positivo su tante missioni: abbiamo soddisfatto le esigenze dei lettori e degli ascoltatori senza mettere in imbarazzo i soldati, a meno che non lo meritassero. Questa soltanto era la ricetta per raccogliere le testimonianze: la fiducia degli interlocutori. In termini di tempo, il lavoro del libro è durato poco meno di un anno.
Hanno collaborato senza paura?
Molti militari, soprattutto quelli ancora in servizio attivo, hanno preferito non comparire con nome e cognome, perché in teoria non potrebbero fare dichiarazioni pubbliche senza autorizzazione. Ma una volta concordato l’anonimato, hanno parlato tutti senza remore.
Nel libro viene ricostruita tutta la vicenda, comprese le bugie che la costellarono. Si può fare una guerra senza bugie?
No. Tutte le guerre utilizzano l’inganno, da sempre. L’espressione fake news torna continuamente nei notiziari, e forse suscita l’idea che le bugie di guerra siano un’invenzione recente. Invece è proprio il contrario. Il primo combattimento di cui si sia trovata descrizione dettagliata è la battaglia di Kadesh, nel 1274 avanti Cristo, fra gli Egiziani di Ramsete II e gli Ittiti di re Mutawalli II. È raccontata nei geroglifici del tempio di Karnak, ad Abu Simbel. Ma gli storici dell’antichità hanno scoperto che il racconto, inteso a creare la leggenda del faraone guerriero, è pieno di bugie. Allora come oggi, i governanti consideravano necessario consolidare il consenso interno con operazioni cosmetiche, ovvero reinventando gli avvenimenti.
Allora è stato un fallimento totale?
La guerra in Afghanistan è costata migliaia di vite e cifre enormi, il Paese è in condizioni peggiori rispetto al 2001. Possono considerarla un grande successo solo i mercanti d’armi e i signori della guerra che hanno nascosto nelle banche di Dubai i soldi destinati alla ricostruzione.
Fu presentata come una missione di pace ma ormai è evidente che si è trattata di una guerra, no?
Non ci sono dubbi. Nel libro questa considerazione si regge sulle testimonianze dei militari e sul ragionamento, che esclude ogni altra etichetta. Chi lo ha chiamato intervento umanitario o missione di peace-keeping semplicemente mentiva.
Oggi c’è un’altra guerra che ci coinvolge, quella in Ucraina. Si somigliano i due conflitti?
Come è ovvio, ci sono similitudini e profonde differenze. Personalmente voglio solo sottolineare un elemento che accomuna le due guerre, e che a mio avviso andrebbe tenuto sotto stretto controllo: l’approccio poco problematico anche da parte dell’Occidente, cioè la narrativa semplicistica che divide fra buoni e cattivi. Questa impone all’opinione pubblica una lettura polarizzata, del tutto insufficiente a comprendere le dinamiche articolate della politica internazionale. In Italia l’attenzione verso la guerra in Afghanistan era senz’altro più critica, invece sull’Ucraina il dibattito pubblico sembra essersi involuto e finisce per dare poco spazio al dubbio, proponendo un atteggiamento “deciso” e spesso bellicista. Questo non corrisponde alla coscienza registrata dai sondaggi fra la popolazione, apparentemente molto più problematica e prudente. Il dovere di chi fa informazione dovrebbe essere porre le domande giuste, invece troppo spesso capita di leggere solo risposte, per di più date con toni assertivi, come di verità auto-evidenti. In altre parole: troppi sognano di essere Gabriele D’Annunzio e pochi si preoccupano di affrontare la complessità per far capire davvero che cosa succede.
Alcuni giornalisti in questo momento sono più attivi sui social che sui media tradizionali, che ne pensi?
È un fenomeno che comprendo solo in parte. I social permettono una circolazione delle notizie molto più veloce, e in genere garantiscono una grande rapidità anche nelle verifiche. Questo potrebbe essere un bene. Ma resto convinto che comunque la logica del lavoro giornalistico cambi poco, quale che sia lo strumento con cui l’informazione si diffonde. Alla fine, l’analisi e la comprensione di osservatori preparati restano indispensabili. Per capire, bisogna studiare. Il resto è solo chiacchiera, fuffa, rumore di fondo.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

L’Old King che dà il titolo al romanzo è un albero secolare, un simbolo di forza e intangibilità di un mondo sulla soglia di una violazione traumatica e senza possibilità di ritorno.

Il significato della parola “assassinio” è molto chiaro. Finché non tocca qualcuno che ami molto.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare