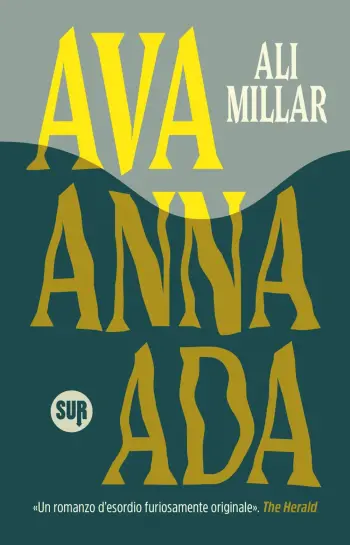Sopravvissuti a sé stessi. Questo sono i protagonisti di questi racconti, tutti ambientati in Israele, nel tempo che si snoda dalla nascita dello Stato di Israele e i primi campi profughi per sefarditi e sopravvissuti alla Shoah, all’ultima intifada. Il tempo, per alcuni dei personaggi, non è mai veramente trascorso e li ha inchiodati lì, nel momento esatto della consapevolezza della perdita dell’amore o dell’amicizia o della speranza. Eppure, nonostante abbiano subito lutti e perdite rimangono vivi, esausti, nella luce logora e accecante del deserto, o investiti da insolite e anomale ondate di gelo, ma vivi.
Ognuno di loro serba un segreto che non riesce a raccontare, un momento di incondivisibile rabbia o paura, un colpo del polso che ha cambiato le cose in maniera irreversibile. Il loro intero percorso vitale è spesso un tentativo di riparare a un torto, un’offesa che spesso non viene nemmeno percepita da chi la subisce, una possibilità di salvezza da quello che tormenta e che non è più rimediabile. Questi racconti hanno il dono di premere un punto doloroso specifico, l’equivalente di un dito tra le costole o su una ferita non guarita che ricomincia a fare male con il cambio del tempo atmosferico.
Troviamo il vecchio ebreo che, di fronte alla nipote palestinese del suo migliore amico di quando erano ragazzi, racconta delle loro avventure nel raccogliere arance e del rimpianto che prova per aver perduto quel tempo e quell’amicizia, ridotta in frantumi dalla diaspora dei palestinesi. Quello che lui non ha il coraggio di confessare alla giovane Lilah, e che lo tormenta, è un segreto confessato al lettore, e il giudizio è lasciato a chi decide di prendere in carico quel dolore.
Ci sono ragazzini che girano con un vecchio furgoncino tra i monti della Galilea, eredi del mestiere di robivecchi del padre, la cui voce acuta registrata è l’unico legame che testimonia che un tempo erano una famiglia protetta e al sicuro. Nel loro viaggio alla ricerca di mobili vecchi e ciarpame incontrano gruppi di ebrei osservanti che stanno cercando di sottrarsi alle regole rigide e di vivere in modo più vitale. Quello che perdono e trovano è la rinuncia a una parte delle loro illusioni, e la tenerezza di una ragazza che toccano per la prima volta.
L’uomo che vende l’aria in Terrasanta è un po’ la versione ebraica di chi vende la Fontana di Trevi, un uomo a cui non è andato bene nessun lavoro e che, per tenere con sé la figlia simula, con lei un gioco che risulta un imbroglio per turisti. La bambina probabilmente capisce l’imbroglio e asseconda il padre, senza farglielo capire, accettando di giocare con lui alla logica del campeggio, un modo poetico di definirsi senza averi. Qualcosa di tenero viene spezzato quando le illusioni non sono più proponibili di fronte a una casa saccheggiata dai creditori, tutta la vita sparpagliata e offerta a chi la prende.
Una donna che ha perso il figlio filma i soprusi dei soldati israeliani ai check point, e per lei la telecamera è un modo per sfuggire a una solitudine troppo rumorosa, dove il vuoto del ragazzo ha creato una frattura fra i tre componenti rimasti, che si sentono esuli nel loro stesso spazio vitale. L’aggressione da parte di un ebreo ortodosso e il conseguente salvataggio di un soldato, diciottenne come il figlio, ucciso da fuoco amico i primi giorni del combattimento, sono una breve tregua al senso di dolore e di inazione che la pervade. Una piccola, minuscola possibilità di rinascita.
Non c’è nessuna comfort zone emotiva nei protagonisti, ognuno di loro vive una doppia vita, come la ragazza che non riesce a dimenticare il suo primo amore, Salim, un ragazzo beduino che contrabbanda oggetti di prima necessità, sulla striscia del confine israeliano-egiziano, nel deserto del Sinai. Il ricordo degli occhi di Salim, uno azzurro e uno verde, e il loro primo bacio incerto di saliva e desiderio è ancora uno dei ricordi più belli che ha. La loro storia è una storia impossibile da vivere, rimangono separati come i loro paesi in guerra.
Rachel e Leah sono una figlia e una madre invalida che vagano per sette giorni in cerca di notizie su chi dei due figli di una e fratelli dell’altra sia morto, e chi invece sia ancora vivo. Affrontano pericoli e cecchini e intemperie e sfidano tentativi di stupro nel loro cammino, che diventa una sorta di Shivà (i sette gironi di lutto stretto in cui ci si straccia le vesti e si coprono gli specchi) itinerante, il tempo per andare e tornare in una casa che si chiude sulle loro solitudini.
Ogni racconto è un microcosmo in cui si muovono brulicanti umanità disperse, in cerca di nuove vite, e ognuno sta bene attento a tenersi stretto il ricordo più prezioso e doloroso, che brilla come una scheggia di vetro, un’illusione di bellezza in un campo profughi, una voce amata che ti riconnette alla felicità, una sorta di fotografia ripiegata in quattro, un bene prezioso da nascondere ai nazisti e ai soldati che perquisiscono e abbrutiscono chi la subisce, la perquisizione.
Mi sono innamorata di Salim quasi venticinque anni fa, quando gli ultimi soldati israeliani si stavano ritirando dal Sinai.
Sono cresciuta nel deserto, per cui sapevo esattamente com’era, insensibile e crudele. Il vento afferrava i minuscoli granelli dorati, li faceva turbinare e li gettava via senza pensarci due volte.
Salim viveva esposto agli elementi dietro un telone impermeabile blu appeso su un ammasso di pezzi di compensato e di metallo arrugginito in uno dei più grandi villaggi beduini non riconosciuti dallo stato di Israele. Il suo villaggio era fatto di tende e baracche di lamiera, a poche centinaia di metri da una discarica venefica. A sedici anni Salim era già un contrabbandiere.
Ricordo la prima volta che vidi Salim, una figura esile con una maglietta legata intorno alla testa per proteggersi dal sole. Ero abbastanza vicina da vedere che aveva gli occhi di due colori diversi: quello sinistro era verde, quello destro era azzurro.
…E poi, senza riprendere fiato, mi disse che poteva ancora sentire il mio sapore sulla lingua, e che pensava alla mia pelle liscia, al profumo del mio shampoo. Mi disse che aveva pensato di raccogliere tutta la sabbia del deserto, tutti i regali del mondo, per darmeli, perché io lo perdonassi.
Ma non era il contrabbando che gli dovevo perdonare – era il fatto che non potessimo stare insieme.