
La Tarologa e lo Scrittore: PORTA CON TE LA TUA PARTE LEGGERA!
Le carte della settimana sono: Forza, Matto e Temperanza.

Il mondo visto con gli occhi di una bambina può apparire deformato e sbavato agli orli, se a giudicare sono gli adulti, ma il lettore che si immerge nella visione di Andreea Paval, io narrante della storia, smette di essere adulto ed estraneo e finisce con il sentirsi addosso la piccola vita di Andreea, esattamente come sono state piene di minuscole e fondanti abitudini le nostre vite bambine. Ho empatizzato molto con questa bambina, la seconda della classe, a volte crudele, a volte gentile, nel modo distratto proprio della preadolescenza, quando il desiderio di essere popolare diventa più importante dell’approvazione materna o dei risultati scolastici.
Andreea ha 10 anni, vive in una piccola città della Romania con la madre e la sorella maggiore in un equilibrio familiare faticoso e precario, dove l’assenza del padre per le figlie ha smesso di essere un peso ed è diventata una realtà. La comunicazione con lui di solito si limita a una serie di messaggi che, per Andreea, hanno la consistenza liquida di un ringraziamento a un’entità incorporea, mentre la madre vive molto male l’assenza del marito. Il mondo di Andreea è limitato dalla pasticceria, dalla libreria, dal cimitero, dai cartoni e dalle serie tv americane con i sottotitoli, e dalla Strada della Pace, uno snodo stradale pericoloso e trafficato che rappresenta la linea di confine, oltre il quale ci sono tutte le possibilità eccitanti che rendono le giornate, segnate dai compiti e dalla sopravvivenza agli umori instabili della madre e della sorella, degne di essere raccontate ai compagni di scuola. Un giorno il padre torna e porta tutta la famiglia a Torino, dove lavora come operaio edile, sottraendo Andreea alla Romania, che “sembra un film in bianco e nero”. L’Italia però è un luogo di rossi e verdi psicopatici, accecanti, dove la tranquillità del mondo conosciuto si disgrega nel desiderio di fuga (impossibile) e nell’obbligo di adeguarsi al ritmo imposto dagli adulti. Il suo nome ottiene sempre un fondo acido di meraviglia “Andreea con due e?” e quello che le rimane, visto che nascondersi fino a diventare invisibile è un gioco che non le riesce, è mimetizzarsi e imparare a mettere insieme suoni coordinati per farsi capire. Il linguaggio struttura le relazioni tra noi e gli altri, le parole dicono di noi quello che vogliamo far sapere al mondo, che non ci lascia in pace, ci incalza, ci costringe a rispondere alle richieste, all’idea che si fa di chi siamo. Perdere i suoni in cui siamo cresciuti è il taglio netto con il cordone ombelicale più forte, il nostro territorio emotivo più sacro, perché “non si cresce in un luogo, si cresce in una lingua” e il modo in cui chi amiamo pronuncia il nostro nome ci rende familiari a noi stessi. Andreea impara l’italiano con velocità sorprendente, ma fa di tutto per tenersi attaccati addosso e dentro i suoni vocalici rumeni, le aspirazioni e gli accenti, sapendo che, se li perdesse, non sarebbe più al sicuro.
“Seduta al mio banco, mentre loro parlano, e il freddo e il grigio e il buio delle prime ore del mattino appannano le finestre, e nella classe la luce la luce è soffusa e calda, io smetto di esistere. Sono invisibile. Mi fanno esistere le parole ma le parole sono al buio e io non esisto.
Noi ci dobbiamo amalgamare, come le strisce di colore sulla carta. Noi dobbiamo stare nei contorni. Noi dobbiamo avere pronunce impeccabili. Noi dobbiamo smettere di esistere in una lingua, rinascere nell’altra. Noi ci dobbiamo integrare, diventare irriconoscibili.”

Le carte della settimana sono: Forza, Matto e Temperanza.

“In genere io penso la storia ‘insieme’ ai personaggi che la devono vivere. La cosa a cui tengo di più in ogni caso è la scrittura, e una buona trama ti aiuta a portarla avanti con naturalezza, secondo me”.
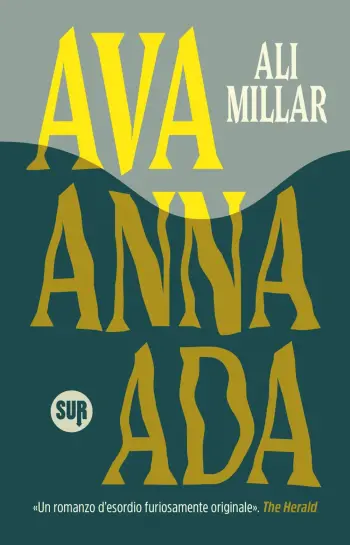
In un’atmosfera surreale, caotica, brutale, nel tempo sospeso dell’estate, afosa e appiccicosa, turisti e villeggianti attendono un evento annunciato, un’Onda che potrebbe essere una catastrofe suggestiva e bellissima da guardare dall’alto con patatine e popcorn.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare