
Agatha Christie e il “Treno azzurro”
“Disgrafia, aveva sentenziato l’ultimo dei medici consultati da quando erano apparsi i primi sintomi”.

Il genio visionario di Vollmann, che fa compagnia a Don Delillo e Thomas Pynchon nell’olimpo dei maestri scrittori di lingua inglese, in questa policroma raccolta di storie, associa un colore dell’arcobaleno a un evento o a una serie di eventi successi a lui personalmente, o alle persone che per caso o per desiderio ha sfiorato.
Storie di abbandoni, di prostitute, di intoccabili e di ultimi, storie di amori non corrisposti, storie di oggetti visti attraverso l’occhio straniato dell’umanità che li rende indispensabili, come le chiavi o il portafoglio, il libro affronta la gamma completa delle emozioni passando dai colori caldi a quelli freddi, fino ad arrivare a una bicromia bianco-nero delle radiografie che fotografano il nostro stato di salute. I nostri organi interni che assumono la cruda evidenza di scarabocchi su una lastra.
“Niente è più bello del buio più oscuro”, inizia così il cammino trascinante di questo percorso, e noi siamo dentro le sfumature del rosso acceso, del giallo e del verde (una storia in cui un uomo si innamora di un vestito verde e lo corteggia e parla con lui, fino a impazzire quando lo perde), per arrivare al territorio freddo dei blu e del violetto, dove il blu è il colore gelido dei corpi marmorizzati dei barboni uccisi e decapitati da un serial killer che chiama sé stesso Zombie, e il violetto è una frammentazione di ibridi di corpi e arti mozzati e riadattati con esigenze meccaniche da ingegneri pazzi o in cerca di forme più estreme di macchine al servizio del cervello umano. I più spietati omicidi di civili a Varsavia perpetrati dai tedeschi, ricordi di un testimone bambino, sono equiparati al rigore estremo delle macchine che eseguono gli ordini, sprovvisti di umanità.
Il linguaggio di Vollmann, che paragona in un punto del libro la tristezza al colore del legno stagionato, è un’incursione nella metafora e nelle forme stilistiche adatte a raccontare un’umanità sperduta, oltre l’innocenza, ma che non manca di una sua poesia fragile capace di suscitare empatia profonda o commozione.
La trama, pur collegando le storie in maniera salda, a un certo punto si fa labirinto e ci fa smarrire nel territorio dell’oltre, quella dimensione onirica che abita accanto a noi, e che talvolta spossessa i nostri corpi per condurci in dimensioni oscure, dove possiamo confrontarci con le nostre asperità sconosciute, i buchi neri dell’anima.
Gli spunti che danno inizio alle storie iniziano come lievi immagini e poi si ingrandiscono fino ad assorbire ogni angolo, ogni particella d’aria. Quello che sai, dopo aver letto Vollmann, è che il delirio psicotico ha ancora un grosso fascino e che non occorre parlarne, lo leggi e diventa tuo. Penso che ogni persona che scrive debba leggere almeno qualche pagina di Vollmann, giusto per sapere che la genialità, a tratti difficile da capire, può far venire voglia di scrivere, e non deve spaventare la crepa tra la realtà tangibile e il mondo che racconti, che è reale quanto le persone che puoi toccare. La tensione tra bene e male è evidente quando una ragazza dai capelli violetti, martire in pectore, diventa l’emblema dell’innocenza tradita “se volessi indurre qualcuno al martirio gli mentirei”, sostiene una bizzarra incarnazione di spirito santo sospeso tra senso di colpa nel volere umanità da santificare e folle desiderio di amare chi gli si nega.
Quando ti guardi allo specchio stai attento: puoi vedere parti di te che fai finta di ignorare, parti mostruose e pezzi di desideri che possono imbarazzarti ma pure sono qualcosa di tuo, anche se segreto.
Macilenti, unti, non lavati, i vagabondi camminavano per strada con i cani. Avevano lunghe barbe fluenti. A volte bevevano spalancando la bocca con stupore. Gli brillavano gli occhi. Tra i cespugli svuotavano bottiglie di porto mentre i loro giovani assistenti si infilavano una sigaretta fra le labbra per dare sostegno morale, e le ore passavano e sui visi degli ubriaconi si aprivano le piaghe, finché il cielo blu non ingialliva sui contorni delle case fredde e nere, e poi faceva sera.

“Disgrafia, aveva sentenziato l’ultimo dei medici consultati da quando erano apparsi i primi sintomi”.

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
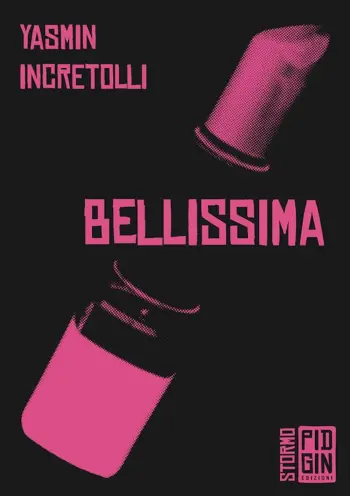
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare