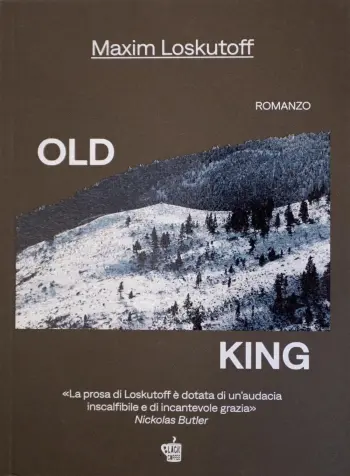Daniela Matronola torna in libreria con un volume di racconti intitolato Il mio amico, edito da Manni. Appassionata lettrice e scrittrice, Matronola è capace di frequentare molti ambiti letterari con la capacità rara di non farsi incasellare in un’immagine stereotipata e con la costante voglia di confrontarsi con i generi per rimescolarli. Ha all’attivo diversi libri di poesia, articoli critici, romanzi e racconti, interviste con autori scelti fior da fiore, ma credo che ciò che la caratterizza sia soprattutto un modo del tutto personale di frequentare i territori della letteratura, sia quella che si legge sui libri sia quella che si vive negli incontri, le presentazioni, i convegni. Presenza intelligente e spirito critico dialoga allo stesso modo con una poetessa inglese del XIX secolo o con un musicista pop contemporaneo. Abbiamo la stessa età e abbiamo fatto molti tratti di strada insieme, quindi se tira fuori la testa con un altra sua opera, per me diventa un’occasione per scambiare quattro chiacchiere sul suo lavoro, che per certi versi è anche il nostro lavoro, sicuro che i lettori di “Dentro la lampada” (il nome che abbiamo dato a questo blog della Scuola Genius) troveranno notevoli motivi d’interesse. Il libro poi, beh, il libro, Il mio amico, è tutto da leggere e da scoprire, tanto che noi ne abbiamo pubblicato un frammento quando era ancora in formazione nell’agosto del 2019…
E ora la parola a Daniela.
Prima di tutto diciamo che hai scelto una forma che ti situa a metà strada tra un romanzo e una raccolta di racconti. Quattro storie, un unico protagonista, Mauro. Sei insoddisfatta di entrambe le forme tradizionali?
Sono sempre molto piacevolmente lusingata del tuo sense of humour e della tua inguaribile aria di sorpresa di fronte a certe cose – a giochi fatti direi due cose: da un lato comprendo sempre di più che la misura a me più congeniale è il racconto: anche nel romanzo che sto scrivendo ora e negli altri che ho scritto o in parte progettato, tendo sempre a parcellizzare e a inquadrare più da vicino, facendo un gioco di zoom e distanziamento che mi serve a mettere a fuoco; dall’altro lato, perlopiù vedo il romanzo come un caleidoscopio, un mosaico con molti pezzi indipendenti da intersecare per non forzare i legami ma per suggerirli, come una delicata e frangibile tela di ragno. Forse si capisce da questo che la mia immaginazione è soprattutto visuale, e l’invenzione è una forma di detection che ha il compito di scovare legami inediti, di svelare una chimica non scontata. Per cui direi che finora ho trovato una sorta di “marcatura a zona” che pedina le vicende e una “marcatura a uomo” che bracca il personaggio. Le liane volanti del resto sono il pane quotidiano del mio ermetismo nella poesia, l’altro versante della mia scrittura. Ma riesco a dirlo ora che ho qualche libro al mio attivo e questo “sistema” si è svelato anche a me…
L’idea di un anestesista come protagonista mi ha molto colpito. È un lavoro diventato oggi di attualità, ma quando l’avevi scelto per scrivere, il Covid-19 non era ancora all’orizzonte, giusto?
Il mio discorso è sul dolore, o meglio sullo scongiurare il dolore, che è un’ingiuria all’integrità della persona. Quando Mauro mi si è manifestato era già (da poco) un anestesista, già però molto prodigo su molti fronti verso i pazienti – estranei nei quali riconosce propri simili titolari di diritti. Dopotutto una questione politica. Cioè una faccenda di diritti fondamentali dell’uomo, dei viventi in generale. Il suo ospedale (sull’Isola Tiberina già nell’anno Mille sembra ci fosse un ricovero per ammalati gestito da suore benedettine, poi il Fatebenefratelli fu fondato verso la fine del ‘500 da San Giovanni Calibita – Juan Ciudad detto Giovanni di Dio –: l’ospedale tuttora fa capo alla sua congregazione, pur essendo una struttura pubblica) non è un ospedale Covid, anche se ha naturalmente adottato tutte le misure relative, una di queste è purtroppo l’impossibilità di visitare i piani interrati dell’ospedale dove sono stati rinvenuti, ed erano stati resi disponibili come patrimonio museale visitabile dal pubblico, resti di epoca romana: come sempre il culto cristiano anche in questo caso ha rispettato il culto pagano precedente riusando are e aree dedicate agli dèi pagani. Pare proprio che lì sotto ci fosse un intero tempio dedicato proprio ad Esculapio. Quindi il sito nel tempo e sulla lunga distanza è stato sempre teatro di prestazione di cure. Mauro ha un caro amico tra i confratelli dell’istituzione religiosa, Fratel Lorenzo, con cui per anni ha fumato e discusso sul Ponte Fabricio nella pausa a fine mattinata: ora i confratelli hanno abbandonato l’Isola Tiberina, e meglio sono stati spostati in un’altra sede, e Mauro ha perso l’abitudine di confrontarsi con questo sparring partner che ogni giorno non ha mancato per anni di dirgli che, per quanto si proclami ateo, Mauro è uno dei cristiani più attivi che Fratel Lorenzo abbia mai incrociato in vita sua, e soprattutto ogni giorno non ha smesso, Fratel Lorenzo, di tentare di convertirlo… Mauro ne ride molto, e non manca, sempre, di riflettere sull’omonimia dell’amico con il frate che materialmente innescò il casino con tragedia finale in Romeo e Giulietta… Mauro e Lorenzo sono sempre amici, fratelli d’elezione dopotutto, e anche se si vedono molto meno, sono spesso connessi.
“Il dolore, una volta provato, diventa un patrimonio della memoria” scrivi.
Esiste una memoria della mente ma anche, prima ancora, una memoria (chimica) del corpo. Come si sa specialmente alle partorienti si ripete sempre, Tanto poi tutto questo dolore te lo scordi. Sul piano razionale è vero, è così, ma nella chimica del corpo e nella mente nascosta quel dolore rimane: è una specie di bottone che inchioda i tessuti, i ricordi, l’animo. E riaffiora, richiamato in modi impensati: bè, allora meglio non provarlo per niente – infatti Mauro è un mago dell’epidurale, e dei blocchi regionali. E poi il dolore stressa i tessuti e impedisce la guarigione o perlomeno la rallenta in modo significativo e dopotutto seccate. In altre epoche non lontane il dolore era considerato un dazio, una specie di pedaggio da pagare alla malattia, si dava per scontato che essere malati comportasse una quota, grande, di dolore fisico, che finiva per inchiodare la coscienza psichica. Bè no!, dice Mauro, ciò è inammissibile, antietico. Nella sua deontologia, prevenire o tacitare il dolore è un punto d’onore, una buona pratica. Quando seppe che negli Stati Uniti un oscuro anestesista di Brooklyn già negli anni Settanta aveva inventato e messo in esercizio sui pazienti l’elastomero, cioè la pompa antalgica che permette di autodosarsi il cocktail di antidolorifici in vena (versione virtuosa della tossicodipendenza al suo picco in quegli anni), Mauro decise, molto dopo, non avendone potuto usufruire nell’81 quando ebbe un certo incidente, di andare a cercare l’anziano collega per poterlo ringraziare. Ma non lo trovò. Era via, in Cina, a specializzarsi in agopuntura. Parlò con i suoi colleghi più giovani, già questo gli diede la sensazione di aver fatto ciò che si era messo in testa.
Il tuo personaggio è un appassionato lettore, musicista, ha un’anima d’artista si direbbe, penso che ti somigli. Volevi che ti somigliasse?
Mauro e io abbiamo in comune un intero patrimonio culturale in senso lato, anche perché siamo nati negli stessi anni (lui è più grande di me, di un anno): certo, come dicevo agli studenti (stupendi) di due terze medie dell’Istituto Alzavole a Torre Maura (ah, vedi?) con cui ho dialogato lunedì mattina per il progetto Libriamoci, a me piace la musica, e i chitarristi, lui è chitarrista; mi piace il tennis e i tennisti, ma sono una schiappa a giocare, lui è un campione; mi piace la vela e spero sempre che gli amici mi portino in barca, lui è velista; anche lui è un forte lettore però mentre io lavoro con la lett(erat)ura, lui ha un rapporto con i libri che vado a illustrare. Leggere per lui è una specie di tecnica di assorbimento da un lato (quando ha studiato per esempio gli esami del corso di Medicina, su volumi di migliaia di pagine, gli è bastato leggerli e li ha assorbiti); e poi a lui leggere letteratura piace ma soprattutto c’è stato un tempo in cui leggere significava pescare in biblioteca i libri letti da suo padre e rintracciarvi una serie di segnali del “suo passaggio”, faceva cioè parte di un programma di pedinamento e di investigazione che ha dato i suoi frutti. Non credo di poter dire che ci somigliamo, anzi siamo diametralmente diversi, non solo perché lui è uomo e io donna ma soprattutto perché siamo tipi proprio diversi. Il punto è che, come dicevo sempre agli studenti di Torre Maura, io, quando l’ho trovato, mi sono subito messa in ascolto. Non ha affatto un’anima d’artista, Mauro, è l’opposto dell’artista. Anche perché poteva diventare prima un professionista della pallavolo poi del tennis, poteva fare il musicista e diventare una popstar, poteva volendo trovare spazio nel mondo letterario in cui peraltro ha non poche conoscenze, persino amici, come ne ha nel cinema, e avrebbe i numeri per essere un attore. Ma lui è un medico. E non ha nessuna voglia di beccarsi la fama. Vuole rimanere un anonimo samaritano. Eppure quando entra in una stanza o si fa vivo in un gruppo di persone, lascia il segno – ha carisma, come usa dire.
A un certo punto viene inserito nella storia un famoso musicista rock reale, come mai lo hai scelto?
Non l’ho scelto, questa amicizia speciale è arrivata un po’ da sola, come dotazione del personaggio.
Appartiene agli incontri, molti, fatti da Mauro nella sua vita: questo in particolare quando aveva 16 anni e non era per niente felice – come forse non è stato mai. Poi però si è accorto, specie in certe circostanze, che il poco che si ha è di per sé una forma di felicità, a cui si accompagna anche la “saggezza” di questi anni recenti: saper accettare. Elegantemente la rockstar non è mai nominata, ed è bene che non lo sia. Perché appunto, Siamo tutti niente. Ma la felicità è essere una certa sera in un teatro, a suonare con tutti gli altri durante le prove di uno spettacolo, a Manhattan dalle parti della 57ma ovest, mentre Mauro era là per un periodo a prestare la sua opera di medico in un reparto di oncologia pediatrica e aveva dovuto rifiutare l’ospitalità dell’amico dall’altra parte di Central Park rispetto all’ospedale, perché nel ‘pacchetto’ della prestazione d’opera e di contemporaneo addestramento, gli era stata data una casa a Willy, Brooklyn. Felicità è anche stare una sera a cena a Milano in un gruppo di amici: tutti gli altri sono musicisti registi attori eccetera, eppure regna la più assoluta normalità e allegria di gente che condivide un pasto. Forse aver scelto proprio quel tale musicista dipende dal fatto che, un certo anno, per mesi, facendo su e giù tra Cassino e Roma ho ascoltato e cantato allo sfinimento un certo disco, e, adesso che mi ci fai riflettere, è stato piuttosto il cantante a mediare tra me e Mauro, e non viceversa.
Nelle parole scambiate in uno dei racconti c’è la presenza terribile del sadismo nazista, dici: “Ci provavano gusto, restavano schiavi del proprio stesso sadismo”. A parte gli orrori della guerra, vedi questo anche tra noi oggi?
Bè il sadismo non ha una marca, è sadismo che poi tende ad ammantarsi di giustificazione ideologica – è fin troppo ovvio ripetere che certe raffinatezze crudeli non erano tanto una novità, quanto che, in un certo momento storico e in determinate ‘cornici politiche’, hanno goduto di ulteriore affinamento e gusto, dopotutto, per effetto di un’alienazione patologica, l’astrattismo industriale applicato ad una materia tenera come la carne umana, che certo è specifica del Novecento, ma è variante ennesima, anche, della macro categoria del sadismo. Però io in IL LAVORO RENDE LIBERI volevo alludere alla crudele ambiguità del linguaggio, che oggi dilaga, ‘sdoganata’ come usa dire dalla pubblicità e già denunciata da George Orwell (cioè Eric Blair) in 1984 attraverso le beffe del NewSpeak. E volevo pure mostrare che la tecnologia e tutte le risorse che l’uomo ha brevettato nel tempo per spianare le difficoltà del quotidiano possono trasformarsi in strumenti di tortura: il lavoro (forzato e del tutto a vuoto) può diventare uno strumento di vessazione e di morte; la tipica parcellizzazione dei compiti nella catena di montaggio industriale, il fordismo applicato alla materia-uomo, deresponsabilizzava gli aguzzini, o così argomentavano i nazisti ma anche gli scherani stalinisti. Si potrà dire che in fondo lo sapevamo già, dunque la reazione di chi legga essendo avvertito di tutto questo potrebbe suonare in modo simile a quei famosi versi di T. S. Eliot in The Love Song of Alfred J. Prufrock quando il suo anti-eroe dice esausto: I have known them already, known them all– / Have known the evenings, mornings, afternoons. / […] I know the voices dying with a dying fall / […] And I have known the eyes already, known them all– / And I have known the arms already, known them all–, come a dire, Marò, mo’ n’ata vota mo’, tutto da rifare e da ricapitolare, tutto daccapo. Qui Eliot, o meglio il suo personaggio, si riferisce alla specifica, morbosa stanchezza che è data dalla noia di dover, come Sisifi felici (l’inganno è doppio), rivivere tutte le note fasi di un processo, nel suo caso dell’amore, che poi è l’eros, è il sesso (the overwhelming question, la questione martellante). Dover replicare il dramma. Perché il vero guaio è la ripetizione. Ecco, ce l’ho fatta. Sono arrivata al punto! LA STANCHEZZA. Che si aggrava di noia per la ripetitività dei gesti. Dopotutto nella prima sequenza narrativa, LIQUOR, il vero fattore ammalante è lo stress da ripetizione, tant’è che i sintomi, ancorché incidenti, sono vaghi, e lo stesso protagonista, appunto da medico, e da docente di Patologia Clinica, distingue subito tra causa scatenante (non ce n’è stata una) e spina irritativa (cioè accumulazione di fatti e circostanze che sommandosi hanno innescato una sindrome). Proprio perciò LA STANCHEZZA in questione non è un fatto episodico e neppure soltanto personale, è una condizione esistenziale che si allarga al genere umano, subissato di sollecitazioni e stremato da una vita troppo densa e contemporaneamente famelica, mai sazia – in una coazione a ripetere, come gradirebbero siglare gli psicospecialisti. La questione è filosofica, invece. È speculativa. È un grumo del pensiero.
Che rapporto hai con le citazioni quando scrivi? Le sistemi scientificamente o ti vengono casualmente?
Mi vengono in mente, mi assalgono, mi danno l’assalto e io non le freno. E sono anche condivisione di un patrimonio comune, di un bacino di esperienze che ci accomunano, che anzi affiorano come altrettanti percorsi di intesa. E poi sono anche fattori esponenziali del nostro comune orbitare nel mondo. Credo,
Ti piace recensire, poetare, narrare, romanzare, sempre allo stesso modo o c’è una scrittura che preferisci?
Bè, ogni scrittura ha i suoi codici e soprattutto agisce, cioè si sviluppa, in un suo modo specifico. Io tendo a sfruttare i tasselli comuni tra i diversi strumenti, come si fa nell’insiemistica: preferisco che si verifichino fruttuose sovrapposizioni, per ragioni, diciamo così, generativo-trasformazionali, che qui però non riguardano la tecnica della lingua altrimenti detta grammatica (chi sto citando stavolta?).
Per noi di Genius tieni una fortunata rubrica di poesia, com’è lo stato delle cose, oggi?
La poesia secondo me è in un periodo ottimo. E comincia persino a prendere quota come situazione sociale. Ecco questo è un po’ se vogliamo anche l’inizio della fine. È facile dopotutto scrivere poesia, scoprirsi poeti, e diffondere i propri versi. Io stessa per un certo periodo ho ‘postato’ versi sui social e ho avuto il piacere di vedere i like, leggere le reazioni in genere positive, crogiolarmi nel favore dei lettori. Ma poi la faccenda, al netto degli strumenti, è sempre la stessa: il valore lo misura il tempo. Se quei versi, quando ti riappaiono, sono ancora buoni, allora forse avevi scritto poesia. Se leggendoli, i versi ti risuonano dentro o fuori come insostenibili ragli, bè forse non si trattava di poesia e si può rimetterci le mani oppure cassare. Un bel colpo di cassino (!) social-mediatico e passa la paura. E poi magari usciamo dall’imbuto del qui e ora, liberiamoci dai legacci del tempo e torniamo a quel cerchio infinito che è la tradizione: subentra un meccanismo di confronto che, ferma restando una legittimità dettata dal proprio tempo di cui i nostri versi cercano di riflettere l’essenza, è la chiave della valutazione un po’ più ponderata di quel segreto custodito nella nostra profusione di parole, il valore della scrittura. Ma è sempre tutto da rimettere in discussione, la messa in questione non si placa mai. L’assoluto è una chimera. E una grande prova d’arroganza: attenzione all’ira degli dèi.
Conosci e frequenti diversi scrittori, da molto tempo, sono amici facili o difficili?
Chi di noi è facile? Nessuno! Non foss’altro che per il fatto che ognuno di noi è un mondo chiuso che tenta di compenetrarsi con alcuni altri. Trovare zone di sovrapposizione (di nuovo l’insiemistica) è arduo però fa della faccenda una sfida agonistica. L’escamotage è lasciar perdere, non lasciarsi fare fessi dall’aura mistico artistica dello scrittore o della scrittrice. Siamo tutti niente, dice Matt a Mauro, ed è sano ripeterselo. Dopo di che, se si è amici sul serio, magari la strada è un po’ spianata rispetto al frequentarsi per convenienza – ciò che alcuni fanno. Ma ci sono mille stadi intermedi. C’è chi si frequenta come colleghi e poi si sceglie per inaspettata, genuina amicizia. C’è chi sta lì a fare le pulci agli altri, a cogliere sempre tutti in fallo e a far pesare la ritorsione. Chi semplicemente è amico ma ti prende e va preso con le molle. Condividere la letteratura facilita i rapporti? Boh! A volte sì a volte no. Io so solo che la letteratura mi ha fatta imbattere in alcune squisite persone che sono ormai veri amici o vere amiche, senza ombre, e l’elemento letteratura è anche un mastice robusto. Con altri o altre non è successo. C’è uno con cui per ragioni a me completamente ignote sempre di più si è alzato un muro di fastidio. È reciproco – o forse è tutto un equivoco. Ciò mi consola. Vuol dire che anche se sono polla, non lo sono del tutto. Però un po’ sempre lo sono, visto che sono assalita sempre da mille dubbi, d’aver capito o di non averci capito niente. Ma ogni suo scritto è un monumento alla letteratura. Per sapienza. Per scrittura. Per (udite!, udite!) sensibilità. E non posso non riconoscerlo e non scriverlo. Ecco, piuttosto questo. Amici o amiche e no, io non lesino il riconoscimento del valore della scrittura altrui scrivendone. Di questa stessa squisitezza non mi è dato godere. Lo ammetto, il non riconoscimento mi dà dispiacere. Non essere considerata mi ferisce. Ma bando alla tristezza.