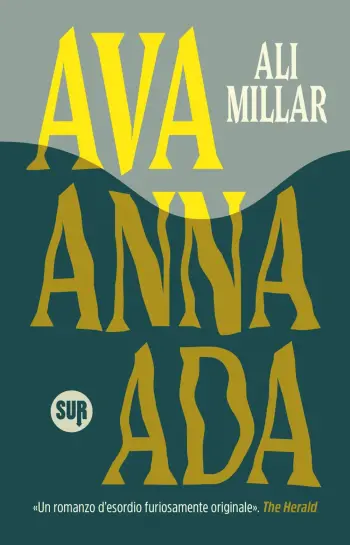L’editore Quodlibet sta riproponendo in questi anni le opere di Giani Stuparich, ultimo esponente della grande stagione della letteratura triestina. Dopo Guerra del ‘15, riedito in occasione delle commemorazioni dei cent’anni dall’inizio della Grande Guerra, e Un anno di scuola, riproposto due anni dopo, è ora la volta de L’isola, a cura di Giuseppe Sandrini, che comprende sia l’omonimo racconto del 1942 che Il ritorno del padre, pubblicato per la prima volta nel 1933.
I due racconti sono intimamente legati dal tema (il rapporto padre-figlio) e dai rimandi interni (l’episodio descritto nel racconto del ’33 viene ripreso in quello successivo), dando così l’impressione di frammenti di un’unica narrazione, tant’è che sono stati collocati rispettivamente all’inizio e alla fine del volume antologico pubblicato nel 1961 da Einaudi col titolo Il ritorno del padre. Entrambi traggono spunto dall’esperienza autobiografica dell’autore, che si trova a fare i conti con la figura paterna, la figura di un uomo vitale, allegro, generoso, avventuroso, insofferente a qualsiasi legame.
Le chiacchiere familiari, che ne Il ritorno del padre precedono come un’aura negativa la figura del genitore, di ritorno da uno dei suoi lunghi viaggi per mare, presentano al figlio l’immagine di “un avventuriero, un uomo senza scrupoli, un violento nelle sue passioni, che aveva abbandonato moglie e figlioli per menare una vita randagia”, ma non gli impediscono di farsi un’idea ben diversa di lui, basata su un unico e luminoso ricordo della prima infanzia, quella di “un uomo forte, dalla voce poderosa come un tuono, … un uomo libero, non legato ad una casa, com’erano tutti gli altri uomini che conosceva”. E quell’immagine, delegittimata dall’astio con cui viene proposta e sorretta dalla cieca fiducia del figlio nella protezione paterna, trasforma tutte le condanne udite in famiglia in esaltazioni. Il bimbo accoglie con gioia, ma anche con trepidazione e angoscia, il ritorno del padre e spera che l’incantesimo di quel ritorno non svanisca, che il padre lo accolga finalmente sotto la sua ala protettiva. Il padre a sua volta si troverà impreparato davanti a quella figurina esile, pallida e trepidante della quale non si è mai occupato ed alla quale è legato da un legame di sangue. Tra i due si instaurerà un sottile gioco di sguardi, prima evitati e poi sostenuti, di parole semplici ed efficaci (un papà dal “tono straordinario” mormorato dal bimbo, un uomo dal “timbro misterioso, energico e pieno di risonanze” pronunciato dal padre) e di gesti densi di significato (il tè preparato maldestramente dal padre per alleviare il mal di denti del figlio, le foglie di malva trattenute in bocca da quest’ultimo fino alla nausea pur di non deludere il padre. È un gioco crudele e ricco di pathos che viene condotto sull’orlo dell’abisso, l’abisso di un nuovo e forse definitivo distacco, e che innescherà una corrente di sentimenti inediti tra padre e figlio.
Il genitore che troviamo nel racconto che dà il titolo al libro è una “quercia minata nel midollo”, un uomo condannato da un male incurabile, che tuttavia mostra ancora, pur velati da “infinita mestizia”, la forza, il coraggio e la dignità dell’uomo di un tempo. Al figlio chiede di accompagnarlo per alcuni giorni, per l’ultima volta, a Lussino, l’isola quarnerina dov’è cresciuto. Il figlio interrompe la sua villeggiatura in montagna e intraprende col padre il viaggio in motonave verso l’isola. Lì saranno ospitati da una vecchia amica di famiglia, che ha perso in mare il marito ed il figlio e la cui casa, carica di oggetti provenienti da ogni parte del mondo è “una specie di bazar: la caratteristica casa dei navigatori di lungo corso”. In quella realtà di marinai e di pescatori, echeggiante di viaggi e di imprese lontane, in quell’isola, frammento di un arcipelago montagnoso tinto di un “azzurro denso di masse cristalline in fondo all’azzurro liquido”, il padre sente il conforto delle proprie radici, mentre il figlio, amante della frescura e della purezza delle atmosfere alpine, si sente doppiamente oppresso: dalla canicola, che imperversa pure la sera, accompagnata dal “perfido ronzio” di nugoli di zanzare attorno ai lampioni, e dalla malattia del padre. Un peso quest’ultimo che non sa come affrontare, dibattuto com’è tra il proposito di reggere a quel gioco di finzioni e di reticenze, che invariabilmente si instaura tra un condannato e chi gli sta vicino, e quello di gettare la maschera, affrontando la realtà in un estremo, virile atto liberatorio prima che il nulla si popoli di rimpianti. C’è un momento in cui al figlio si disvela la bellezza aspra e seducente dell’isola. È quando decide di nuotare in mare aperto, nel punto in cui un istmo separa le placide acque del golfo da un mare profondo, rigato da creste spumeggianti, dove nessuno fa il bagno perché vi girano i pescecani. Lì capisce “di quale coraggiosa e tenace sostanza sia formata l’isola: un pugno di terra, in mezzo alle furie ed ai capricci d’un elemento indomabile, in continuo pericolo d’essere sgretolata”. E capisce meglio “il carattere degli uomini nati nell’isola, che s’eran sentiti nelle ossa la sua struttura e nel sangue la sua inquietudine,” e suo padre “che non voleva rassegnarsi a saperlo più innamorato dei monti che del mare”.
Il rapporto padre-figlio, che nel racconto Il ritorno del padre è quello tra un uomo energico e vitale, che mal sopporta i vincoli familiari, e un bimbo fragile e sensibile, che ha bisogno della protezione e della guida paterne, qui si ribalta: è ora il padre che ha bisogno del sostegno del figlio (“mi darai il braccio tu: il bastone della mia vecchiaia”), ma quest’ultimo, pur trovandosi nel vigore dei suoi trent’anni ed essendo animato dalle migliori intenzioni, sente che gli mancano la forza d’animo e le parole giuste per rendersi davvero utile (“Poterlo aiutare! Che cos’era capace di fare lui per suo padre in quel momento? Nulla”). È ancora il padre, fiaccato dalla malattia, sofferente, denutrito, incapace di inghiottire, a tenere con grandi sforzi un atteggiamento forte e dignitoso, a rassicurare il figlio, a scusarsi per averlo costretto ad abbandonare le sue montagne e perfino ad animare e rallegrare la casa dov’è ospitato e dove Teresa conduce una vita mesta e povera assieme alla nuora ed al nipote. Quando però il figlio, che dietro alla porta della stanza del padre assiste con struggimento alle sue notti tormentate dalla tosse e dall’insonnia, si accorge che sul suo comodino c’è una Bibbia aperta (“pochi libri gli aveva visto in mano”), si rende conto della sua disperata fragilità e ne prova una gran pena. Fino a quel momento “conosceva suo padre tra gli altri uomini, lo conosceva nella relazione con sé, ma come egli fosse da solo a solo lo vedeva in parte appena ora”. Capisce allora che la propria presenza, per quanto silenziosa e impacciata, è preziosa per entrambi: per suo padre, che potrà rendere il figlio partecipe del proprio mondo prima di abbandonarlo per sempre, e per lui che potrà raccoglierne l’eredità umana e spirituale (“suo padre moriva restando lui, conservando la sua fierezza d’uomo superiore alle vicende, più forte del suo stesso destino”; “il figlio, partendo dall’isola e vedendola svanire all’orizzonte nell’immenso bagliore del mare, ebbe precisa e semplice la coscienza di che cosa perdeva perdendo suo padre”).
Il tema della morte è affrontato nel libro in modo asciutto, senza retorica o sentimentalismi, con quell’atteggiamento di virile e rispettosa accettazione che si ha di fronte ad un evento misterioso ed inevitabile. Fin dall’inizio si sovrappongono nel figlio due visioni: una “interna, chiusa e fredda, quasi spettrale”, che è quella del gabinetto radiologico dove il profilo di una strozzatura dell’esofago ha decretato la condanna del padre, ed una esterna, quella del paesaggio marino che dispiega le sue bellezze: un “mare teso all’orizzonte” su cui sono “sparse vele bianche e arancioni che raccolgono il sole come specchi”, “gabbiani che battono le ali inseguendo bassi la nave”, “esili vaporetti che fumano lungo la costa col moto buffo di giocattoli”. Il contrasto tra le due visioni dà alla narrazione un tono epico. Il lirismo delle descrizioni naturali ammutolisce al cospetto della vicenda umana ed il cammino dei due protagonisti, avviati l’uno dignitosamente verso la morte e l’altro verso la nuda realtà dell’esistenza, appare come una danza macabra: “Un morto ed un vivo s’accompagnavano in una buffonesca alleanza, mascherati allo stesso modo”.