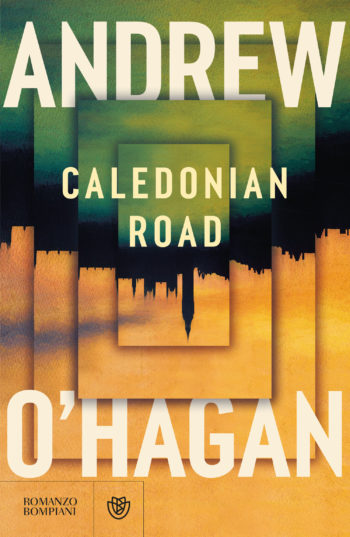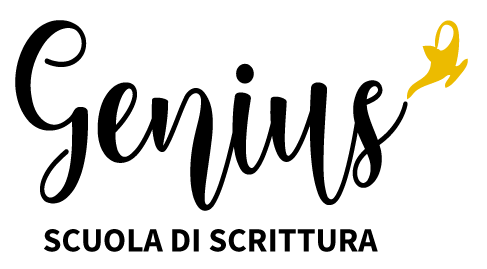Era davanti a lui, con il suo corpo piccolo piccolo e una sottile codina. Le sue dimensioni erano tali da poterlo contenere nel palmo di una mano che, se fosse stata chiusa, probabilmente lo avrebbe nascosto quasi completamente, lasciando fuori solo la magra e lunga estremità.
P. lo scrutava, osservandolo da ogni angolazione e chiedendosi cosa avrebbe potuto attendersi qualche minuto dopo.
La decisione era presa ed era irrevocabile: entro la mezz’ora seguente lo avrebbe dovuto mangiare, un pezzetto alla volta, senza fretta. Erano quelle le condizioni fissate, quelle a cui aveva acconsentito. In fondo era stato lui ad aver fatto la proposta ai suoi amici Giovanni, Paolo, Leonardo con cui formava un quartetto inseparabile. Da quando i suoi si erano lasciati, la vita per lui era cambiata: si sentiva e restava molto tempo solo, senza persone con cui parlare e neanche, come era avvenuto nell’ultimo anno, litigare. Era con uno dei genitori, in particolare il padre, con cui il rapporto era più teso. Con lui non era più possibile confrontarsi, ma neanche scontrarsi, se necessario. Improvvisamente, e senza un motivo chiaro, era diventato un uomo disinteressato sia nei confronti del figlio che della moglie (la madre di P.). Entrambi gli
avevano chiesto ripetutamente una spiegazione. C’erano problemi sul lavoro, di salute o forse economici di cui aveva timore a parlare? O forse, chiedeva la moglie, era entrata qualcun’altra nella sua vita?
A queste loro domande seguiva il silenzio di una persona taciturna e distratta al punto da diventare fastidioso, insopportabile persino ai suoi cari. Non era mai stato così, lo potevano confermare un ragazzo e una donna che lo conoscevano ormai rispettivamente da diciassette e trenta anni, periodi di “alti e bassi” durante i quali non c’era mai stata indifferenza; al contrario avevano sempre prevalso l’ascolto e il dialogo, sia per trovare la soluzione a un problema sia per condividere esperienze piacevoli o ancora per elargire consigli, soprattutto nel caso del figlio.
Cosa era successo questa volta? Non riuscivano a comprenderlo né sapevano come comportarsi. Dopo l’ennesimo, inutile tentativo di sedersi a parlare del suo strano comportamento, l’unica soluzione, o meglio la migliore per tutti a cui era giunta la madre di P. era sembrata quella di allontanarsi. Ne aveva prima parlato col figlio ancora per poco minorenne e che aveva deciso di tenere con sé, andando a vivere con lui
fuori città.
E proprio lì, in un piccolo borgo della provincia di Roma, P. aveva incontrato i suoi tre compagni di avventura, quelli con cui trascorreva il tempo libero, quando non era impegnato a scuola. Non aveva altri passatempi: non praticava sport, non aveva alcun hobby mentre con la madre si limitava a interagire al minimo, rispondendo laconicamente alle domande che poneva soprattutto durante la cena. Di lei non si
interessava granché. Chissà, forse con la maggiore età la distanza tra i due si sarebbe addirittura ampliata.
Cercava di trovare qualcosa di invitante nel ratto, che lo rendesse interessante e che lo convincesse a dare il primo morso.
Fissava l’animale, stroncato prematuramente e terribilmente da un infarto, causato dall’apparizione improvvisa di un gatto. Il felino lo aveva spaventato al punto da ucciderlo senza tuttavia nutrirsene. P. cercava di prender tempo, ritardare quanto più possibile l’attimo in cui avrebbe percepito sopra la lingua e sotto i suoi denti la consistenza della carne dell’animale. Come sarebbe stata? Tenera e gommosa o, al contrario, dura e difficile da masticare e ingoiare? Avrebbe avuto un sapore dolce o piuttosto amarognolo? O tendente al salato? Sarebbe risultata asciutta o succosa? Si domandava. E tornava bruscamente al presente, risvegliato dai rintocchi dell’orologio della chiesa di fronte che segnava le quattro del pomeriggio.
Come uno sportivo che avesse avvertito il segnale della partenza di una gara, realizzò immediatamente che era giunto il momento. Sollevò la bestiola dalla mano, prendendola per la coda e, lasciandola penzolare davanti ai suoi occhi, allungò il mento; poi, con un gesto fulmineo, gli addentò un orecchio. Aveva “rotto il ghiaccio” e ingoiato il primo pezzo.
L’esperienza di quel morso iniziale era stata differente da come se l’era immaginata. Innanzitutto per la consistenza della carne che, inaspettatamente, era risultata viscida, scivolosa in bocca, con il risultato che il boccone era sceso giù rapidamente, quasi senza essere masticato. Il sapore poi era difficilmente descrivibile, lievemente acidulo, ricordava l’umami, noto nella cucina dell’Estremo Oriente (meno in quella nostra, occidentale) mentre verso la fine aveva provato un effetto allappante, che “legava” denti e palato. Terminate queste brevi riflessioni sulle sensazioni fisiche realizzò che si trattava solo di un pezzo, il primo di una serie (poco meno di una decina aveva stimato). E che doveva continuare per potersi dimostrare all’altezza della sfida, facendolo nel più breve tempo possibile, entro i venticinque minuti che lo
separavano dalle 16:30. Senza accorgersene le sue elucubrazioni gli avevano rubato già poco meno di trecento secondi. Tempo prezioso, certamente, eppure indispensabile per prepararsi all’impresa coraggiosa. Per P. mangiare quello che in altre culture e tradizioni culinarie era considerato una prelibatezza, il topo appunto, era orripilante, inconcepibile; un vero e proprio incubo che si era trasformato in realtà. Certo, nei paesi dove la carne di questi animali è apprezzata viene generalmente servita cotta, spesso alla brace come in Vietnam, Thailandia e Cambogia; per lui poco cambiava: sempre di topo si trattava! Eppure l’idea di cuocerlo non gli dispiacque. Era consapevole che i minuti a disposizione per concludere il pasto erano contati ma, pensava, cotto sarebbe stato più attraente e piacevole al palato; in particolare grigliato o arrostito avrebbe perso i peli, come succede al pollo, e il gusto aspro della carne sarebbe stato meno pungente. Se poi avesse anche aggiunto qualche condimento, una salsa o qualche spezia, il tutto sarebbe stato più appetibile. Ne avrebbe alterato le proprietà ma per migliorarle, come accade con il viso di una donna, naturalmente aspro e pallido e che, dopo avervi applicato uno strato di make-up adeguatamente scelto, risulta abbellito, decisamente più attraente. Forse lo stesso sarebbe accaduto con la sua preda, pensava P. Seppure la bestiola ormai fosse morta, gli sembrava crudele infliggergli un ulteriore violenza come la combustione. Sarebbe stato così spietato da riservarle un tale trattamento? E poi avrebbe avuto il tempo sufficiente per scendere al piano inferiore e dirigersi verso la cucina, cuocerlo a puntino e insaporirlo? E ancora, disponeva delle spezie adatte? Intanto le lancette dell’orologio della camera da letto si muovevano sul quadrante con un ticchettio costante, scivolando automaticamente e inesorabilmente sul quadrante; nella sua mente il conto alla rovescia riprendeva,
intervallato dalle riflessioni sulle diverse opzioni disponibili. Che fare per ridurre il più possibile gli ostacoli che si frapponevano tra la sua bocca e il corpo del ratto? Si domandava. Nel frattempo si accorse che erano passati altri 120 secondi; aveva a disposizione due minuti in meno per portare a compimento la missione.
Diede un morsetto ulteriore, addentando la metà dell’altro orecchio, stavolta percependo sotto i denti i peletti che gli solleticavano la lingua; non si rivelò una buona scelta quella di ingurgitarne un altro pezzo; avrebbe rallentato la conclusione della tortura a cui si era sottoposto. Nel compiere questa azione, tuttavia, era prevalso l’istinto; la razionalità per qualche istante era stata messa da parte. Un altro impeto lo assalì.
Corse giù dalle scale portando con sé quanto restava dell’animale, si precipitò in cucina, prese un pentolone, lo riempì d’acqua già calda e lo mise sul fuoco immergendovi il corpo, eccetto la coda che teneva tra indice e pollice. Di una sola cosa era certo: quello della coda sarebbe stato l’ultimo boccone. Sul resto era ancora assalito da mille dubbi: l’avrebbe cotto? E se sì, bollito o cucinato ai ferri? O ancora al forno o stufato? Per facilitare la scelta considerò le differenze temporali. Due delle opzioni di cottura immaginate si auto-escludevano: stufarlo o arrostirlo sarebbe stato sicuramente troppo lungo. Restavano le altre due; anche queste però avrebbero richiesto tempo, alcuni dei pochi preziosi minuti rimasti. Magari avrebbe forse potuto accelerare il processo di consumo allungando quello di preparazione. Ma come
regolarsi? C’era anche un’altra ipotesi che, senza aver risolto il dilemma precedente, lo tentò: quella di fingere con i suoi compari di aver rispettato tutte le condizioni per vincere la scommessa. Avrebbe potuto nascondere le prove del suo inganno. Fare a pezzi l’animale? No, sarebbe stato un atto crudo e ingiustificabile alla sua coscienza, raccapricciante, uno spettacolo insopportabile alla vista. Oppure gettarlo
nel bidone della spazzatura e poi portarla fuori casa? Così se ne sarebbe facilmente disfatto, senza che i suoi familiari se ne accorgessero. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore (o meglio dalla mente) pensava; il compito era diventato insostenibile e l’obiettivo gli sembrava irraggiungibile. L’orologio intanto segnava le 16:17. Anche questa possibilità, però, non era percorribile. Non poteva rinunciare a una sfida simile che non aveva mai accettato ma che gli forniva un’ottima occasione per mettersi alla prova. Si trattava di superare le fobie, cedere al fascino dell’orrido, darsi una scarica di adrenalina. Era un uomo, adesso. Era stato proprio lui a proporre ai suoi amici un ciclo di prodezze da compiere nell’arco di un mese. E questa era la prima. Non poteva assolutamente tirarsi indietro.
Le lancette cambiavano posizione ma lui no. Era come imbambolato e in piedi davanti ai fornelli guardava l’altro lessarsi a fuoco lento. Pensò perfino di dare un nome al sorcetto, per ingannare il suo cervello e i suoi sensi. Come avrebbe potuto chiamarlo? Il dilemma era il seguente: lasciarsi ispirare dalle caratteristiche fisiche o, piuttosto, dal suo passato? O ancora dalla fine che aveva fatto? Certo era che tra le tre l’ultima
sembrava la scelta più improbabile. In fondo cosa sapeva del passato del topolino? Nulla praticamente. G. glielo aveva portato a casa la mattina avvolto in una bustina di plastica raccontandogli solo che il giorno prima era morto nella soffitta di casa per colpa di Romeo, l’adorato felino di famiglia. Una scena a cui aveva involontariamente assistito, un fine vita improvviso che, con la stessa rapidità con cui si era
consumato, aveva dato a G. lo spunto per la prova di coraggio da assegnare a P.
Dopo aver discusso col resto degli amici, che avevano approvato la proposta all’unanimità tra una risatina e l’altra, G. aveva preso l’auto e, compiuto il breve tragitto che separava la sua abitazione da quella di P., gli aveva ceduto il sacchetto contenente la bestiola. Appena visto il contenuto e venuto a conoscenza della prova aveva esclamato: “Che stronzi!”, riferendosi agli amici. Non si aspettava nulla di simile. I topi per lui erano un argomento tabù, ne era schifato, tremava alla sola idea che gli passassero davanti anche di sfuggita. Eppure non gli era passata neanche un attimo l’idea di tirarsi indietro, rinunciando alla partecipare alla sua prima sfida. Lui che era il più grande sia anagraficamente che fisicamente avrebbe potuto dire di no?
Aveva quindi accettato mascherando ogni esitazione, cercando di farsi coraggio. Concordati modalità e tempi di realizzazione della prova, i due si erano lasciati. G. era ripartito in fretta, promettendosi di tornare nel tardo pomeriggio, conclusa l’impresa. Salutato il suo amico, P. era montato al primo piano; sedutosi sul letto teneva in mano la bustina trasparente che, presa dall’estremità superiore, faceva penzolare. Il
sorcetto era fermo, sembrava dormisse e ancora vivo. Invece era morto, seppure da poco. Non male, pensava, almeno non avrebbe dovuto sopportare l’odore acre e nauseabondo della sua carne in decomposizione. Aveva deciso di metterlo da parte per un paio di ore per dedicarsi ad alcuni scritti che doveva preparare in vista di un’interrogazione imminente. Tuttavia non riusciva a distogliere il pensiero dalla prova che avrebbe dovuto affrontare di lì a breve e che lo ossessionava. Dopo alcuni vani tentativi di recuperare la concentrazione, rinunciò e riprese in mano la busta. Continuò con l’osservazione approfondita che aveva iniziato alla consegna dell’animale, riflettendo sull’orario migliore per l’impresa. Le condizioni da rispettare erano le seguenti: portare a termine la prova entro le 16:30 impiegando al massimo mezz’ora. Dopo un lungo ragionamento, P. decise che avrebbe posticipato il più possibile l’inizio, in modo da sfruttare le due ore che lo separavano dalla scadenza per farsi forza e convincersi a mangiare pezzo dopo pezzo il ratto. Non c’era di meglio da fare. Intanto rigirava ripetutamente tra le mani la busta trasparente: aveva bisogno di essere rassicurato, tranquillizzato e questo poteva accadere solo con una disamina minuziosa di diversi elementi che lo predisponessero psicologicamente nel modo migliore per poter “ingoiare il rospo” (o meglio il sorcio).
Doveva procedere con il terzo morso. Preso dalla fretta addentò il dorso ammorbidito dall’acqua bollente in cui era stato, soffermandosi sulle sensazioni fisiche che provava, concludendo che il sapore della carne ora era diverso. Non che da cotta fosse gustosa, ma comunque era mangiabile. Finalmente si decise: avrebbe consumato il resto dopo averlo passato in padella. Era un escamotage veloce e semplice, utile ad alterare il gusto rendendolo accettabile al palato, a creare l’illusione che fosse carne di bovino, equino o comunque di qualche specie più comunemente consumata nel mondo occidentale. Estrasse una padella dallo scolapiatti e a fuoco più che vivace cominciò ad abbrustolire il topo. Lo schiacciò con forza; avrebbe potuto aprirlo a metà sul lato lungo ma temeva che la fuoriuscita di sangue gli avrebbe causato ribrezzo. Lo mantenne intero rigirandolo più volte in modo da assicurarsi una cottura uniforme, sia all’esterno che all’interno.
Dopo qualche minuto spense il fuoco, fece scivolare l’animale su un piatto e, dopo aver afferrato una forchetta e un coltello, lo tagliuzzò a piccoli pezzi che ingurgitò velocemente, tappandosi il naso. Fece seguire all’ultimo boccone un bicchiere di rosso. Il vino gli tolse presto il gusto dalla bocca e l’incubo dalla mente. “Missione compiuta”, si disse. Non poteva crederci.