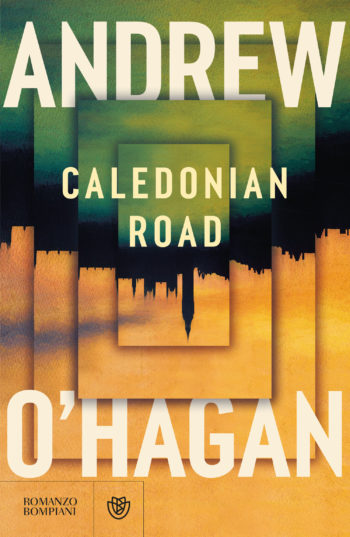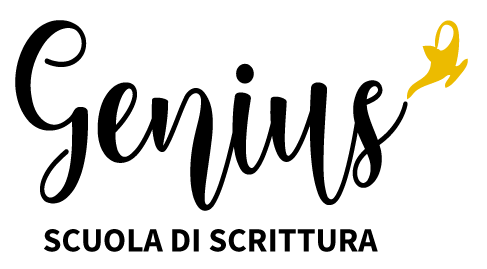Scattered Pictures BUT non-memories / frattali e non-memorie
Io so di non sapere
ma forse anche questa cosa
non la so, non so niente
ma m’inchino davanti al mistero
e oppongo davanti a lui
la mia vita nuda, ignara
lui anche fa finta di niente
fa finta di non sapere
o forse non sa davvero
eppure io mi inchino a lui
per come è tutto ordinato
ogni cosa è al suo posto
e non c’è niente che manchi
l’equilibrio è tale
che non c’è peso
siamo tutti sospesi
anche l’ignoranza non pesa.
Ascolta, quella individualità
di tuo padre, sì
è una individualità
unica e irripetibile
ma nello stesso tempo
è qualcosa che è in tutti
quelli che sono stati e saranno,
è il tuo sguardo verso di te che ti sembra impossibile
di avere perso, ma quello sguardo è un anello
della catena del numero, la totalità degli esseri.
Non un anello scompare
come non scompare la strada
che hai percorso, come in una melodia
non scompaiono le note precedenti
ma sempre in relazione al prima
percepisci la nota presente
e la presente ha senso
in relazione alle seguenti.
L’ho sempre detto io, che la Teoria della Relatività di Albert Einstein è stata più profondamente compresa e assunta soprattutto dai poeti, come emblema dello status, nel mondo vivente, di immanenza dinamica cara anche a John Keats (se ne parlava nella puntata precedente a questa). I poeti hanno subito accolto e fatta propria quest’idea della realtà come sistema che si regge, sospesa, per virtù di equilibrio e corrispondenza tra le parti, ciascuna delle quali imprevedibilmente, godendo di risorse energetiche e motilità proprie, osa lanciare lacci più o meno laschi o tenaci, diciamo lascamente tenaci, le une alle altre, in quel dinamismo virtuoso che risulta nella medesima, vitale sospensione. Il vantaggio per i poeti è non dover pedinare ogni minimo passaggio in questi intrichi di percorso come fanno l’algebra la matematica la fisica ma di potersi muovere agilmente per virtù di intuizione e per analogia, sfoggiando volteggio e armonie melodiche. I poeti hanno dalla loro l’immaginazione che salta i nodi, dunque non li impiglia, e la musica, che li libra.
Come diceva Einstein? È tutto relativo – intendendo, Tutto è con tutto correlato.
L’intera produzione di Claudio Damiani dimostra l’intuizione, di nuovo, di questo piccolo e grande segreto al cuore della ricerca del senso nello stare al mondo e del mondo di esserci, fin dall’inizio, e ora approdata a un punto alto di profondità speculativa, coincidente con la resa felice.
Giustamente Andrea Di Consoli, presentando questo particolare libro, Prima di nascere, uscito per Fazi lo scorso febbraio, sottolineava il suo valore filosofico e anche, quanto a grana della scrittura, la coesistenza di registri e stilemi che mescolano in modo disinvolto, liscio dopotutto, la prosa dentro il dettato poetico, la variazione poetica in coniugazione alla melodia prosastica.
Aggiungo che uno dei chiari segni della maturazione espressiva e tematica di Claudio Damiani in questa sua più recente raccolta è l’inclusione proprio di alcuni tipici strumenti espressivi, su tutti il dialogo, anzi meglio, la conversazione. A cui sono chiamati tutti gli esseri terrestri: anche il fiume, anche l’acqua del lago, anche il gatto, anche il monte. Il Fraturno, il Soratte. Vi sono convocati e presenti tutti gli enti del creato che sono con noi, a cui noi non diamo peso, noi umani presunti e pretesi padroni del mondo: arbitri d’ogni destino e rovina del creato – quest’epoca di guerra torna a confermarcelo.
Del resto Omero nell’Iliade dava voce al fiume, testimone immanente e mobile, muto e cangiante come tutta la Natura, della guerra umana, sta lì impotente a sorbirsi la sanguinarietà umana.
Tutto conferma la nostra arroganza, la tracotanza con cui ci viene spontaneo, come per un raptus assurdo e cieco, di sbaragliare ogni altra forma di esistenza, distruggendo fatalmente pure la nostra.
La polvere guardo nell’aria
e questa polvere sopra il tavolo
non la tolgo, la lascio,
voglio stare accanto a lei
e dei fili che sono per terra
non li levo, e le orme
delle scarpe, le lascio
e questa mosca anche lascio, morta,
e questa cosa che era caduta per terra
e non so più dov’è
non so più che era.
E mi deposito anch’io
mi lascio andare sul letto,
lascio che l’aria mi circondi
come un ciottolo che la corrente trascina.
Qui ritrovo echi spontanei di Philip Roth e di Schopenhauer. Segno che nel bagaglio a mano del poeta, di Damiani in particolare, sono sedimentate le parole di una lunga tradizione che, come si vede dai numerosi segni incorporati e, volendo, intercettabili, risalgono alla letteratura antica, greca e latina, per venire avanti e allacciarsi a noi.
Ritrovo echi del rispetto a oltranza dei Giaìni, setta a cui ha aderito la figlia terrorista dello Svedese, il protagonista di Pastorale Americana: la ragazza mette bombe negli uffici postali però non si lava e non si pulisce i denti (la bocca è una coltivazione di tartaro e carie e germi e batteri) pur di non distruggere le minime forme di vita spontanea tra cui funghi e spore. Nel grande romanzo americano questo tratto era kafkiano e paradossale, qui è il chiaro segno del rispetto di ogni forma di vita, anche la più umile, anche la più repellente. Soprattutto è il segno della resa felice, a una condizione che accomuna tutti gli esseri del creato nello spettacolo d’arte varia di esistere, di essere al mondo, di essere alla vita, a quel fato inaggirabile di essere che è e non può non essere, così come il non essere non è e non può essere e non esiste in quanto, ci dice Parmenide, non può essere pensato: pensare il non essere significa non pensare, esprimere il non essere vuol dire non parlare. Però qui ritrovo echi soprattutto dell’ulteriore evoluzione del pensiero parmenideo, il contributo di Schopenhauer che mi pare Claudio Damiani abbia interiorizzato, il fatto cioè che ogni essere o ente sia semplicemente investito (i versi sopra mi pare lo dicano chiaramente) dalla cieca volontà di vivere, cioè dalla vita come status unico, la cui unica negazione possibile sia l’uscita e/o la non entrata, come non-volontà o noluntas cioè come (impossibile) sottrazione.
Infatti in questo libro, riprendendo una felice immagine di Emanuele Severino, anch’egli (noto) filosofo, Claudio Damiani ci mostra la vita come sospensione tra due punti, il non esserci ancora (prima di nascere) e il non esserci più (la morte, l’uscita di scena), tutti noi trapezisti impegnati a volteggiare nel vuoto tra una sbarra e l’altra.
Quando ero piccolo avevo le vertigini
a pensare dove ero stato prima
di nascere, mi vedevo come sospeso
nel non essere, un infinito abisso,
ora invece so che ho vissuto
tutto il tempo per tutto il tempo che è stato
e non c’è nessuna cosa che non ho veduto.
“Ma veramente ti sembra
di non essere mai nato?”
“Ho vissuto così poco
anche se quel poco potrebbe essere visto come tanto
pensando a come anche piccole cose
possono essere grandi,
piene di verità e di mistero.
Forse anche un solo giorno basta
Per dire di aver vissuto la vita.”
“Ma tu avevi detto, avevi dichiarato
di aver vissuto tutto il tempo del tempo
come puoi dire ora che non hai vissuto?”
“Mi sembra di aver vissuto
ma anche di non aver vissuto,
di aver vissuto tutto il tempo
e di non aver vissuto neanche un istante.
Come questo possa essere
non lo so, ma è così.”
“Stai per compiere 61 anni
non è poco, come puoi dire
di non aver vissuto?”
“I momenti in cui sento
di aver vissuto sono momenti
di solitudine in cui ho sentito
qualcosa di misterioso
che era semplice, naturale e insieme proveniente
da un altro mondo,
questi momenti non hanno una durata,
non sono durati nemmeno un momento
ecco perché mi sembra di non aver vissuto.”
– Che i miei morti siano morti
non lo accetto, lo nego.
– Scusa, ma perché non lo accetti?
è infantile il tuo atteggiamento.
– Non lo accetto perché è inaccettabile.
Io sarò infantile
ma tu non ragioni.
Oltre a notare come nel tessuto del dettato poetico Claudio Damiani in modo del tutto naturale abbia incorporato la forma dialogica, che ricorre spesso, in diverse fasi chiave nello sviluppo speculativo, per così dire, del libro, questi passaggi appena riportati ci forniscono altrettanti segnali significativi di una serie di punti forti del libro lungo il percorso che esso descrive.
Per cominciare vediamo ribaltata l’idea di durata, la duration, che era stata un punto forte nella poetica degli autori modernisti; vediamo poi sconfessati i moments of being di woolfiana memoria annullati da numerosi moments of not being; tutto ciò è da ricondurre alla fulmineità dell’esperienza e anzi, mi viene da dire, alla fulmineità di quella stessa fulmineità.
In più accettare l’accettabile e non accettare l’inaccettabile, cioè arrendersi all’essere che è e non può non essere e non pensare il non essere il quale non può essere non è un giochetto di parole, una sciarada per impapocchiare tutto e infinocchiare tutti ma è la postura del filosofo-scienziato, cioè dell’uomo che (mentre si interroga sui significati profondi, e ravvisa i dati necessari alla posizione sensata di domande che se non hanno risposta abbiano almeno senso, e viene via via trovando la traccia, il filo mimetizzato e tutto da intravedere, del giusto ragionamento) si pone i giusti dubbi, indaga i territori appropriati, si muove con naturale agilità tra il mondo fisico lucreziano e la vera metafisica, quella che intuisce presenze nelle domande e non può confezionare risposte, ma deve attenersi a un’oscura urgenza in cui poi consiste la resa felice.
La notte è così nera
ma noi fortunatamente
siamo ciechi.
Il mistero è così fitto
e noi così fragili
che non ci sono speranze
o meglio, possono esserci solo speranze,
la speranza è la nostra scienza.
La notte in cui tutte le vacche sono nere non è un velo di Maja, allora, non è oscurità senza speranza, è un immenso pascolo per la mente, in cui intuire speranze, immaginare prospettive, lanciarsi ponti.
La mente la devi spingere, è questo quello
che devi fare, la devi spingere avanti
fino a coprire tutte le galassie
tutta la materia oscura e l’energia oscura,
devi spingerla e spingerla, sempre più lontano
fino all’ultimo atomo della totalità dell’essere,
non devi lasciare niente, neanche un atomo, ricordati,
anche le cose che non sappiamo, che non conosciamo,
anche quelle che non ci immaginiamo, anche quelle devi
[metterle
(lo so che è strano, ma devi fare così)
ed ecco comincerai a sentire una forza,
un’energia che penetra nel tuo corpo
da dentro. Questo è lo strano,
che non viene da fuori, come ci si aspetterebbe,
ma viene da dentro
come se – capisco che ti puoi stupire –
l’intero universo fosse dentro di te
ma tu non ci pensare, lasciala venire
e spandersi per bene in tutto il tuo corpo,
e poi goditi la sorpresa
di essere sfuggito (lo so che è strano) alla morte.
Mi pare qui trasparente, più ancora che il richiamo all’atomismo, e a un lucrezianesimo filosofico e poetico, l’eco delle struggenti parole del Maestro Battiato: Tutto l’universo obbedisce all’Amore. Per questa via (lo dimostra questa raccolta di Claudio Damiani: contemporaneamente un prosimetro che con naturalezza accoglie l’espressione in prosa e un poema filosofico) conoscere è riconoscer(si), e nascere cioè venire al mondo consiste nel ritrovarsi accolti da tutto ciò che era prima del nuovo venuto ed era là ad attenderlo, e tutta l’esistenza non è che uno svegliarsi alla mente smettendo il sogno di vivere. Come si risolve questo rebus? Così: noi conteniamo ESSERE, ne siamo sottomultiplo scalare, e l’ESSERE, l’ESISTERE è dappertutto, partecipa ed è partecipato. Lo respiriamo stando nella Natura che ci partecipa e di cui siamo frammento [vi accenna, in Nature, Ralph Waldo Emerson].
Il nostro essere come ogni essere,
uomo, animale, cosa
ha uno spazio e un tempo e in questo spaziotempo
tutto esiste e la sua esistenza è unica
non confondibile con altre esistenze
e al tempo stesso legata a tutti gli altri esseri
in un tutto unico che è la totalità divina
eterna e indivisibile,
quello che voglio dirti è che ogni essere è eterno
perché ogni istante, ogni atto del tuo esistere
rimane incancellabile nella totalità dell’essere
come una traccia che non puoi nascondere,
infatti se ci pensi – è anche molto semplice –
quello che è stato non lo puoi cancellare,
è come se la nostra vita e tutto lo spaziotempo
è registrato e niente si può perdere,
neanche un atomo sfugge a questa necessità
neanche il più piccolo istante.
Si può ragionare sull’illusione di facilità che può ingannare leggendo questa poesia, espressa in una lingua comune, semplice, semplificata quasi in alcuni passaggi. La ragione di questa scelta è forse nella sensibilità del poeta, tutta pedagogica, per la possibile sprovvedutezza del tu cui si rivolge, linguistica certo ma ancor più speculativa. In realtà mi pare di poter dire per averlo sentito che il poeta fa della semplicità un proprio abito etico e strategico, evita specialismi formali e punta invece su un grado zero dell’intellettualismo proprio per tenersi al riparo da superfetazioni che escludono dal contatto con la verità o dalla possibilità di attingerla o lambirla. E poi è anche una risorsa per un avvicinamento senza troppe complicazioni e accigliamenti al nocciolo della questione.
– L’accetti perché altro non si può fare?
– Sì, ma questo non poter fare altro non è un divieto.
Non è qualcosa che possiamo trasgredire. Siamo la nostra
morte e la nostra nascita, non possiamo non essere. Questo
fatto, in quanto verità, assume una sacralità cui possiamo
solo inchinarci, possiamo contemplare, ammirare, lodare. E,
al tempo stesso, possiamo sentire la sua forza, che penetra in
noi e ci vivifica, ci calma, ci soddisfa, e ci acquieta.
L’uomo del Soratte impara dal Soratte. L’uomo del bosco si dissocia dalla corsa alla tecnologia spinta, sta fermo al centro del bosco, aspetta e prega la sua preghiera laica di umano che confida in una laica Provvidenza, che non è né la manzoniana prefigurazione dell’intero destino umano né la verghiana barca naufragata dei Malavoglia: è la direzione verso cui corre il mondo, la dirittura dell’evoluzione che ha previsto anche la tecnica, purché senza mitologie idolatrie trionfalismi.
Non sappiamo niente,
solo ipotesi.
È vero! Se parli con uno scienziato o con un ingegnere non ti assicureranno nessuna certezza, solo manciate di dati da monitorare e continue conclusioni da trarre o indovinare, passibili di cambiare.
Chiudo riportando due ultimi stralci da questo libro che andrebbe trascritto tutto e poiché farlo è semplicemente insensato tanto vale che chi generosamente abbia letto qui decida più sensatamente di leggerlo direttamente, confrontarcisi, cogliere l’infinita ricchezza che il libro racchiude in tutte le ulteriori possibili direzioni qui per forza di cose omesse.
Vorrei essere duro
come questa pietra
che le cose le passano sopra
e lei se ne frega,
che la prendi, la rompi
e lei non sente dolore,
se la porti lontano
a lei non importa,
che non la guardi o la guardi
per lei è lo stesso,
sta per altri milioni di pietre
eppure è lei, solo lei, unica nell’universo,
nessuno la può imitare
e dire che cosa è.
Tu, Beppe, hai tagliato la testa al toro
e ti sei tolto di mezzo
come un taglio, uno sbrego
di pennino sul foglio
tu che non potevi resistere
al sole forte e alla notte
e al passare lento dei giorni
combattente di prima linea
morto giovane, tra i primi
a cadere.
Il Beppe qui nominato è Beppe Salvia, grande poeta, emblematico di una intera generazione poetica, suicida a neppure trent’anni, dopo aver partecipato, con lo stesso Claudio Damiani e molti altri, tra cui Marco Lodoli, Arnaldo Colasanti, Pietro Tripodo, Antonella Anedda, Silvia Bre, Emanuele Trevi, Gabriella Sica, Gino Scartaghiande, Edoardo Albinati, Paolo Del Colle, alla rifondazione, attorno a due riviste, Braci e Prato Pagano, della poesia italiana, reduce dai massacri del Gruppo ’63, negli anni Ottanta – segnati anche dalla sua prematura scomparsa avvenuta nel 1985.
A lui sarà dedicato un prossimo numero di questa rubrica.
La fotografia di Claudio Damiani nella pagina è di Dino Ignani