Nessun prodotto nel carrello.

Dentro la lampada
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

Nella seconda metà d’agosto eravamo nella casa tra gli scogli.
Non era una vacanza.
Eravamo lì per accumulare in fretta ricordi, inventare parole, nasconderne altre, fingere allegria e fiducia violentando sguardi, sorrisi, distogliendo gli occhi dall’enorme bombola d’ossigeno che incombeva su di lui e sui nostri pensieri. Sempre, giorno e notte.
Lui sapeva tutto, come noi, ma non fingeva. Era più forte. Forse perché aveva più paura di vivere in quel modo che di trovare riposo. Aveva sempre accettato il dolore degli ultimi anni, ma adesso la debolezza, la fame d’aria e le vertebre demolite dal cancro non gli davano pace. Da un mese camminava piegato in due, con le stampelle, sembrava un grosso insetto che arranca in cerca di un posto dove morire tranquillo. Ogni tanto accettava di abbandonarsi su una sedia a rotelle e farsi spingere fino alla casa di un vicino, per il rito dell’aperitivo che si ripeteva da vent’anni ogni giorno delle sue estati, e adesso era ridotto a una breve recita piena di ipocrisia. Un quarto d’ora, venti minuti al massimo, poi aveva di nuovo bisogno di sentire nel naso il gorgoglio dell’ossigeno.
– Se mi vuoi bene, – mi disse una volta mentre tornavamo a casa – quando sarà finita non piangere, perché vado certamente a stare meglio di così.
Mi guardava in modo nuovo, sembrava che mi chiedesse aiuto, ma non per soffrire di meno, o vivere di più. Ho capito dopo, troppo tardi, che chiedeva di fondersi in me, annullare, per il breve tempo che ci rimaneva, la distanza tra noi, che io l’abbracciassi e non lo lasciassi più fino all’ultimo dei suoi respiri corti e strappati. Anche se l’avessi capito non ne sarei stato capace. Non ricordavo che le sue braccia si fossero mai strette intorno a me.
Un giorno, uno degli ultimi, mi chiese di aiutarlo a fare una doccia. Da giorni ormai passava gran parte del tempo a letto, sudava, non si lavava i capelli da chissà quanto tempo.
Misi uno sgabello in mezzo alla doccia, aprii l’acqua perché fosse calda al punto giusto, poi lo andai a prendere e, chiusa la valvola dell’ossigeno, l’aiutai ad alzarsi e a camminare fino al bagno.
Ero annientato dalla sua docilità, una cosa nuova, lontana da tutto quello che lui era stato per me. Anche la sua nudità mi era del tutto estranea. Non avevo mai visto i suoi genitali. Avevo sempre evitati di guardare, forse per mantenere la puerile convinzione che li avesse enormi, come le sue mani, il suo cervello, il suo essere padre.
Mi spogliai anch’io. Neanche lui conosceva la mia nudità di adulto, ma in quel momento aveva altri pensieri. Voleva solo essere di nuovo pulito.
Entrammo a fatica nella piccola scatola di vetro.
Guardò lo sgabello e poi me. Gli feci segno di sedersi, e lui lo fece. Mi misi dietro di lui, diressi il getto sui capelli e cominciai a lavarli. Con la scusa di sciacquarli li accarezzai a lungo. Non mi bastava. Li insaponai ancora una volta per poterli accarezzare ancora sotto il getto d’acqua tiepida. Erano pochi, ma abbastanza per sentirli, ancora adesso, scorrermi tra le dita. Non avevamo detto ancora una parola. Strofinai il collo, le orecchie, la schiena, il petto, senza spugna, non volevo niente tra la mia pelle e la sua. Passai alle cosce ormai scarnite, e poi ai piedi gonfi e scuri. Intanto cresceva in me una emozione che mi toglieva le forze, una specie di gioia sconosciuta. Le lacrime scendevano tranquille e per un po’ si portarono via l’angoscia che mi attanagliava da quando, a maggio, mi avevano comunicato l’inappellabile sentenza: tre mesi, difficilmente più di tre mesi.
– Fammi alzare – disse piano.
Con le mie braccia sotto le ascelle, si mise faticosamente in piedi. Io, lui e lo sgabello entravamo a fatica nella piccola cabina che ci racchiudeva in un mondo nuovo, che stavamo esplorando ognuno per conto proprio, eppure insieme come non eravamo mai stati. I nostri corpi erano vicinissimi. Si appoggiò a me con forza.
– Lavami lì sotto. – disse piano – Per bene. Non mi piace quell’odore.
Lo sentivo anch’io, quell’odore. Lo conoscevo bene. Non piaceva neanche a me. Odore stantio di maschio.
Mi era cresciuto tra le gambe insieme ai primi peli, a dodici anni, tredici, quattordici, non so, e allora mi piaceva. Un odore nuovo, caldo, avvolgente. Mi infilavo le mani nelle mutande, le strusciavo a lungo per poi portarle sotto il naso, soddisfatto di me. Ogni tanto, negli spogliatoi della palestra, quell’odore superava quello del sudore e dei piedi di noi ragazzini gonfi di cambiamento. Crescendo, quell’afrore era diminuito, insieme alla mia voglia di sentirlo. Ricompariva dopo un giorno o due senza doccia, ma ormai per me era odore di maschio sporco, da togliere via appena possibile.
Presi il guanto di spugna e lo impregnai di sapone liquido. Senza quello scudo non ce l’avrei fatta.
Mi chinai.
L’odore era forte, provai vergogna a sentirlo, mi sembrava di violare l’intimità più profonda di quell’uomo del quale avevo ancora, come sempre, soggezione, tanto da rimuovere dalla mia mente le sue confidenze tardive. Trattenni il respiro e cominciai a strofinare delicatamente.
– Di più – sussurrò – per favore. Anche dietro. Per favore. – E dopo un po’ – Ecco – sospirò.
Senza guardare, avvicinai il getto della doccia ai suoi genitali e poi alle natiche, lo allontanai solo quando vidi l’acqua scorrere limpida, senza tracce di sapone.
Chiusi il rubinetto e, senza smettere di sorreggerlo, uscii dalla doccia. Con la mano libera presi il grande telo di spugna che avevo appoggiato al lavandino, lo scrollai e glielo avvolsi intorno. Lo guardai finalmente in viso. Con i pochi capelli arruffati e il viso spaurito sembrava un bambino vecchio. Per farlo uscire dalla doccia lo dovetti abbracciare. Poi lo abbracciai ancora perché si asciugasse in fretta.
Due abbracci. Mai prima. Mai più.

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
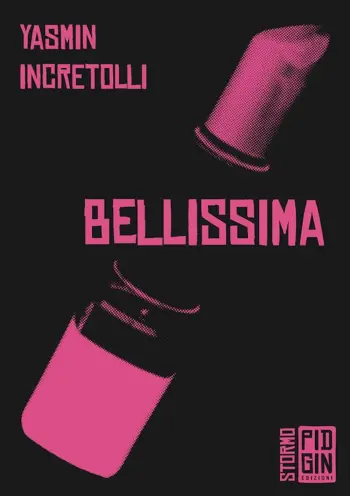
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare