Nessun prodotto nel carrello.

Dentro la lampada
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

Se la mia ombra
si chiamasse casa,
ci entrerei dentro
per farmi visita.
Abbiamo appena lasciato un architetto in versi delle case, della loro edificazione poetica, Andrea Bajani, il quale racconta e ragiona instancabilmente attorno all’idea di casa soprattutto in forma di romanzo, ed ecco che ci imbattiamo in questo libro di versi, snello e saltellante, targato Marco Saya Editore, di cui è autrice Elena Mearini: ARITMIA.
Voglio perdere
il senso dell’abitudine,
disorientarmi per vivere.
Di nuovo un autore, stavolta una scrittrice, che sceglie di affidare alla potenza quieta e folgorante, sorniona, dei versi, la propria intelligenza sensibile della vita, sul doppio tracciato: dell’esistenza che ci si rivela man mano che avanziamo nella sua esperienza e nella sua meditazione sul piano personale, e della condizione umana grazie all’apertura della dimensione singolare alla condivisione plurale.
Diventiamo poveri così,
mancando presenze
e intascando scomparse.
___________
Non c’è più niente che manca
ora che ho
tutto il resto di me.
Piccola osservazione: questo a mio avviso è un distico mancato, ma capisco che l’occhio e l’orecchio di chi formula il discorso, poetico e non, in italiano pretendano una suddivisione triadica, un accenno di terzina. Personalmente sogno un’opera in versi fatta solo di distici: non è escluso che lo comporrò.
Ho molti volti
che mi percorrono il nome,
se mi pronuncio
inciampo nella folla.
Ecco: questa idea dell’identità plurale, che subito ci fa tornare in mente i versi whitmaniani in cui ogni io è il filo d’erba che oscilla in piedi insieme a tutti gli altri per sommarsi nel mare d’erba che è la gente, è il versante aperto, costruttivo, che segue subito a un pugno di versi di tono più chiuso, questi:
Non si scappa mai del tutto,
c’è sempre un passo
che tradisce la fuga
e resta.
Anche qui, se cedessimo a un bisogno di appagamento grafico dell’occhio, più ancora che uditivo per l’orecchio, potremmo suggerire di compattare di più i versi e tirare su quel -e resta- che pende, e resta (è dunque il caso di dire, anche da parte nostra leggendoli) come una cimetta o un parabordi scordato, e invece si rivela invito innocente e impertinente ad aggrapparsi, ad afferrarsi per salire a bordo, e per imbarcarsi. Ecco, cade proprio per questo l’ammissibilità di una simile azione di editing: è evidente qual è la funzione di quel -e resta- che viene lasciato a sguainarsi per poter essere afferrato.
C’è un bambino disperso
nel mare di ognuno.
C’è in questa poesia un’idea di comunità che è comunanza di destino e di traguardo. L’individualismo apparente, predominante, nella persona della poeta che si presenta principalmente nel risuonare della propria voce, è in realtà una sorta di chiave malandrina che sta lì, abbandonata sull’angolo del tavolo, ad aspettare che questa novella Alice riesca a trovare il modo di afferrarla e maneggiarla con efficacia, e a condurci tutti nel Paese delle Meraviglie.
Se solo fossi
un poco più alta di me,
potrei stare
spalla a spalla con il filo d’erba
o fronte a fronte
con la margherita nel campo.
_________________________
Con le dita
del bambino sul disegno,
io sfumo i miei bordi
e dichiaro
insofferenza ai confini.
Solo una breve sosta per attirare la vostra attenzione su questa questione del disegno, dei labili segni di matita, e dello sfumarsi dei contorni – cioè della instabilità dell’essere, e soprattutto sulla presenza del bambino, sull’infanzia immanente che tutta la raccolta a più riprese enuncia, e lascia circolare sotto traccia fornendoci la traccia acustica di una identità matura, adulta, in cui continua in sottofondo ad agire la voce bambina. Qui si apre un filone aureo per chi legge: una voce duale che rende conto della infanzia mai tacitata (nulla a che fare col fanciullino, dunque), e l’elemento più potente a mio parere in questa poesia, la tecnica del rovesciamento, l’azione di costante capovolgimento del senso comune, che questa poesia pur con calma apparente persegue.
Carichiamo
i nostri abissi sulle spalle
e prestiamo i piedi
a un fondale che vuole
incamminarsi nel mondo.
___________________
“Dovreste imparare
l’umiltà degli angoli
che si defilano dal centro
per farlo esistere”,
così mi suggerisce la stanza.
___________________
Ognuno di noi sa
con quale passo falso
si è reso vero.
___________________
Chissà
chi davvero non siamo
tra tutti coloro
che fingiamo di essere.
Ci attende in effetti tutto un altro, ben più potente capovolgimento, ma diamo tempo al tempo.
Nel suo recente I passi di mia madre, Elena Mearini ha edificato un intero romanzo attorno al tema dell’infanzia irrisolta fin quando un certo mistero materno, indagato con lena di figlia, non sia stato compreso, e la vulnerabilità infantile che persiste, e non sempre solo in forma latente, venga pacificata. Lì, la protagonista è un’editor, e proprio il lavoro sulla lingua nella scrittura è lì parte integrante del lavoro esistenziale.
Stanotte c’è un padre
nelle cose lontane
e una madre
in quelle perdute.
____________________
Più volte colpevole
di non essere adulta,
io compio più volte
la parola bambina.
Che nessuno mi assolva,
grazie.
Eccolo, il residuo di infanzia che è inguaribile, che non può essere smacchiato neppure in lavatrice, nemmeno con i detergenti più aggressivi. Non c’è azione correttiva che regga, che si riveli efficace.
Per fortuna.
E poi
qualcuno tra noi
sarà residuo che resiste
all’ultimo lavaggio.
_______________________
Vivendo
lascerò che il corpo completi
i punti sospesi
dopo le parole.
_________________________________
Mi prendo cura
dell’ultima me che resta
affinché non si allontani.
In questa raccolta che consiste in brevi, a volte brevissimi, componimenti, dotati del giro intelligente e rovesciante di senso degli haiku, e tipici per formulazione aforistica, non solo la lingua è asciutta, direi secca, ma si fa presto chiaro che essa tiene a bada il silenzio, e con esso lo spavento cui mettere paura.
Ci sono silenzi
che non oso ascoltare
e allora parlo
per fare spavento
alla paura.
__________________
In questa notte basta
il poco di una stella
che guarda il mio cane
per vivere ogni paura
senza spavento.
__________________
Con la sua torcia accesa,
il silenzio
s’aggira cercando
la parola scomparsa.
___________________
Ognuno si porta dentro
il crollo muto del vento
che quando cade tace
e nessuno lo sente.
___________________
Stasera per le strade
oltre a me e il mio cane
il silenzio è terzo passante.
Sentiamo persino
il lampione che respira.
___________________
È stanca la parola,
tace.
Solo il suo fantasma
adesso dice.
Non si tratta solo di evocare inquietanti convitati di pietra che ci respirano accanto, di agitare fantasmi, ma di fiutare l’aria e rivestire di parole il senso ambiguo dell’esistere, dunque dare voce alla condizione umana.
Abbiamo un niente da nominare
con tutte le parole che ci capitano
tra le labbra e il destino.
Dunque assumono rilevanza: il duello tra parola e silenzio, tutto giocato sul filo della parola essenziale e del silenzio che come un blob tende a dilagare e soverchiare, e il rapporto col tempo che è il campo di gioco su cui il duello, partita senza esclusione di colpi, si disputa:
Vorrei imparare
dalla nuvola
che viaggia dentro il cielo
a spostarmi libera
nella reclusione del tempo.
________________________
Vorrei essere la voce piccola
delle cose minori,
per dire ciò che a nessuno
importa ascoltare.
Ma la sorpresa in assoluto più succosa del libro, in attesa della rivelazione da capovolgimento che (portate ancora un po’ di pazienza) ci attende, è questa:
Forse sbagliamo
la specie del fiore,
quando di assenza in assenza
ci posiamo a suggere
ciò che manca.
Si affaccia the bumble-bee, il calabrone di Emily Dickinson, insetto intento a sondare i succhi dei fiori col suo ronzio di sottofondo che ci richiama di continuo il senso naturale della vita e che la poetessa di Amherst spiava dalle proprie finestre del primo piano quando guardava il giardino, unico mondo di fuori che le fosse appena tollerabile. Bene, qui il calabrone siamo noi, siamo noi le api, le vespe, insetti infaticabili che nessun evento esterno distoglie dal mistero del vivere. Siamo noi gli insetti e i simboli. Sempre noi le parole e i versi, i gesti e il tempo, il silenzio e le formule fulminanti. E in ognuno di noi c’è tutto di noi, dall’esordio nel mondo al momento in cui ci troviamo, anzi meglio, dal presente che ci pressa all’infanzia mai perduta, mai esaurita, in cui ci andiamo a rifugiare, e al nostro stato neonatale:
Alla fine di ogni
nostro volto,
ci ritroveremo nella faccia
con cui siamo nati.
Irresistibilmente, e piuttosto imprevedibilmente, mi viene qui un pensiero: lo condivido con voi qui.
Descriviamo nel tempo il nostro personale cerchio che è una descrizione appunto di tempo, intera, circolare, e quando si compie torniamo all’origine, riandiamo indietro, come (univocamente, per la verità, rovesciando la freccia del tempo) fa Benjamin Button nel noto racconto di Fitzgerald del 1922 poi pubblicato nella raccolta L’età del jazz.
Il dopo di una fine
ci resta alle spalle
e continua a scrivere punti
sulla pagina della nostra schiena.
Quest’idea enigmistica della nostra ricerca di senso nelle nostre esistenze e dell’esistenza trova posto in molti momenti della raccolta. Non solo unire i punti per individuare i nostri tracciati: muoversi anche nello spettro su cui intercettiamo il mondo come in una sfida di parole crociate senza schema. Però qui di nuovo è intervenuta una suggestione irresistibile: ho ripensato alla schiena della geisha usata come pagina, come foglio di scrittura, in I racconti del cuscino di Peter Greenaway. La forza delle immagini.
E perveniamo al finale atteso e preparato, tutto giocato sul rovesciamento e sul capovolgimento.
E poi arriva
il ricordo di quello che è stato
a deformare quello che è.
Subiamo tutti
l’insofferenza geometrica
del passato.
Questa raccolta di brevi componimenti di Elena Mearini, Aritmia, che parla al cuore senza disarmonia, al contrario: nella sua secchezza di formulazione, dicevo aforistica, fa salva (come abbiamo visto) tutta la geometria possibile di un’armonia precaria, senza troppo darlo a vedere ha anche una sua struttura in sezioni. Le sezioni sono annunciate, oltre che da un intervallo nell’impaginazione, dalla presenza di aforismi ulteriori, extra-opus, evidenziate dal corsivo,
Per carenza di vivi
ci rivolgiamo ai fantasmi
è il primo in assoluto, ed è programmatico, credo.
Avevo già letto, di Elena Mearini, due opere narrative, ma proprio grazie a questo sua recente uscita poetica scopro, ecco il vero rovesciamento, e ve lo trasmetto con piacere, che Elena Mearini ha molto più a che fare con la poesia che con la narrativa, o perlomeno tiene le briglie di entrambi i cavalli con mani salde. È anche fondatrice della Piccola Accademia di Poesia, a Milano, città che spesso affiora in questa raccolta con un suo carattere e una sua dignità personale, dunque non è solo uno sfondo. Perciò stavolta non tanto un’autrice di narrativa che trova anche una propria voce poetica, ma voce poetica paritetica alla voce in prosa. Ecco, era questo il capovolgimento. Non una narratrice prestata alla poesia ma la poesia per prima o perlomeno accanto, proprio a fianco, passo passo, con la prosa narrativa.
Occorre un esilio privato
per accedere alla libertà.
Nessuno vuole essere ultimo
così resta vuota
la pagina conclusiva della storia.

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
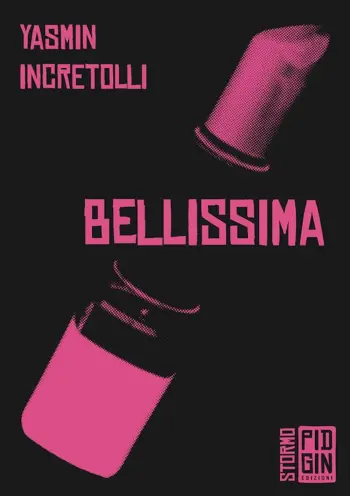
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare