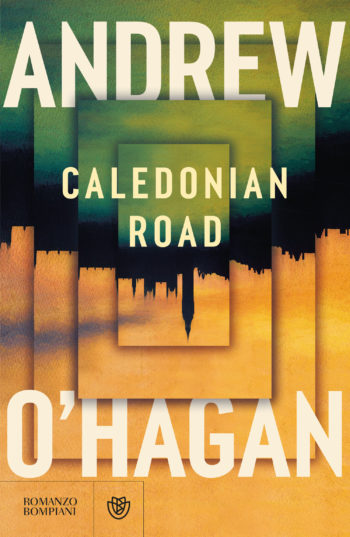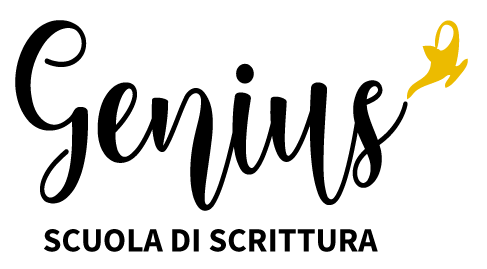Ripesco per questa puntata due poeti, Paolo Del Colle e Renzo Paris, su cui già abbiamo ragionato perché sono recentissime le loro ultime uscite: IRENE, per Paolo Del Colle (Quaderni de La Nuova Pesa, aprile 2021, corredato da disegni di Giuseppe Salvatori), e MAGICO RESPIRO, per Renzo Paris (Stampa, Le Collane – a cura di Maurizio Cucchi, aprile 2021). Due raccolte molto diverse.
Irene di Paolo Del Colle è un piccolo libro molto denso che segue a Nuda proprietà (2018) con cui Del Colle è tornato a pubblicare poesia in volume dopo aver esordito nel 1988 con Gemme apicali, esito anche dell’esperienza nella rivista Braci, e dopo aver composto a quattro mani, con Edoardo Albinati, Mare o monti uscito nel 1997.
Magico respiro è il quarto volume di poesia per Renzo Paris, dopo Album di famiglia (1990), Il fumo bianco (2013) e Il mattino di domani (2017), e sembra quadrare un cerchio ideale nella sua produzione in versi.
Partiamo da Paolo Del Colle, da Irene, da una constatazione sconsolata e inconsolabile nozione:
nulla si apprende dal dolore
piuttosto si dimentica
ciò che siamo
o meglio ancora
quello che vorremmo essere
da un qualsiasi adesso in poi
e per parlarne
occorre essere cattivi
o affidarsi a consulti
le dosi variabili
delle medicine e degli orari
numeri da segnare
perché sfuggono dalla mente
perché l’unica idea
è seguire il decorso
rispettare le indicazioni
che ti ripeto
perché le hai già scordate
***
non trovi un ulteriore senso
a questo misurare il tempo
che unisce un punto all’altro
tracciando l’unica retta possibile
come fosse passato appena
un giorno ripetibile all’infinito
nella tua testa che ora sembra piccola
deposta in una mano
e forse sogna parabole sbilenche
una via diversa dalle figure
che prendono le cose seguendo
il proprio corso per ripetere
ciò che apparirà di nuovo;
la data di una visita
quella di una mattina prevedibile
e il mio sdoppiarmi al lato destro
quando ti volti per essere sicura
che almeno io abbia capito
e forse in uno sono quello
che vorresti e fingo di essere
finché non parlo.
dobbiamo sbrigarci dico
sperando che la fretta
trovi presto altrove
dove bisognerebbe andare
seguendo la freccia dell’uscita,
mentre allora tutto è meglio
del previsto
di ogni volta che mi perdo
in questo parcheggio
Questo quaderno di versi è un congedo. Non dalla poesia. Non dal mondo. Ma dalla cara sorella, la figura eponima di questo pugno di versi quieti e disperati.
La raccolta si apre con una sorta di testo extra-testo, segnalato dal corsivo (così anche in fondo al libro: incipit ≠ exit): il poeta così ragiona sui nomi e su a cosa servano per chi li porta e chi li grida:
…anche i nomi hanno uno statuto
provvisorio
un grumo amorfo
di pigre circostanze
accumulate nel tempo
che si può asportare
e non ci voltiamo se qualcuno
ci riconosce o ci chiama
quando è il turno…
Il nome è associato alla persona fin quando si riempie di lei, del suo corpo, della sua figura. Portare un nome inorgoglisce, poi c’è un momento finale in cui si vorrebbe che proprio quel nome non fosse chiamato, che non si fosse convocati, e al nome si finge di non rispondere. Irene è “pace” in greco: un nome dunque che suggerisce quiete e concordia, collegato persino a “shanti”, l’invocazione di quiete e pace ripetuta tre volte in fondo a The Waste Land – forse un’eco di quel “-sospira” in cui esita il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare. Qui il poeta, carico di queste e altre suggestioni, tra cui certo il sonetto foscoliano per il fratello Giovanni, e calato in una sua necessità di coronare la “loda” in forma di elegia intonata con rassegnata e smarrita accettazione, invoca, come estremo lembo cui aggrapparsi pur di non lasciar andare, un processo di assimilazione che può esser stato estremo esito della fratellanza con Irene, ora scomparsa, specie nella coda finale della loro convivenza:
[…] dovrei guardarti ma so
che i volti si assomigliano
sempre di più come volevano
i nostri genitori o i nonni o chiunque
avesse notato
che ricordavamo qualcuno
non puoi lasciarmi adesso
che siamo uno nell’altra
senza voler più sapere perché
il mutare nascondesse
queste somiglianze
La delicatezza di questo lungo congedo è annunciata e accompagnata all’uscita dai disegni di Giuseppe Salvatori: due mani che accolgono una colomba caduta e una colomba pronta al volo con una penna sul capino (elemento quasi pascoliano).
Curioso che il libro di Renzo Paris, Magico respiro, per una liaison inattesa, si apra proprio così:
Come un animale in gabbia
percorro a passi svelti
il corridoio di casa. Raggiungo
lo studio, la cucina, il balcone,
rievocando la mia vita in quarantena.
Ritorno in corridoio trafelato, contando
i minuti dei miei attacchi di panico.
Questo mio ultimo libro al respiro
intitolato è fatto di passi perduti
attorno al mio palazzo, con il volto
nascosto al virus nemico
e i guanti a proteggere le mani. Solo
abbracci virtuali tra me e Marina
e un saluto con le dita mosse, distanziati.
Così il mondo da remoti si popola
di fantasmi. I miei versi sembrano geroglifici
scritti con la biro, su quaderni colorati.
Sono frammenti di un nuovo album.
In ascolto della voce antica, trascrivo
quello che detta dentro quel magico respiro.
Anche qui l’incipit è un testo extra-testo segnalato dal corsivo, un proemio programmatico in cui si rinviene un compendio degli elementi che connotano tipicamente anche questa raccolta di Renzo Paris in cui appare consolidata tutta la sua strumentazione: l’uso delle terzine in versi liberi e l’uso frequente dell’enjambement, la spezzatura che prolunga il completamento del senso nel verso dopo. Ma vi dicevo di una inattesa liaison, un legame tematico, una liana libera lanciata da un libro all’altro e da un poeta all’altro: l’animale e la gabbia, il panico e la corsa trafelata, i giri ossessivi là attorno al dolore come qui attorno al palazzo, e l’appoggio a una voce antica per ascoltare e trascrivere ciò che il magico respiro “ditta dentro”.
Il libro, diario in versi del periodo di clausura imposto dalla pandemia, è diviso in tre sezioni.
La prima e l’ultima raccontano il quotidiano da reclusi a SanLo, il quartiere San Lorenzo dove il poeta abita, la sezione centrale è invece ambientata a Celano, l’Abruzzo da cui il poeta proviene (migrato a Roma con la famiglia a soli tredici anni).
PIAZZA DEI SICULI
Attraverso la strada ed entro
in un altro mondo. Piazza
dei Siculi è rotonda e ha in fondo
un chiosco di giornali. Sulle quattro
panchine dormono gli africani
sotto coperte donate dalla vicina
Caritas, dove a mezzogiorno vanno a mangiare.
Alcuni sono più creativi e montano
con i cartoni veri e propri canili
dove c’è un fornellino e non manca
la moka per il caffè. Sono quasi sempre
nerboruti giovanotti di colore,
rare le ragazze e la mattina, quando
vado a comprare i giornali, li vedo
assonnati che fanno i loro bisogni
sotto i tigli, rigorosamente senza mascherina.
Ne ho conosciuti diversi. Mi è rimasto
in mente uno spilungone che da sciamano
lanciava al vento della piazza fogli con il mantra:
“Bonne chance à la lune!”. La sola ragazza
che ricordo aveva una veste nera
e inanellava le braccia con gli spaghetti rossi
dei cassonetti della piazza, felice
di rosicare costolette, alucce di pollo. Un nero
si coricò sul suo cartone e lei fuggì
verso Termini facendo perdere le sue
tracce. La ritrovarono dentro un vagone
in un binario morto. Aveva sgozzato
un pensionato che voleva approfittare di lei.
Disegnava ridendo un alfabeto misterioso.
PIÙ FORTE DELL’AMORE
Tornato dal Guatemala
dove pure infuriava il virus,
affacciato alla finestra Jean
vide suo fratello Tristan accarezzare
una ragazza. Erano sdraiati sul prato
del giardino, come fossero i vecchi tempi.
“O lui o io” disse Jean in gran dispetto
alla madre “se non trasloca a casa sua
questo pomeriggio stesso mi trovo
un albergo dove passare il lockdown.”
Così Tristan dovette rimanere in quarantena
per quindici giorni senza la sua Isotta,
con la madre che spediva ragazzi in bicicletta
a pranzo e a cena, chattando tutto il dì
con il figlio prigione. Jean intanto
litigava con la sua ragazza americana
che non aveva nessuna voglia di accoglierlo
in casa. Il virus era più forte dell’amore.
Le cronache di SanLo, che hanno sempre contraddistinto una grande parte della produzione in versi di Renzo Paris, non solo svelano che la crisi al tempo del virus (tutto condensato già nel titolo, che è anche un verso interno al testo qui sopra, PIÙ FORTE DELL’AMORE, di impianto pasoliniano) può essere ridotta a una mesta cronaca domestica, ma quella cronaca si allarga a due motivi letterari profondi di facile riconoscimento a un occhio attento: il canto dell’aube o aubade (la separazione coatta all’alba, un classico della letteratura medievale) ha un nuovo motivo o movente, la quarantena per il virus; i personaggi di questa cronaca, Jean e Tristan, fratelli, la madre, tenera autorità del potere familiare, e la Isotta del caso di specie, una fidanzata americana, alludono sì a un impianto poematico antico, ma rievocano anche certe dinamiche alla Maupassant che abbiamo ben vive nella memoria letteraria. E poi, qui come in PIAZZA DEI SICULI, assistiamo a una composizione di quadri semplice, annotativa, ma la levità del dettato non inganni sulla gravità delle vicende, dei gesti e dei personaggi. Dunque una poesia, questa, anche come documento. Ci sono nella prima sezione molti altri componimenti di grande rilevanza poetica: penso a LA DOLCEZZA DEL NAUFRAGIO, dove troviamo il “metodo mitico” del XXI secolo targato Paris; oppure al componimento ANIR di cui riporto solo la chiusa:
[…]
sono tra i pochi che sanno che è vissuta
saltellando allegra nei sotterranei di Termini,
gelosa dei suoi numerosi elemosinieri.
Viene da esclamare: “questi fantasmi!”. Li abbiamo tutti attorno a noi e non li vediamo, non facciamo loro caso fin quando non decidiamo di spalancare i cuori prima dei nostri occhi e orecchie, e allora va in scena solo per noi il loro film che si conclude spesso non con un lieto fine, cui noi aggiungiamo perlomeno un finale, la carità di un nostro pensiero solidale.
Penso anche a SONO UN DOLLARO CHE CAMMINA, dove il quartiere è come certe cittadine africane e gli immigrati di oggi hanno preso il posto degli immigrati degli anni Cinquanta, tra cui anche il poeta e la sua famiglia abruzzese. In sé e in quelli come lui, come nei migranti d’oggi, il poeta si chiede se sia riconoscibile il “popolo / cantato dai poeti che amo”. Questa la chiusa:
[…]
Cammino, lento pede, nella mia città
come fossi il migrante di me stesso.
Nella terza sezione del libro, che segna il ritorno del poeta a SanLo dopo la felice parentesi marsicana su cui ci intratterremo alla fine, troviamo echi e corrispondenze con la prima, in adesione come da sempre a una idea di poesia ereditata dai grandi francesi, tra cui naturalmente Charles Baudelaire, anche se Renzo Paris ha sempre amato indentificarsi nell’amato Apollinaire.
IL CIGNO NERO
Il cigno nero vola sul globo e scende
a picco sulle nazioni più indebitate.
Poi riprende a volare alto
per precipitare di nuovo.
Al cigno non interessano
i poveri, non ha pietà
per la pandemia, specula
sui debiti di stato
portandolo alla catastrofe.
Sta arrivando anche da noi;
se ne parla sui giornali.
Qui siamo portati a un naturale ragionamento su questo uccello che trasvola e cala a picco senza pietà: automaticamente viene da pensare all’albatros, in cui Baudelaire identificava la figura del poeta, uccello del buon augurio che accompagna per tradizione la buona navigazione, evocato in questa funzione già da Coleridge nella Ballata del Vecchio Marinaio: il marinaio navigato del titolo innesca un maleficio uccidendo l’albatro, come il mondo civile tende a ostracizzare il poeta o anche a ucciderlo – in quei due casi non è l’uccello il portatore di sciagure ma è l’azione umana, l’improvvido delitto, a mutare la buona sorte in maledizione. Qui siamo al cigno nero del čajkovskijano Lago dei Cigni, siamo non solo al sortilegio e alla dannazione, ma al sospetto di una malefica mistificazione che si abbatte senza pietà su un mondo apparentemente innocente, o inerme, forse non abbastanza attrezzato.
SIAMO AFRICANI SBIANCATI
Entrando in Europa i giovani
africani d’antan si slavarono
a poco a poco, diventando
a tutti gli effetti bianchi. Abbiate
pazienza ancora qualche decennio e i neri
di oggi diventeranno come voi
che li disprezzate così tanto da
accoltellarne diversi, di tanto in tanto.
Ecco un buon argomento per rintuzzare il revanchismo leghista in una produzione poetica in cui a un certo punto salta fuori persino il nome di Salvini.
ALLA GIORNATA
Mi ritrovo a vivere alla giornata
senza fare di essa una metafora.
Qui e ora, mentre fuori piove
e io mi chiedo: quanto vivrò ancora?
E i miei figli* lavoreranno stabilmente,
prima o poi? E Marina riuscirà a guarire
(*Ale e Giò cui è dedicato un componimento bellissimo, ndr)
di tutte le ferite che le ho inferto?
Tutto il mio passato è stato macinato
e solo pula ne ho ricavato. Questo
Natale non ci sarà né il bue né l’asinello
né la mangiatoia se anche i pastori
si sono ammalati. Staremo a vedere
se la stelluccia appare anche quest0’anno.
È buio il presente, gente*, è buio pesto.
(*generalmente è vezzo del poeta rivolgersi a tutti noi non con “gente” ma
con “drughi”, omaggio all’Anthony Burgess di Arancia Meccanica, ndr).
FIGLIO DELLA MEZZANOTTE
La mattina mi alzo sempre più
Presto. Mi piace vedere l’aurora
e ogni volta è come fosse il primo
mattino del mondo. Il mio cervello
è fresco, attivo e lavora fino
a mezzogiorno.
Vado a dormire sul presto.
Se a mezzanotte mi sveglio
non mi riaddormento facilmente.
Sono figlio della mezzanotte e
quelle
sono le mie prime ore di vita.
Mi pare evidente che qui la notazione più centrata che si possa fare non è legata al riuso di un famoso titolo di Salman Rushdie, ma all’elemento fortemente personale che via via nel corso della lettura del libro diventa non solo sempre più forte, ma da un lato sembra suggerire il noto detto, to make ends meet, in senso letterale, il toccarsi degli estremi nella vita di una persona, nascita e morte che sembrano gareggiare in attesa di lambirsi, e dall’altro si cumula la sensazione del senso di un destino che incombe, di una corsa verso il traguardo, non solo non dissimulata ma ingaggiata con allegria o forse con non inconsapevole ineludibilità.
LA BRANDINA
Soffiano venti di covid nella costiera
pescarese. Anche all’Aquila, a dieci chilometri
dal mio piccolo Tibet, c’è un infettato.
Cammino in lungo e in largo dentro le ampie
stanze, abbandonando la passeggiata
pomeridiana nei boschi. L’altro giorno
alla fontana del lavatoio, a una a due a tre,
sono comparse le pecore assetate, con
il cane pastore che mi ha guardato severo.
Ultime le caprette nere che hanno
spaventato i pappagalli. La fontana è
al centro dell’ara dove anticamente
si consumavano sacrifici umani e
ancor prima i dinosauri venivano lentamente
ad abbeverarsi. Al museo del Castello
aquilano ce n’è uno tutto ossa in mezzo
alla sala, alto fino al soffitto.
Non abbiamo un bunker dove seppellirlo.
Sogniamo una brandina nei deserti della Luna.
Eccoli i motivi, anzi i moventi alla composizione, abruzzesi: le origini, le radici, cui il poeta è tornato in un breve intervallo nella chiusura totale, per ritrovare il suo “piccolo Tibet” (Celano, l’Aquila, la Marsica), evocando poi il luogo che nella sezione centrale, abruzzese, ricorre, la valle dei dinosauri.
I PASTORI
“Il latte è il nostro sangue e se lo abbiamo
versato sull’asfalto non è per farvi fare
una bella foto!” gridava un pastore
sardo davanti ai faretti eccitati
delle televisioni di mezzo mondo.
Tutto il sangue rimasto dei millenni
agro-pastorali gocciolava sull’asfalto
imbiancato, insieme alle lacrime di San
Panfilo d’Ocre, il patrono dei pastori.
Dunque il motivo dannunziano dei pastori d’Abruzzo e della transumanza diventa qui un legame millenario tra tutti i pastori del mondo agro-pastorale che sembra rimandare a un passato scomparso ma a fare da legante fra i pastori millenari di tutta la Terra salta fuori il loro patrono, abruzzese, San Panfilo d’Ocre, che dà anche il nome a una frazione di Ocre (AQ) piccolo borgo di un triangolo, con San Felice e San Martino, zona di monasteri e di pochissimi residenti. Anche qui qualcosa incombe. Quel latte versato, come sangue disperso, allude alle proteste degli allevatori e dei pastori contro la politica cieca dell’UE (le quote del latte) costituita da burocrati che “è come se parlassero – leggiamo in SONO UN DOLLARO CHE CAMMINA – di un algoritmo”, e non di vite spezzate. E poi non può non incombere il terremoto: terremoti nel tempo, tra cui l’ultimo, terribile, occorso nel 2009, evocato in L’AQUILA, in cui il poeta denuncia anche le inadempienze e le contraddizioni che tengono fuori gli aquilani dalla loro città e impediscono loro pure di provvedere con sostanze proprie almeno a una ricostruzione privata.
Chiudo con un ampio stralcio dall’ultimo componimento della raccolta:
I MIEI VERSI
Carico d’anni e dell’altrui piacersi
nel mio rocchetto elettrico
ancora sfrigola l’eros
di tutte le donne che ho amato.
Non sono chi fui e nemmeno chi
sono stato ieri, vaso di opinioni
altrui, senza averne una.
Cammino, lento pede,
sui marciapiedi di Roma, appartandomi
agli angoli per incontrare me stesso.
[…]
L’amore
dici, il vero amore, è confortarsi nel pericolo.
Non ho futuro, ti rispondo, ho rincorso la vita
immaginandola, strologando con i miei
ultimi scongiuri come uno sfigurato
sciamano di città.
Tiriamo dunque le fila, ora.
A giustificazione dell’aver messo insieme due poeti tanto diversi, provenienti da esperienze molto diverse e anche di generazioni diverse, ho ritenuto di poterli accostare non solo per offrire a voi un aggiornamento della loro opera documentando i loro testi più recenti: mi pare di poter dire che si coglie, anche, seppure da moventi diversi, una comune poetica del congedo e di pacata e rassegnata accettazione di un destino più vasto in cui le singole esperienze individuali, ancorché rilevanti in sé, riescono ad esserlo proprio per l’opportunità, allo sguardo profondo della poesia, di sentirsi dentro un’avventura più grande che è la vita umana e comune.
E mentre Paolo Del Colle esplora qui una fratellanza anagrafica, resa più acuta, in questa plaquette molto personale, dalla perdita della simbiotica sorella Irene (perderla, se restiamo al significato del nome, è anche perdita della pace, della quiete, e inevitabile panico), Renzo Paris esplora questo tema in rapporto alle nuove relazioni dettate dalla pandemia, o meglio alla profonda e forse irredimibile modificazione di ogni relazione, che insieme al resto gli desta panico, e appiglio forsennato alle radici e a quel piccolo paradiso che è la propria terra.
Entrambi adottano il passo cauto dell’andamento lento, quel lento pede, che suggerisce di accostarsi a tutto ciò che segue, dopo gli eventi particolari che hanno segnato ognuno, e tutti noi, dopotutto, con lentezza, adeguandosi passo passo a ciò che avviene e avverrà.