Nessun prodotto nel carrello.

Dentro la lampada
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

ERA QUELLO CHE MI DICEVA IL LAGO
cioè di non piangere, piuttosto
di ascoltare il pigolìo dei merli
appena nati, trovati morti dopo un giorno
di neve fiacca e gelo. Viene così
a nudo la cosa che sapevi
tossisci, non sai che dire.
***
cioè di non urlare e entrare
dentro, di premere la mano
con forza contro il muro e – vedi?
non c’è niente di male a farsi forza
con le canzonette
ce n’è una che faceva
ta ta ta
***
l’aureola mancante della santità
a volo d’aria si raccoglie e vede
coriandoli gettare il panico tra i fiori
un inganno in piena regola
una vera crudeltà
[da La gravità terrestre, Elio Tavilla (Musicaos 2020)]
Giorni fa mi è capitato di ascoltare Andrea Bajani, autore di Il libro delle Case (romanzo Feltrinelli in gara per il Premio Strega di quest’anno, ma autore anche di ben due libri di poesia, pubblicati con Einaudi nella Collana Bianca, scritti nell’intervallo tra il precedente romanzo e questo). Mi ha fatto piacere sentirgli dire qualcosa che anche noi qui condividiamo da tempo: l’idea che a sorreggere la poesia sia proprio lo spazio bianco, a tenerla, anzi a metterla in piedi, sia il silenzio circostante da cui come per miracolo emerge in un pugno di versi, che magari qualche volta possono pure essere versacci (per tralasciare i ragli), ma, andando all’essenziale (ciò che conta nel processo elaborativo che porta ad aggregare dei versi), il gesto del poeta è simile alla tenacia dello scultore. Come questi stana ed enuclea la figura intrappolata nella materia, così il poeta inalbera dal silenzio bianco che la circonda una scrittura evocativa strappata al mutismo attonito che sempre ci accompagna. E proprio Andrea Bajani, in Dimora Naturale, conferma anche un’altra ipotesi che culliamo come assunto che nulla possa sconfessare, e cioè che la poesia è lo spazio del pensiero profondo, un humus spirituale che poi può riversarsi nei romanzi, può accendere situazioni narrative e sfondare spazi di luogo e di tempo, restandosene al di qua: sta di fatto che essa, di tutta la materia narrativa che torrenzialmente da essa poi si dipana, è il termine a quo.
Bene! Direte, allora questa puntata è dedicata alla poesia di Andrea Bajani. Neanche per idea.
Di lui non mancherò di occuparmi come già pregusto da tempo, ma oggi è la volta di Elio Tavilla. Poeta messinese di stanza a Modena dove è docente di Storia del Diritto. Questo dettaglio indica la prossimità della sua opera poetica con l’area modenese/bolognese in cui si muovono come lui Alberto Bertoni e Paolo Valesio (autore, non a caso, di Ascoltare il silenzio), Rosita Copioli ed Emilio Rentocchini – cui direi di associare Giampiero Neri (brianzolo di Erba di stanza a Milano, poeta sotto pseudonimo, nato Pontiggia, fratello del noto romanziere Giuseppe).
Elio Tavilla ha intrapreso la sua strada poetica a cominciare dal Premio Montale per l’Inedito 1983, cui è seguita la pubblicazione della prima raccolta, Il cubo e l’assenza, con Società di Poesia nel 1984. E poi altri libri (e altri premi: Dario Bellezza, 2000; Sandro Penna, 2005), fino a La gravità terrestre, Musicaos 2020, ultima raccolta in ordine di tempo di cui ragioniamo insieme qui.
Partiamo da una osservazione sui versi sopra riportati che spero non sembri peregrina: la sezione cui i versi si riferiscono ha un titolo che è un interruttore: ERA QUELLO CHE MI DICEVA IL LAGO, suonano in risposta a una sollecitazione, a una provocazione, a una richiesta formulata come affermazione imperiosa, diversamente da quando sul social di Zuckerberg rispondiamo alla domanda, A cosa stai pensando?, e il post prodotto appare vagamente campato in aria perché la domanda è omessa.
Qui viceversa, benché per simile meccanismo, il poemetto, frazionato in cinque sezioni, elabora proprio la reazione a quel tarlo. E struttura cinque piccole rivelazioni, o un’unica verità, scomoda, da esaminare in cinque sue variazioni. Colpisce la lieve indicazione dell’effetto mistificatorio che deriva dalla nostra cauta accettazione della verità, il nostro approccio ad essa prudente, che TSEliot avrebbe definito “politic and cautious”. Qui però non è un caso da Prufrock o Sweeney, Tavilla non suggerisce una miserabilità – “l’aureola mancante della santità” è solo l’ammissione di un’imperfezione, e di una inermità, di un’innocenza di fatto, per scarsità di forze, il cui “inganno in piena regola” esita in “una vera crudeltà”. E poi si può solo “colare a picco” col proprio “carico di carne”. Che questo disarmo insito nella nostra caduca natura sia all’origine di un atteggiamento così indifeso è segnalato pure da parole-spia disseminate nei versi: una di queste è acquerugiola, così tenera e corrosiva insieme.
e poi colava a picco
col suo carico di carne non
riusciva neanche a dire basta
le era uscita tanto flebile di bocca
che neppure la sapeva
più a memoria
***
poi la serenata suona
non era che acquerugiola a
disperdere il calore,
dei polsi, delle mani
Prevengo la perplessità di chi leggendo questa poesia noti, nei versi sopra, la inaspettata cesura dopo “parole interiettive” come la negazione “non” o la preposizione “a”, e ora si sta arrovellando: ma come è possibile? Lo preciso perché è una domanda che una volta mi è stata rivolta. Non si tratta solo della assoluta libertà, nel verso libero, da parte del poeta, di “manovrare versificando” a proprio piacimen= to, si tratta nel caso di specie, come sempre accade, di forme ardite di enjambement e di audacia sospensiva. E anche di una sorta di esitazione, di tremendo bilico in precario equilibrio che sempre segna la parola poetica – che, conviene qui ripeterlo, esce allo scoperto dal buio del silenzio per ridefinire il senso e il segno della nostra avventura umana, dunque richiede tremante coraggio. In questa chiave mi pare si possano interpretare anche i cosiddetti indentings o rientri, frequenti in questa raccolta come formulazione grafica, ulteriore risorsa espressiva di una cautela che sospende il giudizio, non lo infligge come sentenza, ma lo suggerisce come dubbio, cullando il caso di studio.
L’idea della mistificazione che ci insidia, e che sta in agguato incombendo su tutti noi indifesi, mi sembra il reperto più temerario e impertinente, appunto, di questa raccolta. E posso fornirne due prove almeno, restando sul testo.
Intanto (visto anche che stiamo attorno ai giorni di definizione della cinquina che approda al Premio Strega, e che la cernita si è svolta proprio, tornandoci, nella città di Benevento –Maleventum, in ori= gine– nella conca petrosa del suo teatro romano), partirei dalla sezione di La gravità terrestre che si chiama proprio LE STREGHE DI BENEVENTO:
1
A furia di temere il peggio, avevano l’aspetto
degli ossimori mancati. Del tipo: aurora, ora
lucertola, carogna – una T larga sul petto
che si vedeva da lontano anche
con le luci accese. E dire che temevano
di morire presto.
2
L’angelo custode
nel retro del negozio
aveva un dito rotto ed era afono. Per forza
con quella aura da profeta non smetteva
di avere il torcicollo e urlare. Un’algida
apparenza da dimostrare. Fece
un altro giro gratis e seppe
che eran due e che si davano
le spalle.
3
Non si parlavano. Neppure
per vederci meglio. Un giorno sì
e uno no. Comunque.
Meglio che nulla. Meglio
nulla.
A motore spento
a folle.
4
E per quanto esanime
sembrava avere sette vite. Come
si comportava. Si muoveva. Un polso
sopra l’altro. Ne ricordo uno
che batteva al ritmo della madre chiesa
quando i fedeli entravano
o uscivano, non so.
È evidente che c’è un trucco (direbbero i francesi), cioè un meccanismo perverso, insidioso – torno a dire, nella trasmissione, o interviene qualche capricciosa interferenza, che disturba, traducendo in altro, ciò che è emesso in origine, per cui il messaggio che arriva, o si osserva nel suo viaggio sonoro o in video, finisce per trasformarsi, capovolgersi, rovesciarsi, finisce per mentire: ci arriva questo. Non sappiamo più qual era il contenuto genuino di questo macchinoso lavorìo di propagazione. Come se tutto ciò che diciamo e facciamo, nel corso del tragitto verso terzi, si alterasse naturalmente e sconfessasse sé stesso. Per danno soverchio si aggiunge la comicità involontaria: ridicolo contrario.
5
Sì
era meglio di quello che si dice
un’evidenza fattuale
ma aveva il viso segnato
e una carota per naso.
Poi c’è una prova testuale ulteriore, difatti finale nella geografia del testo, nella sezione eponima La gravità terrestre:
preme sulle costole nell’aria limpida
di ottobre, prima di immergersi con muta
apprensione, divaricando gambe e
braccia al carico bilanciato del corpo
opponendo fiato, la schiuma che è un vapore
di quelli trasformati in vera acqua
e nel sale trascende il suo furore
un unico intrico di alghe e carni
molli di paguri impauriti, quasi feroce
l’esibizione inutile degli arti prima
di finire decorticato attorno
al suo centro.
Era impossibile resistere
alla sua forza, agitare le mani era
la rivolta dei poveri che nient’altro fanno
se non desiderare tanti piccoli mali
per nessuno in particolare ma al primo
che passa e disarticola le sillabe
che sapeva dalla nascita di dove non
sapeva, ricordava. Era impossibile comunque
riconoscere dal taglio della bocca e quello
sanguinante altrove dietro gli occhi, nei sessi
il grigio-fuoco delle schiene illuminate quando
vengono vergate a sangue. Esce
come un ospite in un giorno di un qualunque
mese e in un’orbita spaziale e temporale
estrema dice cose quali gratitudine e promessa
inutilità del vecchio mondo che sparisce come
era apparso, senza gloria e senza infamia.
No.
L’infamia, quella sì.
Quella torna
ripetutamente torna
a confondere e mischiare l’acqua
con il vino, una falsa eucaristia
che toglie vita e nulla in cambio dà.
E certo, l’ingenuità era perduta
e con essa il fiore
dei migliori anni.
Ora l’ora del crepuscolo affanna
appena, nulla si scorge oltre la fiancata
del relitto, una scialba mattina di luce
retta, inequivoca, fissa sui resti
sulle rovine. Schiacciate dai vandali
le retrovie sono piccoli popoli erranti
divisi, prossimi allo sterminio e questo solo
per testimoniare l’abitudine al dolore
l’oro dei meticci che affondano nel fango
e lì restano per sempre e nel silenzio
di ogni storia. Il tubero
di un futuro fiore
affiora dalla terra smossa come
da un gioiello d’inarrivabile valore
e non stupisce che si addentri
con radici più voraci da animale
inerme, cosa che si spiega come
un’aporia iridescente nel sereno
ragionare di un Socrate, di un quasi
irriconoscibile Spinoza.
Ciclo circolare
dei pianeti inquieti, spinti da chissà
quale nera forza che nessuno sa
e dispera di sapere, un attrezzo inutile
l’acciaio delle macchine volanti attorno
al globo, la piccola sparuta inerte e comica
pallina colorata in fiamme e fumo – un padre
nostro che si informa delle sue creature
consumandole, pestandole, ascoltandone
i flebili lamenti a fiotti nelle notti
senza luna.
Solo un rapido passaggio
di stormi volatili impauriti assaliti
dalla fretta di migrare, un lampo oltre la fitta
dedalica vegetazione
e poi uno sparo
e poi ancora un altro. E poi più nulla.
È letteralmente fenomenale come questo poemetto finale sia anche conclusivo di una sorta di arco del ragionamento, se così si può definirlo, e come dopotutto qui il poeta “spinga”, per citare il solito TSEliot (ma tant’è, gli dobbiamo molto, in termini squisitamente poetici, e in termini critici), “il momento alla sua crisi”. Qui tutto decanta in peso, in pesantezza. C’è una forza che grava e pressa, a cui non è dato avere forze sufficienti per opporre apprezzabile resistenza. Ed è significativo come il poeta ragioni sulle parole, sul senso comune che in esse è distillato e diventa verbo ipocrita. Fino a stanare l’infamia.
L’infamia, quella sì.
Quella torna
ripetutamente torna
a confondere e mischiare l’acqua
con il vino, una falsa eucaristia
che toglie vita e nulla in cambio dà.
E certo, l’ingenuità era perduta
e con essa il fiore
dei migliori anni.
È chiaro che stare sotto il torchio della confusione e della mistificazione (che, attenzione, non è più difetto fisiologico ma crimine con una matrice) non solo trasforma, corrompe forse, smalizia di certo, ma scarnifica anche, porta via polpa, letteralmente spolpa l’anima. In uno scenario che ha dell’infer= no dantesco e dello sciamare disperato, e in una specie di eterno purgatorio che è la vita umana, che ha della desolazione terrestre eliotiana, come per un maleficio spunta
Il tubero
di un futuro fiore
affiora dalla terra smossa come
da un gioiello d’inarrivabile valore
e non stupisce che si addentri
con radici più voraci da animale
inerme, cosa che si spiega come
un’aporia iridescente nel sereno
ragionare di un Socrate, di un quasi
irriconoscibile Spinoza.
Ciclo circolare…
-è incredibile, questo passaggio, pazzesco. È di una lucidità spietata: cogliere in modo disilluso – e finale, verrebbe da dire – come la tragedia annidata nel piccolo nascosto e misero sia la stessa che su un piano più elevato, che sia il pensiero, o il moto armonico delle sfere celesti, non solo addita la nostra “animale inerm”ità, ma dimostra la natura aporetica del ragionare, persino delle speculazioni storicizzate e solidamente radicate nella nostra cultura. Questo nostro spregevole rimestare–
stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.
–già ci era stato rivelato in The Burial of the Dead (La sepoltura dei morti) in The Waste Land (La terra desolata, tradotta da Roberto Sanesi – che in una nuova traduzione, di Carmen Gallo, per Il Saggiatore, uscita il 13 maggio scorso, diventa La terra devastata). E a nulla serve che siano lanciate in orbita attorno al globo macchine d’acciaio volanti – il mistero non si risolve. È inintelleggibile, non è interpretabile o rivelabile nella materia e nei fatti minuti o negli oggetti, che sono solo pesi singoli, solitarie zavorre che ci aggravano. Elio Tavilla sembra suggerirci qui (giusto lui che è uomo di legge, immerso nei codici e in una normazione curiale di ogni umana materia, attenendosi stavolta invece ai suggerimenti di un poeta della Fisica, Albert Einstein) che quel mistero può essere scorto nel valzer dei legami che intercorrono tra le parti in gioco, e come per incanto sorreggono e alimentano proprio il movimento, appunto in una celeste armonia, in un sistema composito di cerchi e orbite – o, per dirla con le parole della Legge, finalmente restituite al ruolo di portatrici di decisivi significati, e di civile sistemazione, “nelle more” tra gli atti tangibili.
La gravità terrestre è un libro da leggere a cuore aperto. Si impara, anzi, leggendolo, a disfarsi del senso comune e anche dell’ormai liso e consunto buonsenso, e a conquistare un senso diverso, più franco in una specie di apprendistato che è naturale e radicale come la meditazione o una seduta di yoga. A proposito, leggiamo anche Yoga, di Emmanuel Carrère – uscito lo scorso anno in Francia per P.O.L. (suo nuovo editore), e ora disponibile in italiano nella traduzione per Adelphi di Lorenza Di Lella e Francesca Scala.

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
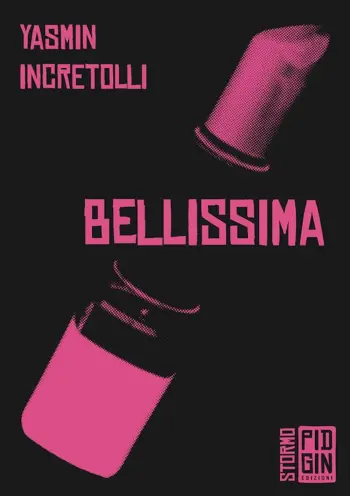
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare