
Agatha Christie e il “Treno azzurro”
“Disgrafia, aveva sentenziato l’ultimo dei medici consultati da quando erano apparsi i primi sintomi”.

Nel campo della scrittura è difficile che si perda qualcosa, i ricordi e le persone con i loro testi lasciano riverberi che si prolungano per anni, così quando ho visto che era uscito un romanzo di Rosa Maria Di Natale, conosciuta in un laboratorio che conducevo qualche tempo fa, ho avuto subito voglia di leggerlo. E ho fatto bene. Non solo l’autrice è una brava giornalista, che collabora con “La Repubblica” di Palermo e ha vinto nel 2007 il Premio Ilaria Alpi, ma il suo romanzo è bello, profondo, vero. S’intitola Il silenzio dei giorni ed è edito da Ianieri Edizioni, racconta una lunga notte milanese in cui Peppino Giunta, correttore di bozze siciliano ma ormai milanese d’adozione, narra un episodio della sua giovinezza, vissuta in un paesino ai piedi dell’Etna, al suo capo redattore. Con uno stile avvolgente e preciso, direi quasi senza fretta, senza sensazionalismi, con naturalezza, Di Natale ci trasporta in quell’epoca e in quella terra, attraverso la vita di un ragazzo che scopre i valori e le assurdità che regolano la sua vita e quella degli altri. Con al centro un tema quanto mai attuale: il rifiuto e anzi l’accanimento feroce su chi è diverso e non si adegua al patriarcato della tradizione.
Quella che descrivi è una tipica famiglia siciliana tradizionale, oppure è un caso limite?
Se guardiamo agli anni Settanta-Ottanta un buon numero di famiglie della provincia siciliana si poteva rispecchiare nelle dinamiche di casa Giunta. Per nulla poveri, anzi, con molte potenzialità economiche, ma ancora rivolti al passato, con un certo disprezzo timoroso della modernità e saldati ad un modello patriarcale molto forte. No, non parlerei affatto di caso limite.
Quanto c’è della tua infanzia in questa ricostruzione familiare?
Conosco molto bene il dolore familiare, quello sì. Ma per il resto ero tutta Lego, libri e lezioni di pianoforte. Non giocavo per strada, anche se qualche volta avrei voluto farlo, e fortunatamente non ho mai conosciuto da vicino esempi di omofobia e meno che mai di violenza familiare.
La provincia però la conosco benissimo così come il contesto economico agricolo, e seppure negli anni in cui Il silenzio dei giorni è ambientato (siamo nel 1973) io fossi poco più che una neonata, ricordo i riti collettivi e privati di quel decennio e di quello successivo.
La tua storia nasce da un fatto di cronaca, ma come hai scelto il punto di vista della voce narrante, un ragazzo, fratello di uno dei protagonisti?
Mi serviva il punto di vista di uno dei ragazzi vicini ai protagonisti del racconto, ma che potesse finalmente guardarsi indietro a distanza di molto tempo. Peppino Giunta è un sopravvissuto. Chi vive grandi dolori si porta dietro un peso enorme, per se stesso e forse anche per chi gli vive accanto, ma a volte può essere anche in una posizione di privilegio. Peppino vede la vita diversamente, indovina le sfaccettature come in un’ologramma.
Un siciliano emigrato a Milano e che poi ha quasi dimenticato la sua terra, è un caso che hai visto spesso?
Non spesso, ma Peppino Giunta non è un emigrato qualunque. È scappato da Giramonte per ben altri motivi che quelli lavorativi o economici…
Mi ha colpito il cameratismo nella vita di redazione che viene fuori dalle pagine del libro, con il caporedattore che ascolta la storia di Peppino Giunta. Quindi ci può essere amicizia tra colleghi nella tua esperienza?
Ovviamente si. I giornalisti saranno pure una brutta razza, ma tra simili può anche accadere di fare ottime amicizie per la vita. E poi Peppino Giunta, sebbene lavori in redazione, è un correttore di bozze.
Perché un romanzo?
Perché questa storia lo richiedeva. Adoro i racconti e non mi sazio mai di leggerli. Ho iniziato scrivendo racconti e ne sto scrivendo altri.
La storia di Saverio e Matteo, di Peppino, della sua famiglia e dell’immaginaria Giramonte aveva bisogno di una maggiore quantità di linee narrative. Volevo che anche la cornice della redazione – luogo prescelto per raccontare “tutto in una notte” – avesse la giusta estensione.
Alla fine noi ci aspettiamo un finale, poi in maniera sorprendente la cronaca e le storie personali si mescolano e si confondono, secondo te questo avviene talvolta nella realtà?
La realtà supera la mescolanza della narrazione in maniera eclatante. Siamo certi di potere contare almeno su un certo numero di esiti possibili invece nella realtà i finali dei rapporti, delle fasi di una vita, delle passioni ci sorprendono sempre.
Molto suggestiva la presenza della gigantessa Etna, cos’è per te?
Un essere senziente. Al pari di una fiera bellissima. È viva. In questa parte di Sicilia arriviamo a sentirne il respiro.
Quanto sono importanti le radici, il territorio d’origine, per chi scrive?
Secondo me nella stragrande maggioranza dei casi contano moltissimo. Puoi chiamarti Roth ma scrivi di Newark, Ortese e scrivi di Napoli, Sciascia e scrivi di Racalmuto eccetera. Poi c’è chi se li porta dietro senza saperlo oppure finge di essere al di sopra delle parti e al di là delle appartenenze. A questi ultimi credo poco. Noi siamo la prima terra che abbiamo calpestato, il cibo che ci ha fatto crescere ossa e muscoli. Ci portiamo dietro un corredo di gesti, parole, sguardi e respiri delle nostre origini. Poi il vero gioco lo fanno le storie e il punto di osservazione. E le combinazioni diventano milioni…
Come hai scelto di equilibrare dialetto, poco e solo quando serve, e lingua italiana?
Mi è venuto naturale. Il dialetto è anche linguaggio etico.
Na basta pochissimo per rompere certi conformismi letterari. I miei giovani protagonisti dicono parolacce dialettali irripetibili che però illustrano mondi e modi di pensare. Perché derubarli di una parte così importante?

“Disgrafia, aveva sentenziato l’ultimo dei medici consultati da quando erano apparsi i primi sintomi”.

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
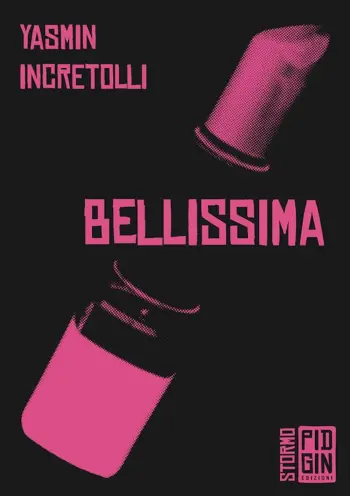
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare