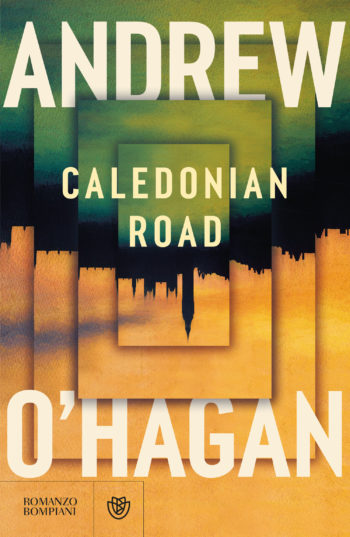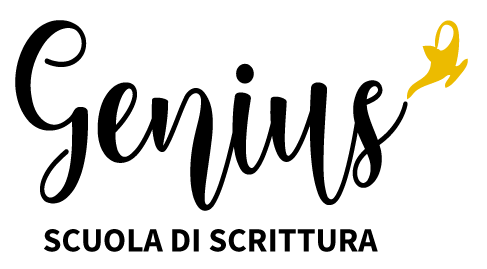LA POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA, a cura di Arnaldo Colasanti
(Bompiani, Milano – Marzo 2021)
La volta scorsa ci siamo lasciati con la poesia di Alberto Toni (Roma, 1954-2019), del quale stavolta riporto altri versi, di nuovo tratti da Liturgia delle ore:
Troviamoci oggi ancora.
Perché tra noi si sparga un desiderio:
le mani e il filo rimosso
dell’inizio quando non sapevamo spiegarci.
Che nulla vada perso.
Perché di noi si dica che viviamo.
Cerchiamoci nella città dove si avvera
il sogno. Siamo liberi nelle parole e nei gesti,
nel nome che chiamiamo, nella poesia
che trasporta i pensieri.
Le nostre speranze dicono che ci sono
spazi da colmare. Ecco che dunque
è giorno un’altra volta.
Visto che questa puntata della nostra rubrica esce subito dopo Pasqua, mi è parso consono aprire il nostro quindicinale appuntamento stavolta con versi che sono percorsi da una febbrile volontà di ritrovarsi, appunto, e da uno spirito ottativo, dal desiderio fervente che la fine davvero sbuchi in un nuovo inizio, e questa ripartenza non solo sia libera da costrizioni ma avvenga proprio nella poesia. Dunque la poesia come resurrezione. Il Bardo di Stratford puntava a una poesia eternatrice, ebbene Alberto Toni crede con tutte le sue forze nel sorgere di un altro giorno, nell’avere di nuovo da fare per colmare gli spazi ancora vuoti in cui contribuire alla vita. La poesia assicura di poter rinascere, come è ben indicato da quei due “perché”, non causali ma finali, sorretti da quegli esortativi che corredano un diffuso, franco benché timido, fiorire (ed è stagione) della vita, ancora, e a dispetto di tutto. È la realizzazione del sogno più sognato che c’è: non finire mai, risvegliarsi per sempre. La poesia crea un mondo parallelo al mondo reale, in cui dobbiamo soggiacere a miserie come perdere il filo, vedere che tutto va perso. La poesia tiene tutto insieme, tutto unito, nulla disperde e tutto trasporta con sé.
Anche stavolta i versi riportati sono tratti dall’antologia BRACI LA POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA (Bompiani, Marzo 2021) di cui si dava annuncio nel nostro scorso appuntamento: ne è curatore Arnaldo Colasanti, critico e studioso, autore di molti testi non solo di critica letteraria – per esempio La Magnifica, romanzo acido uscito qualche anno fa per Fazi, in cui la business class, su un Boeing che traghetta una truppa di letterati italiani a New York, trascinati in viaggio-premio dalla Vecchia che ha su di loro un potere subdolo e inossidabile, mette a nudo la scarsa classe di questa corte di individui che nulla hanno da invidiare alle maschere della Commedia dell’Arte e portano i nomi delle loro tipologie, come fantasmi di un morality play.
Ma, se non conoscete Colasanti (ne dubito), ne avrete le notizie essenziali in quarta di copertina.
La stessa quarta di copertina dove in poche righe si dice qual è il piccolo segreto di questa antologia.
Tutte le antologie sono in fondo lo specchio del gusto arbitrario di chi le compila. O meglio, rivelano il criterio di lettura di chi le cura. Senonché qui mi pare d’aver scorto qualcosa che via via vorrei farvi scoprire.
Dove sedimenta reciso, trama
in negligenti viluppi il possibile,
affabula nelle requie che raggiunge
il non potersi più alzare da terra.
Questa messe ha l’abbondanza dei giorni
rigogliosi; è la fine del superfluo.
È virtuale anche il tuo passo che aumenta
i frantumi e persegue vaghi innesti.
Non è qui che si consuma la fine,
mi rivolsi, se cresce il ramo monco
m’agiterò di nuovo, a questa vista:
la voglia amputata ritenta il volo
che il caso non avrebbe, se durassimo.
Stupita trascorreva le tue labbra
la certezza di incontrarci di nuovo.
Sono versi, questi, di Paolo Del Colle, in inattesa risonanza con i versi già citati di Alberto Toni, e percorsi, almeno nel suono, da echi danteschi: esattamente infiltrazioni dantesche in un tessuto novecentesco tutto a celebrazione di una poetica dell’incerto, del transeunte, del possibile e quindi anche dell’impossibile. Sono versi tratti da Gemme apicali, la prima raccolta pubblicata da Del Colle, poeta di cui ci siamo occupati in un numero lontano (credo uno dei primi) di questa rubrica.
Sono anche versi che forse meglio di ogni spiegazione rendono lo spirito d’osservazione professato e esperito da Arnaldo Colasanti come fratello di cammino dei “suoi” poeti sul sentiero della poesia.
Paolo Del Colle è uno dei sodali più antichi di Arnaldo Colasanti nell’avventura letteraria: compagno di studi e con lui fin da subito nel primo nucleo dei fondatori, negli anni Ottanta, della rivista BRACI, appunto. Come ci “avvisa” lo stesso Colasanti nella premessa all’antologia, AVVISI PER L’USO, la rivista BRACI, che visse tra il 1980 e il 1984 come ciclostile a uscite irregolari, è stato il primo luogo di quel costante monitoraggio della poesia e dei poeti a cui Colasanti si dedica appunto da allora, e qui ritroviamo tutti i suoi “compari”, da Edoardo Albinati a Marco Lodoli, da Claudio Damiani (effettivo co-fondatore) a Gino Scartaghiande (il poeta medico salernitano). E poi arriva l’altra rivista di poeti e poesia che è Prato Pagano, ideata e portata avanti da Gabriella Sica, e nasce la simbiosi dei poeti con la galleria La Nuova Pesa che si identifica in Simona Marchini.
Adesso io ho una nuova casa, bella
anche adesso che non v’ho messo mano
ancora. Tutta grigia e malandata,
con tutte le finestre rotte, i vetri
infranti, il legno fradicio. Ma bella
per il sole che prende ed il terrazzo
ch’è ancora tutto ingombro di ferraglia,
e perché da qui si può vedere quasi
tutta la città. E la sera al tramonto
sembra una battaglia lontana la città.
Io amo la mia casa perché è bella
e silenziosa e forte. Sembra d’aver
qui nella casa un’altra casa, d’ombra,
e nella vita un’altra vita, eterna.
Questi versi di Beppe Salvia (Potenza, 1954-1985) provengono da Cuore, cieli celesti: Beppe Salvia è il primo poeta che Colasanti inserisce nell’antologia, è l’apripista della squadra di poeti monitorati dal curatore. Ma il monitoraggio nel caso di Beppe Salvia è stato breve: Salvia è stato primo animatore di BRACI eppure la sua poesia è stata pubblicata tutta postuma. Però la sua azione poetica e umana ha profondamente infiltrato la nuova poesia italiana: di Salvia, nella nota finale, Colasanti ci racconta molte cose, soprattutto la condivisione della letteratura, del lavorìo sulla lingua, del cesello dei versi, “La forza del verso è invece la frana della vita, perché la vita è infinita e crudele innocenza. L’endeca= sillabo di Beppe è immaginale, paleontologico, carsico, esatto e limpido, oscuro: forte e struggente come un verso di Puškin”. E ancora, coglie la consonanza di Beppe Salvia col magnifico John Keats, “La loro lingua è similmente orfana […]. Beppe come John, […] è per entrambi inevitabile il fatto che il presente della lingua sia davvero nella vita, nella sua evidenza congetturale e originaria di bellezza e verità quale principio sommo del reale” [“Beauty is truth, truth beauty,—that is all / Ye know on earth, and all ye need to know”, ci raccomanda John Keats in Ode on a Grecian Urn]
Dal sonetto LXXIV di Shakespeare
Sii sereno quando un giorno le ali
nere del giudizio irrevocabile
ombre daranno al mio viso. Ché io
o qualcosa di me rivivrà in questi
versi che ancora con te staranno.
Lì vedrai che è la linfa
dell’amore che ti portai. Ora soltanto terra
può rifarsi terra, ma ciò che è spirito,
il verdeggiante ritratto che di un uomo rimane
nel cuore degli uomini e il calore che fuor della terra
è nel cuore degli uomini e quel viaggio che ci porta
alla totalità di Dio e nel gran vero del sogno
di me e della vita che mi riguardò, tutto
questo ti riguarda.
Allorché sarò morto perderai
qualche lieve lineamento che completava l’insieme del mio volto
che non è altro che una minuscola
pietra della creazione, linea che l’avvento
degli anni cancella
e il corruttibile e distratto irregolare bersaglio
del coltello d’un miserabile.
Soltanto bello forse è ciò che sono
i versi che per te ho scritto e che nella tua stanza rimangono.
Questa elaborazione del sonetto shakespeariano n. 74 è del poeta e traduttore Pietro Tripodo (Roma, 1948-1999), del quale Colasanti ci racconta l’implacabile lavoro e bisogno di confronto soprattutto sui versi dei grandi poeti stranieri. Tripodo beffardamente è scomparso agli sgoccioli del Novecento come il nostro caro Pietro Pedace, che anche Arnaldo conosceva, e più o meno nello stesso giro di giorni. Un disastro, cioè due. Due disastri. Due perdite incalcolabili. Di Tripodo, Colasanti, proprio intorno a questa sua rielaborazione del testo inglese, ci racconta, “Avevo portato con me il sonetto originale e cercavo di seguirti. Ma ogni tua sillaba era un’apertura…”.
Ecco, fa parte del segreto che si muove tra le pagine, e io vorrei provare ad analizzare e indicare in questo mio contributo, la seconda parte di questa antologia: tutti i poeti ricondotti a un elenco alfabetico (con indicazione della sezione e della pagina dove, nella prima metà, si possono leggere campioni dei loro versi) e ampiamente raccontati in lunghi saggi pieni di notizie e notazioni critiche. È rievocato l’intreccio intenso del curatore con le loro vite e nello stesso tessuto sono ricostruiti i fili del loro tributo all’opera poetica, alla poesia come creazione e celebrazione della vita in vita nuova. Il risultato è una lettura critica poetica a sua volta, non perché immaginifica oltre il lecito o l’autoriz= zato dai testi, ma perché rivelatoria o disvelativa. Una lettura commentata che schiude agli occhi dei lettori il principio di creazione annidato nei testi. E poi è bello sfogliare un’antologia che include poeti per il resto assenti dalle solite rassegne, come Giuliano Goroni (1947), marchigiano, di cui Colasanti ci dice, “Vive in estrema solitudine”:
Stanno, all’inizio del paese, tra l’ultima
rondine e le prime lucciole nel saluto
corto che li ricongiunge, scalfiti
un poco dal peso inerte del cielo,
dall’incerto volto della terra,
e al dio che l’abita, pare troppo angusto
tempio, la pensosa trasparenza,
il pallore azzurro d’ognuno.
Un lento volume d’ardente fragilità
galleggia tra i pitosfori freschi e acuti,
fra casette gialle e miti cui anni timidi
fanno somma addosso, e filano bozzoli
di mete lontane, di incerti propositi
antichi, nuovi ad ogni sera.
Ad ogni sera, la valle è sempre un gorgo
nerazzurro, sopra, il parapetto di pietra
chiede la carezza d’una mano
per fare della sua stretta realtà
una grazia un dono un’armonia.
Sono versi tratti da Almanacco di primavera. Arte e poesia, preceduti da un peana in quartine del “paese tra le case”, che richiama il villaggio di provincia, e, sottolineando il “tinnire di faccenda”, ci congeda con “più ombra, i muri, donano ai muri”. Ad essi seguono questi altri versi:
Case e fienili si aprono a un alto
carro di fieno e il monello in cima,
trascorre tra nuvole rotte dallo
scirocco, l’appello placido e cieco
dei giorni. […]
Versi, questi di Goroni, di chiara eco leopardiana e con un occhio molto indietro al caro Esiodo di Le Opere e i Giorni, cioè versi che, mentre evocano (con quel “tinnire”, e anche in quel paesaggio locale di confidenza) la filiazione leopardiana e il richiamo d’affetto a una tradizione connaturale, cantano l’affetto anche per l’oggi “placido e cieco”, cioè senza ansia di anticipazione, che è la vita di provincia.
“La lingua di Giuliano Goroni”, ci dice Arnaldo Colasanti nella seconda parte dell’antologia intitolata, giustamente CANTIERE DEL CONTEMPORANEO, “è soprattutto calore: sentire appunto, più che pensare, tutto ciò che accade attorno.” Possiamo poi scoprire un poeta come Francesco Nappo (Napoli, 1949) – da Genere (1996):
Gheographòi
(agli storici antichi)
O saggi che odiaste il tempo
innocente, tra schiume di mùrice
esangui e frane d’argento sospese
sul mare nell’ultimo azzurro,
nasceva la notte che cede alla notte, così
puramente persuasa di sé.
E voi narravate, per tenebre
vaie, di terre al sole vegliate,
da arboree ombre di templi, di molte
tra l’onde e le nubi stagliate città
la luce dimentica e lieta tra
voci d’emporii e grida di ciurme.
Lo sterco di greggi fulventi la via
dell’aperto tracciava, il flauto ancora
ascoltava sorgive segrete di
vero nel rado dei monti boscosi.
L’aedo parlava cantando, a
incredule corti il fato narrando, e
l’ascia stroncava la vita ai ròveri
immani per dare una chiglia
cretese alle navi e farle sorelle
dei venti ed arpe d’abisso frementi.
Un esempio di poesia magnogreca, mi viene da dire: si notino l’uso della anastrofe o inversione, l’evocazione sia del mondo arcadico o pastorale che dell’antico ambiente pedagogico e poetico per la presenza delle ombre di templi, delle greggi, e, ancor più, per la voce melodiosa dell’aedo, fino alla finale irruzione del mare che già palpabilmente premeva lungo tutta la narrazione ricca di sonorità forti, allitterative. Notevole il lavoro sulle parole: mùrice, vaie, fulventi, ròveri, sono piccoli tesori.
E poi fa piacere ritrovare la poesia di Giovanna Sicari, di Antonella Anedda, di Maria Pia Quintavalla, di Umberto Fiori, di Gino Scartaghiande, di Nadia Campana, di Irene Santori, di Francesca Ricchi:
Vorrei farti felice con questo niente
Babbo, vorrei comprarti
tutte queste piccole cose
esposte al mercato,
cose piccole, inutili:
arnesi, cianfrusaglie, biglietti.
Vorrei farti felice con questo niente
che colma il vuoto
con quest’amore che ripara,
tu solo annaffi le piante lievi
lavi e curi ogni cosa
e scavi nella compostezza
della vita, con decisione
raccogli foglioline e altro
tu solo puoi entrare nell’infinito.
[Giovanna Sicari (Taranto 1954 – Roma 2003), da Epoca immobile]
____________________
Se l’avesse vista
se avesse visto la sua forma mortale
spalancare stanotte il frigorifero
e quasi entrare con il corpo
in quella navata di chiarore,
muta bevendo latte
come le anime il sangue
spettrale soprattutto a se stessa
assetata di bianco, abbacinata
dall’acciaio e dal ferro
bruciandosi le dita con il ghiaccio
avrebbe detto non è lei. Non è
quella che morendo ho lasciato
perché mi continuasse.
[Antonella Anedda (Roma 1955), da Historiae]
______________________
Esiste la deliziosa
prossimità, non il perfetto amore.
E intanto
lunghi tragitti tratti
erosi da pianto, polvere
di sentieri assembrati angoli della mente che
stavano per sfollare e – sostano,
campi desertici
trasferimento, letto come strada
silenzio non ancora pace.
[Maria Pia Quintavalla (Roma 1952), da Le Moradas]
_______________________
Sosta
Il treno porta ritardo
e non si muove, non parte.
Il sole non si vede quasi
ma è già chiaro dall’altra parte,
come se tutta questa luce che viene
la facessero quattro case.
Illuminazione
Come quando la luce va via
e nelle case
si sfiorano gli stipiti, si va
da un buio
ad un altro buio:
se la luce va via,
mentre sfiori gli stipiti da un buio
a un altro buio
ti viene incontro questa serietà
[Umberto Fiori (Sarzana, La Spezia – 1949)
Sosta, da Case – Illuminazione da Esempi]
_____________________
[…]
Mentre più luci possono
illuminare, può che tu ne vedi
la cornice d’un paesaggio
e atmosfere tenere.
E cosa fondono questi
paraventi di cieli e cosa
mandano e perché un
personaggio di me si cullava
da dentro, quasi da dentro
un mistero
Era il silenzio stesso
a guardarmi e divorarmi
Io calpestavo nel molle
ma ero benefico.
Aumentavo come minimamente
le nubi convergenti.
Prima di ciò
avevo la facilità
d’esserci. Ora è come
da una finestra a metà
senza differenza ma doverosa.
[…]
[Gino Scartaghiande (Cava de’ Tirreni, SA – 1951), da Oggetto e circostanza]
______________________
Ho fatto un grande sogno ma non me ne ricordo
niente babbo amiamo le teste bruciate
dell’amore ma non la misericordia e
i chiodi come coltelli di gelosia
tra poco cadrà la strada su di te
spergiuro sulla mia infanzia scrivo
lettere, se non mi dai da mangiare
i capelli mi diventeranno come crine
e come un fucile. Notte di lupi
sprangare l’angelo del vento
qui è la piega
dove non sarà nuovo morire
[Nadia Campana (Cesena 1954 – Milano 1985), da Verso la mente]
______________________
Dal greco
25 agosto, notte della taranta
il farmacista traduce
il suo apotheke in italiano
questa notte, sulla strada per Melpignano
milioni di cimbali d’argento e di pianeti
mi faranno danzare.
Al convento degli agostiniani
già la terra ventriloqua
si contrae sotto le gambe
si spazientisce e sui prepara.
– Tua figlia è pazza di te! – ti grido
per come ti inarca
le ginocchia sbucciate sotto il mento
socchiude le ferite
e dilata le narici. Anch’io
farei così.
E ci provo a legarle i capelli,
ma che vuoi, i più teneri,
gli ultimi nati
saltano la corda e sfuggono
come d’estate le bisce
dagli oleandri.
Anima mia, Anna mia, Anna fame mia
tosson orìa
ghenomeni così
ben fatta Anna
chiedimi tutto, tutto
quello che vuoi
io quaggiù [la figlia è sulle spalle del padre, ndr]
a te
sottomessa
– fa’ presto! – mi scuoti e mi rispondi
– va’ a vedere la facciat, che fra un po’ non si capisce niente –
e come?
Mi lego Nicola alla cintura
e penetro
nell’organo lucente
come il bue condotto alla fiera
io sono
lo stupido dio erbivoro
alla pesa
da carne. […]
[Irene Santori (Roma 1973), da Hotel Dieu]
______________________
[…]
Ma io conservo in qualche grembo dello spirito
ben oltre gli spazi di cavità distante
l’impossibile ossessione di annegare la distanza
come non fossimo soltanto germe e piaga
dell’errore denso
nonostante i sussurri delle schiume
e le molteplici chiavi disperse nei venti opachi
ci piega infatti una richiesta
o meglio la necessità
di comunicare come esistesse il vero
nei fatti e perfino dell’argomentare
mentre non distinguiamo nemmeno le lettere
nel mugolare delle foglie
né i versi di animali e furie tra i secoli smarriti
e torna sempre la mancanza
e la questione eterna degli intenti
che ha conficcato i canini nel terroe
di scioglierci in oblio
[…]
[Francesca Ricchi (Bologna 1971)]
______________________
…accennavo a un piccolo segreto che è annidato in questa antologia curata da Arnaldo Colasanti, e che come è ovvio rende questa antologia diversa dalle molte altre che sono fiorite e fioriscono di continuo, comprese anche quelle che abbiamo esplorato qui, in questa rubrica. Nella premessa, come per un disclaimer dovuto, il curatore chiarisce il criterio di scelta degli autori da includere (spesso chi non è inserito si lamenta per l’esclusione: Colasanti compila una paginetta di requisiti, i suoi propri);
poi passa a enunciare il proprio metodo, che è un metodo di lettura – l’ermeneutica, “l’auscultazione dello studio”; non solo auscultare i testi ci permette anche di farci cambiare dai testi che leggiamo, ma è l’unico modo per “onorare l’intelligenza dei poeti”; mentre del nome dato all’antologia si è già ampiamente detto all’inizio di questo saggio. Ma il segreto… il segreto qual è? Sto benedetto segreto che se ne sta acquattato, placido e sornione, un po’ comare un po’ serpentello – qual è? È semplice, ed è anche, come si diceva, incautamente svelato in quarta di copertina, tirato fuori dalla pagina sul metodo: “il metodo è rischiare la cosa più difficile […], ciascun poeta viene letto e ammirato come se già fosse un classico”. È proprio questo modo di porsi rispetto a quel corpo vivo, “essere vivente e in sé contraddittorio, difettoso e laboratoriale”, che è la poesia, a sottrarre questa antologia alla tenta= zione di stabilire etichette categorizzazioni e correnti creando in realtà solo insiemi di coincidenza per versificazione e tematiche, preferenzialmente tenute insieme dall’esperienza che di quei poeti e della loro azione in versi ha fatto come incontri di vita il curatore:
“Sentire a fondo che la critica è possibile solo se c’è una grande poesia che le dà parole per dire”.
È questo che convince: questo lavoro di monitoraggio della poesia nel suo farsi e diversificarsi, in un lavoro di valutazione costante – in costanza di osservazione. Proprio per questo, in questa (si potrebbe obiettare, insensatamente) ennesima antologia di poeti, chi davvero cerca la poesia trova alcuni tra “i soliti” poeti, consolidati, ma ne trova molti e molte di cui non aveva mai sentito parlare.
Chiuderei con dei versi che onestamente mi sono venuti incontro aprendo casualmente il libro,
come accade dopotutto con gli incontri della vita in cui ogni cosa sfugge al controllo:
Per alcuni anni, prima di addormentarmi
ho sperato sarebbe venuto a prendermi
come davanti al portone della scuola
quando gli consegnavo la cartella
e m’aggrappavo al suo braccio.
Sarebbe stato là, sul marciapiede,
m’illudevo, distante da tutti e fumando,
ma niente, nemmeno la brace della sigaretta
a luccicare nel buio dove lo immaginavo.
Poi in un’alba livida e piena di vento,
quando ormai non ci contavo più,
si è aperta e richiusa la porta dove dormivo
e l’ho visto: era lì, ai piedi del letto,
che mi aspettava fumando.
[Stefano Simoncelli (Cesenatico 1950), da Hotel degli introvabili]
_________________________________________________________________
Tutti i testi poetici qui sopra riportati sono tratti dall’antologia oggetto del presente saggio, BRACI LA POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA (Bompiani, Marzo 2021) a cura di Arnaldo Colasanti, i cui brani critici sono chiaramente indicati in quanto riportati tra virgolette.