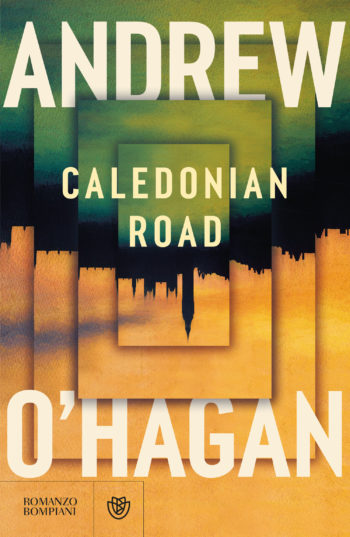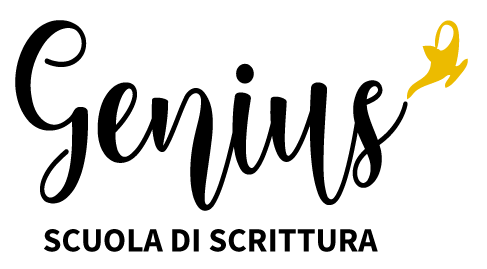CONTROFIGURA POETICA DI BORIS PASTERNAK
La notte bianca
Un tempo lontano mi riappare,
una casa del Quartiere Pietroburgo.
Figlia di una modesta possidente della steppa,
sei studentessa, sei nativa di Kursk.
Sei carina, non ti mancano i corteggiatori.
In quella notte bianca noi due,
accoccolati sul tuo davanzale,
guardiamo giù dal tuo grattacielo.
I lampioni, quasi farfalle di organza,
sono sfiorati dal primo brivido del mattino.
Ciò che ti racconto sottovoce
Assomiglia tanto alle lontananze addormentate.
Siamo avvolti da una stessa
Ritrosa fedeltà a un segreto,
come Pietroburgo che si stende a panorama
al di là della Neva sconfinata.
Laggiù, lontano, per limiti impenetrabili,
in questa notte bianca di primavera,
gli usignoli dei loro inni fragorosi
riempiono gli spazi boschivi.
In questi luoghi, come una viandante scalza,
avanza la notte lungo lo steccato
e dietro, dal davanzale, si stende la scia
della conversazione origliata.
Negli echi di quei discorsi ascoltati,
nei giardini recinti da palizzate,
i rami dei meli e dei ciliegi
si vestono di fiori bianchicci.
E i bianchi alberi, come fantasmi,
si riversano in folla sulla strada,
quasi facendo cenni d’addio
alla notte bianca che tante cose ha visto.
Questo poemetto è una delle poesie attribuite al medico russo Jurij (da piccolo chiamato in casa Jura, specie da sua madre), poste in genere in appendice al romanzo Il Dottor Živago di Boris Pasternak. Subito due notazioni sul testo: 1. nei versi sentiamo echi chiarissimi di due opere russe eccezionali, Le notti bianche di Fjodor Dostoevskij, con tutta la faccenda dei discorsi origliati, e dell’oscurità della notte che scivola avanti fino a calare solo alle tre del mattino, e Il giardino dei ciliegi di Anton Čechov, medico drammaturgo narratore; 2. poi ci colpisce molto il segno simbolico del bianco della notte russa, del bianchiccio dei fiori sugli alberi, un bianco, per quanto stropicciato dagli agenti esterni, che sta per la purezza di uno sguardo, che già molte cose ha visto. Questa è l’essenza dell’anima di Jurij Živago, uno spirito puro ma non ignaro, che per propria inclinazione, poetica, si tiene aggrappato alla purezza e già molte cose ha attraversato, come racconta il romanzo pasternakiano. Naturalmente ci torna in mente la neve, la dacia, i boschi, il gelo attorno alle rotaie e al treno, cioè percepiamo, come durante la lettura di certi passi del romanzo, il valore agghiacciante di certi sguardi vitrei di rivoluzionari, e la bufera che avvolge Jurij e Lara, per poi separarli.
Separazione
Dalla soglia un uomo guarda
senza riconoscere la casa.
La partenza di lei fu come una fuga.
Dappertutto segni di soqquadro.
Ovunque nelle stanze caos.
Della gravità della devastazione
non si rende conto per le lacrime
e un attacco di emicrania.
Dal mattino ha nelle orecchie un ronzio.
È in sé oppure vaneggia?
E perché gli torna nella mente
di continuo l’idea del mare?
Quando oltre la brina alla finestra
non si vede che c’è fuori,
la disperazione dell’angoscia
doppiamente ricorda il deserto del mare.
Lei gli era così cara
in qualunque suo tratto,
come al mare sono vicine le sponde
con tutta la linea della battigia.
Come sono sommersi i giunchi
dal mareggiare dopo la burrasca,
gli sono discesi nel fondo dell’anima
i tratti e le forme di lei.
Negli anni delle tribolazioni,
nei tempi di un’inconcepibile esistenza
l’onda del destino
l’aveva sospinta a lui dal fondo.
Tra ostacoli senza fine,
sfuggendo alle insidie,
l’onda l’aveva sospinta, sospinta
e unita a lui strettamente.
Ed ecco adesso lei è partita,
forse a ciò è costretta.
La separazione li divorerà entrambi,
l’angoscia li stritolerà del tutto.
E l’uomo guarda intorno:
lei al momento di andar via
dai cassetti del comò
ha buttato tutto alla rinfusa.
Lui vaga, e fino all’imbrunire
rimette nel cassetto
pezzi di stoffa sparpagliati
e un modello di taglio.
E pungendosi con un ago,
lasciato nel cucito,
d’un tratto la rivede tutta
e piange piano piano.
Convegno
Ricoprirà la neve le strade,
si ammucchierà sui tetti spioventi.
Andrò a sgranchire le gambe:
dietro la porta ci sei tu.
Sola, nel paltò autunnale,
senza cappello, senza calosce,
lotti con il tuo turbamento
e mastichi madida neve.
Gli alberi e gli steccati
si stendono lontano nel buio.
Sola sotto la nevicata
sei ferma all’angolo della via.
Scivola l’acqua dal fisciù*
lungo la manica nel risvolto
e tra i capelli sfavillano
gocciole di rugiada.
E una ciocca bionda
illumina il viso,
il fisciù, la figura
e il tuo paltoncino.
Neve acquosa sulle ciglia,
nei tuoi occhi angoscia,
e tutto il tuo sembiante
è fatto di un unico pezzo.
Come se a mo’ di ferro
bagnato in tintura
t’avessero fatto incidere
il mio cuore.
E lì per sempre si è fissata
la mitezza di questi tratti
e perciò non importa
se il mondo è crudele.
Per questo si sdoppia
tutta questa notte di neve
e a tracciare un confine
tra noi due non riesco.
Ma chi siamo e di dove
se di tutti questi anni
sono rimaste le maldicenze,
e al mondo non ci siamo più?
*[foulard triangolare coprispalle, ndr]
L’alba
Tu significavi tutto il mio destino.
Poi venne la guerra, lo sfacelo,
e per tanto, tanto tempo di Te
non si sentiva neppure una parola.
E dopo molti, molti anni
la Tua voce di nuovo mi ha turbato.
Tutta la notte ho letto il Tuo Testamento
e come da un deliquio sono tornato in me.
Vorrei andare tra la gente, nella folla,
dentro la loro animazione mattutina.
Sono pronto a ridurre tutto a pezzi
e mettere in ginocchio tutti.
E scendo giù di corsa per le scale,
come se uscissi per la prima volta
in queste vie innevate
e sui selciati senza vita.
Dovunque ci si alza, luci, conforto,
si prende il tè, si corre ai tram.
Nel giro di pochi istanti
l’aspetto della città è irriconoscibile.
Negli androni il vento intesse
una rete di fiocchi che volano fitti
e per arrivare in tempo tutti corrono
senza finire di far colazione.
Io per tutti loro sento,
come se fossi nella loro pelle,
io stesso mi sciolgo come si scioglie la neve,
io stesso, come il mattino, aggrotto le ciglia.
Con me è gente senza nome,
alberi, bambini, casalinghi.
Da tutti loro io sono vinto,
e solo in questo è la mia vittoria.
Come sempre l’inizio, il giro di manovella che fa partire il motore, che mette in moto la macchina del racconto, è frutto della selezione accidentale in una folla di possibilità. Mai come nella poesia questo è vero. Se vi dicono che la maestria dell’autore è stata aver saputo scientemente capare il gancio (in mezzo al cielo, direbbe il cantautore) da cui avviare tutto il meccanismo, bè, non ci credete. Il massimo del risultato (perché è un risultato che state contemplando, ormai state lì a cose fatte) consegue sempre al minimo dell’intenzionalità. E anche avviare un articolo dopotutto pone questo genere di imbarazzo. Lo dico per avvertirvi che vedrete questo articolo iniziare più e più volte: una pletora di inizi e zero conclusioni.
A chiudere si stenta sempre.
Qualche difficoltà pone anche la comprensione di cosa sia venuto prima e cosa dopo.
In un caso come Il Dottor Živago, epocale romanzo di Boris Leonidovič Pasternak, come si devono intendere le poesie di Jurij Živago, il protagonista? I curatori di un magnifico volume – edito da Feltrinelli nella collana Comete, PASTERNAK, Le poesie di Jurij Živago (cioè Clara Janovic e Vittorio Strada, la Janovic in particolare, autrice dell’introduzione), ci fanno sapere che Jurij Živago “nel suo sembiante di uomo comune, è un libero spirito creativo che nella poesia trova la sfera di manifestazione della sua più intima vitalità, la affermazione di quella segreta libertà spirituale che la realtà circostante ha distrutto con la violenza della rivoluzione e la mistificazione dell’ideologia, che egli anche nell’esistenza quotidiana miracolosamente conserva”.
Notte d’inverno
Tormenta, tormenta su tutta la terra
in ogni contrada.
Una candela ardeva sul tavolo,
una candela ardeva.
Come d’estate i moscerini in nugoli
volano attratti dalla fiamma,
così i fiocchi di neve dalla via
volavano verso la cornice della finestra.
La tormenta scagliava sul vetro
cerchietti e frecce.
Una candela ardeva sul tavolo,
una candela ardeva.
Sul soffitto illuminato
si posavano le ombre.
Incroci di braccia, incroci di gambe,
incroci del destino.
E due scarpette con un tonfo
cadevano sul pavimento.
E dal lucignolo la cera a lacrime
gocciolava sul vestito.
E tutto svaniva nella foschia
canuta e bianca della neve.
Una candela ardeva sul tavolo,
una candela ardeva.
Sulla candela da un angolo veniva un soffio.
E la febbre della tentazione,
come un angelo, ergeva due ali
a forma di croce.
La tormenta infuriò tutto febbraio
e di continuo
una candela ardeva sul tavolo,
una candela ardeva.
Chi di noi qui non visualizza i vortici di neve e il vento che avvolge Jurij e Lara, il turbinare del gelo come metafora del turbinare del destino? Chi di noi qui non nota che nella ripetizione della formula, -una candela ardeva sul tavolo, / una candela ardeva-, il poeta raddoppia e moltiplica proprio questa idea di una poesia che è un fortino in cui l’anima si tiene al riparo, conserva una minima luce sulla realtà, sta composta e raccolta, e può salvaguardarsi dagli assalti e dalle intemperie dell’esistenza?
Pasternak, poeta, fu autore di questo solo romanzo: vicenda biografica in cui si affacciano i suoi versi, attribuiti al protagonista, Jurij Živago, medico, spirito amante, spirito libero, che conserva dentro di sé il ricordo caro, che sua madre amava chiamarlo Jura, medico poeta che nulla sa del mondo letterario, eppure sa il fatto suo quanto a linguaggio temi composizione, insomma quanto a poetica. Un uomo in cui si è annidato il fanciullo che in apertura di romanzo è in prima fila durante la tumulazione della madre, e in quella cerimonia avverte tutta la grana fasulla della fetta di società (la famiglia, i parenti, gli amici) che lo ignora e minimizza il suo dolore, tutto il sottofondo ambiguo dei loro rapporti che lastricheranno il suo esercizio dello stupore nella successiva vita adulta. Un sincero russo sballottato dai venti della Storia e irriducibile ai dettami della rivoluzione bolscevica. Questo è Jurij Živago, ed è questo l’essudato della valutazione storico-sociale agita da Boris Pasternak, in modo dolente, nel romanzo, nel suo eroe eponimo. Il romanzo di un poeta sulle traversie di un medico poeta in pectore. Il rovescio dell’Onegin di Puškin, a pensarci bene, romanzo in versi di cui possiamo leggere la straordinaria traduzione, la più recente, ad opera di Pia Pera.
Fango di primavera
Le luci del tramonto si smorzavano.
In un fangoso sentiero di una fitta foresta
verso una lontana fattoria degli Urali
a fatica avanzava un uomo a cavallo.
Sobbalzava la milza all’animale
e al suono degli zoccoli nel pantano
lungo la strada faceva eco
l’acqua nei vortici delle sorgenti.
Quando l’uomo allentava le redini
e metteva il cavallo al passo,
la piena gli rovesciava accanto
tutto il suo rombo e fragore.
Qualcuno rideva, qualcuno piangeva,
si sbriciolavano le pietre contro le selci,
e nei gorghi cadevano
ceppi divelti con le radici.
E nell’incendio del tramonto,
nel lontano nerume dei rami
come il rimbombo di una campana a stormo
si scatenava un usignolo.
Dove il salice il suo velo vedovile
chinava, spenzolando sul burrone,
come l’antico Usignolo Brigante
fischiava sulle sette querce.
A che sventura, a che passione
era destinato quel fervore?
Chi nella boscaglia voleva impallinare
con quella carica di schioppo?
Sembrava che, come uno spirito silvestre,
stesse per sbucare da un bivacco di ergastolani evasi
incontro a pattuglie a cavallo o a piedi
di partigiani di quella zona.
Terra e cielo, foresta e campi
coglievano quel suono raro,
quelle ritmate scansioni
di follia, dolore, felicità, tormento.
Pasternak non è Živago, anche se gli affida una parte della sua anima e della sua poesia.
Pasternak è russo e non è sovietico. Si contrappose idealmente a Stalin, che forse lo ignorò principalmente perché tra i due c’era un abisso di considerazione e sensibilità oltre che di fini pratici nella realtà tempestosa della Storia (è noto l’episodio della telefonata che forse ci fu tra Stalin e Pasternak a proposito dei poeti, in cui Stalin vedeva dei veri destabilizzatori sotterranei del suo potere poliziesco e cieco, di Mandel’stam in specie, nel giugno 1934).
Pasternak visse sempre ai margini, a Peredelkino, vicino Mosca: lontano dal centro, dalla grande città e dalle avanguardie cui si era inizialmente avvicinato. La sorte editoriale di Živago la dice lunga sulla sua posizione rispetto al potere e sulla sua sorte personale. Fu Giangiacomo Feltrinelli nel 1957 a pubblicare il romanzo per la prima volta in assoluto, il che vuol dire che la circolazione del libro avvenne prima di tutto in italiano: ne esistevano copie clandestine in russo in cui appunto Pasternak distribuì la parte poetica in contrappunto alle parti in prosa narrativa. Cioè il libro per lui era un prosimetro. Monumentale, voluminoso. Anche in questo unico. E sappiamo che rinunciò a uscire dall’URSS per ritirare il Nobel altrimenti non sarebbe potuto rientrare: inconcepibile per lui. Pasternak piaceva anche a Abraham Sonne / Avraham Ben Yitzhak, il poeta galiziano di lingua ebraica di cui abbiamo letto qualcosa nella scorsa puntata. Gli piaceva con qualche riserva. La fortuna di Pasternak è stata un po’ limitata dal giudizio che molti ebbero verso le sue pagine, in prosa o in poesia, considerate troppo sentimentali dunque letterariamente deboli (!!!) Era accusato d’essere romantico, un irrazionalista (!!!) Cioè d’essere un russo? E certo che sì. Con orgoglio!
Vi regalo una breve messe di altri versi suoi, chiudendo il discorso con un’osservazione: mi sono convinta (ho deciso, diciamo) che molte delle immagini che David Lean ha costruito nella versione cinematografica del romanzo del 1965 (con Omar Sharif, Julie Christie, Alec Guinness, e un implacabile Rod Steiger) le abbia trovate proprio nelle poesie di Jurij Živago.
La bambina
Dormiva la notte la nube dorata
sul petto dello scoglio gigante!
Dal giardino, dalle altalene, di punto in bianco
irrompe il ramo nel trumeau!
Immenso, accosto, con una goccia di smeraldo
in cima alla falange.
Il giardino è coperto, dal suo disordine travolto,
per il trambusto che gli crolla in viso.
Consanguineo, enorme, come il giardino,
e per sua natura fratello! secondo trumeau!
Ma ecco il ramo è messo nel bicchiere
e posato accanto allo specchio.
Chi – indovina – mi vela gli occhi di lacrime,
di umano torpore che imprigiona?
[L’epigrafe è tratta da Lo scoglio (1841), lirica di M. Lermontov.]
***
Mia sorella la vita anche oggi in piena
s’è franta come pioggia primaverile contro tutti,
ma la gente coi ciondoli è altamente scontrosa
e con garbo punge, qual serpe nell’avena.
I più anziani hanno in questo le proprie ragioni.
Senza dubbio, senza dubbio è ridicola la tua,
che siano nel temporale lilla gli occhi e le aiuole
e d’umida rese da profumi l’orizzonte.
Che in maggio, quando l’orario dei treni
nello scompartimento leggi, col tratto di Kamysin,
più grandioso esso sia delle Sacre Scritture
e dei sedili neri per polvere e bufere.
Che appena il freno s’imbatte, latrando,
nei campagnoli pacifici d’una vigna sperduta,
dalle cuccette guardino se non sia la mia fermata
e, tramontando, il sole si dolga con me.
E per la terza volta spruzzando salpa il campanello
con scuse ininterrotte: spiacente, non è qui.
Sotto la tendina alita una notte ardente
e la steppa svanisce dai gradini verso una stella.
Occhieggiando, ammiccando, ma dormono dolcemente.
in qualche dove e come fata-morgana dorme l’amata
nell’ora in cui il cuore, guizzando per le piazzole,
‘I gli sportelli dei vagoni sparge nella steppa.
***
Lezioni d’inglese*
Quando dové cantare Desdemona,
e cosi poco da vivere le restava,
non per l’amore, sua stella, ma per un salce
scoppiò in singhiozzi, per un salce.
Quando dové cantare Desdemona
e la voce impostò, facendosi animo,
sulla nera giornata un nerissimo demone
di un salmo di alvei piangenti la provvide.
Quando dové cantare Ofelia, –
e cosi poco da vivere le restava, –
tutto il riarso dell’anima fu d’un soffio rimosso
come in un turbine pagliuzze da un fienile.
Quando dové cantare Ofelia,
dell’amaro dei sogni ormai stanca,
con quali trofei svanì?
Con una bracciata di salci e celidonie.
La passione dalle spalle scrollata come sacco
entrarono con l’animo sospeso
nella piscina dell’universo, il proprio corpo amoroso
per aspergere e stordire con i mondi.
*Boris Pasternak fu anche traduttore in russo di William Shakespeare.