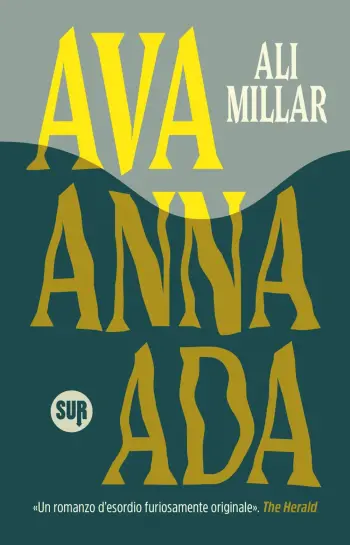E mi sorrideva.
Aveva un faccino piccolo, chiaro e occhi verdi da gatta selvatica. E i capelli erano grossi, biondi e striati, solo un po’ schiacciati sulla nuca nel punto in cui ogni tanto la testa le sbatteva sullo schienale.
La paura era passata. Al suo posto un magnetismo, una potente attrazione.
Bea voleva comunicare, incurante di riuscire a produrre spesso solo suoni disarticolati, e presto imparai a trovare le parole dentro quei suoni.
Cominciai ad andare da lei sempre più spesso, passavo a trovarla dopo la scuola col piacere di stare insieme a lei, attratta dalla sua forza, gratificata dal suo amore incondizionato, dal suo magnetismo, dalla sua dolcezza.
Pian piano iniziai a conoscere anche gli altri bambini, la maggior parte di loro chiusi in un guscio di dolore, o di rabbia. Li salutavo tutti chiamandoli per nome, mentre andavo da lei, in fondo a quel salone.
Bea mi cambiò. Mi regalò l’occasione di fare un passo oltre i miei confini per entrare in un mondo diverso, separato dal mio da una membrana di dolore e di difficoltà. Agganciata alla sua mano fredda, alle sue dita contratte, imparai a sporgermi al di là di quella membrana, a non avere paura delle persone diverse da me, a cercare altri modi di comunicare oltre alle parole, a usare tutti i sensi a mia disposizione per sintonizzarmi con gli altri.
Se la cerco nella memoria, oltre alla sua bellezza un po’ selvaggia, sento il suo profumo. Mia mamma diceva sempre che a differenza di altri ragazzini un po’ trascurati lei era sempre in ordine, ben lavata e curata. Ma quello di Bea non era profumo di sapone o di shampoo.
Non profumava così nessun altro ragazzino in quella scuola speciale, non la bella Fabienne, del tutto inconsapevole di essere vestita con abiti firmati, non Antonio, cieco dalla nascita e con le mani sempre a pasticciarsi le parti intime, non Gino, afflitto dalla distrofia muscolare e rapito dal suono di una parola nuova che ogni giorno ripeteva come un mantra, non Maurizio, il ragazzo baffuto che avevo sentito lamentarsi il primo giorno e tutti gli altri in cui lo vidi.
Bea aveva un odore chiaro, una nota alta, un misto tra il profumo che hanno i cuccioli e quello dell’aria ad alta quota. Lo sento ancora, se mi concentro la percepisco ancora vicino a me.
Ma se cerco altro, di lei, ecco che arriva lo sconforto.
Mi sento come quando si perde qualcosa di prezioso per incuria e dabbenaggine.
Cerco l’ultima volta che ho visto Bea, un momento di saluto, e non lo trovo.
Metto insieme pezzi di ricordi per ricostruire i fatti: so che mia mamma alla fine di quell’anno scolastico venne richiamata alle elementari e accettò subito l’incarico. So che dopo l’esame di terza media andai in crisi e passai l’estate ombrosa e immusonita, senza amiche né cugini, perché i miei avevano venduto la casa al mare. So che poi andai al liceo classico e che fu molto dura per me ingranare con il greco, e che i miei pomeriggi divennero infinite maratone di studio in cui annaspavo da un’interrogazione all’altra con la sensazione permanente di non farcela.
Nessuno di questi motivi ai miei occhi di adulta però dà un senso al fatto che io mi scordai di Bea, delle sue mani e del suo profumo di creatura magica, con la leggerezza incosciente con cui i ragazzini dimenticano le cose importanti.