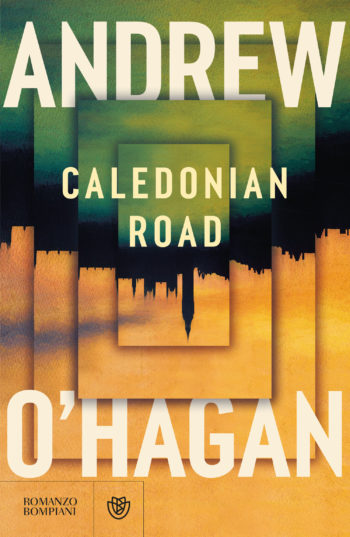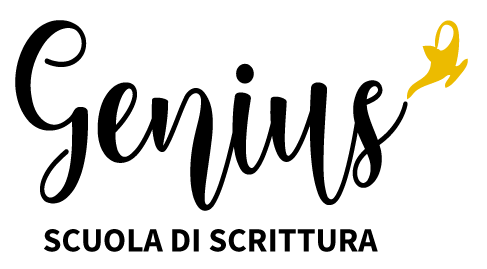MOBBING
Due atti irregolari con possibile via di fuga
Più delle voci del bilancio
mi preoccupano quelle dei colleghi
in pausa pranzo o quando dall’ufficio manco.
***
Come al liceo le ore di studio non mi hanno liberato
dalle maldicenze e dalle prepotenze
che anche qui in ufficio si ripropongono
come di sera i peperoni imbottiti al forno.
Il bullismo non è un fatto adolescenziale
e non muore al compimento dei diciott’anni.
È una costante di notti bianche e di malanni,
di valori inversi e inganni.
Il bullismo si trasforma in questa parola inglese
che si dice “mobbing”
e che nessuno si prende la briga di tradurre
forse per paura che qualcuno la riconosca
e si metta in testa di annientare.
***
La consapevolezza a volte si paga
ma a pensarci bene
è uno sforzo sostenibile, anzi necessario.
Penso allo sforzo di una madre in sala parto
e a una nuova vita che nasce.
Alla speranza e alla vita,
a questo penso. A questo dobbiamo pensare.
Solo questo deve interessarci. Tagliare il cordone ombelicale,
liberarci. Dopo infinite lacrime, imparare a respirare.
Uno dei sintomi ricorrenti in EPICA QUOTIDIANA, sostanziale esordio nella poesia di Ilaria Grasso, è la spasmodica ricerca d’aria di contro al regolamentare stato di soffocamento, una specie di liberazione da ricorrenti crisi d’asma in un ambiente malsano e asfittico. Quest’ultimo è il mondo in cui viviamo, la camera a gas che ci siamo costruiti, in cui agenti di costrizione sono il lavoro e l’economia, e la kafkiana parcellizzazione e ripartizione del nostro ambiente che non fa che tirar su diaframmi di plexiglas (ogni riferimento è voluto, anzi gridato) per cui ci guardiamo, forse ci vediamo, di sicuro non ci parliamo e non ci capiamo, né ci comprendiamo in senso letterale ma ci manchiamo clamorosamente.
“Un uomo che, superati i ventisei anni d’età,
si trova in autobus può considerarsi un fallito.
(M. Thatcher)
Questo è l’esergo della sezione “In itinere”, da cui riporto un paio di passaggi:
In autobus al mattino la gente stanca
sale per andare a guadagnarsi il pane.
Avanziamo isolati dai vetri di una bottiglia
traboccante di una moltitudine di disperati.
Ogni tanto dai rami lungo i viali
scorgiamo bianche nuvole e raggi di sole
e riprendiamo a respirare.
***
Eppure sono tanti i poeti che mandano avanti il Paese.
Lavorano in ufficio o chissà dove
per il mutuo o per pagare le spese.
Vi ascoltano lo stesso nonostante le preoccupazioni.
Scrivono sul cellulare o su pezzi di carta di fortuna
nel centro di una piazza affollata o al capolinea dei mezzi.
Talvolta anche da lì un’ispirazione parte.
Va detto che questa seconda sezione del libro inaugura anche un cambio di passo rispetto alla sezione di apertura, “Le gesta dei padri”, che rispetto all’impianto del libro funziona come una sorta di proemio, capace di conferire a EPICA QUOTIDIANA una sua saggezza classica – una classicità strutturale che non è smontata neppure dalla natura protestataria di questa scrittura in versi. Tuttavia vorrei qui intanto mettere in evidenza che al/la navigato/a lettore/lettrice subito si configurano nella mente una serie di rimandi precisi sollecitati proprio dalla frase della Thatcher: affiorano da un lato il classismo ipocrita ben descritto da Forster in Howards End (l’amicizia impossibile tra due giovani di classi diverse lasciata ambiguamente emergere in una occasione cultural mondana, un incontro pubblico di lettura), dall’altro, l’epopea degli impiegati raccontata da David Foster (senza la R centrale) Wallace in The Pale King – Il re pallido.
Il libro EPICA QUOTIDIANA compie un tragitto: Ilaria Grasso parte con l’esposizione della compagine dei propri (numi tute)lari, autori consolidati nella nostra tradizione (tra loro anche Rocco Scotellaro, Paolo Volponi, Luciano Bianciardi, e altri) e poi si incammina per la propria strada. Sposta la bussola del proprio “fare poesia” verso un senso e una funzione civile in senso stretto.
Arroccata sul sedile mi tengo stretta di lato
la borsa quasi fosse un fucile.
Siete lì in piedi come arbusti
e ogni frenata prova ad abbattervi
come una raffica di vento.
Ma siete così stretti che non riesco
a distinguere tronco e rami.
Solo al capolinea ogni pianta
riprende il suo spazio vitale e ogni giorno
questo rituale agli occhi miei appare
sempre diverso e sempre uguale.
***
In autobus alle nove di sera
vi ascolto anche se non vi conosco.
Siamo vicini come su un divano
eppure tra noi nemmeno uno sguardo
neppure per sbaglio durante tutto il viaggio.
Poi un suono dice che siamo a casa
ma ancora non riconosciamo le pareti.
Mi accendo una sigaretta
e avanzo a passo svelto per la strada.
Ho ancora i vostri occhi davanti
come i miei stanchi.
Il distico è spesso una formulazione adottata da Ilaria Grasso, a volte risorsa epigrammatica a sé:
DISTICO DEL LAVORO
Il lavoro manca / anche quando manca.
DISTICO DEL PIAGNISTEO
Le lacrime prima di fottere valgono zero. / Quelle dopo ancora meno.
Non si limita, Ilaria Grasso, a porsi come temi di questo poetare, e del proprio dettato (come meglio dirò dopo), figure e condizioni del nostro vivere di occidentali organizzati e raffinati sadomasochisti, ma li mette in scena, li fa agire e parlare come attori di un dramma penoso in cui emerge spietata la natura ingiusta e insanabile del nostro malvivere.
Questa poesia mette all’opera tutto lo strumentario della scrittura poetica, lavorando anche sulla lingua e i linguaggi e forgiando titoli ironici e amari (“Il mattino ha il Tavor Oro in bocca”, oppure “Partorita IVA”) o che giocano con echi da altre voci poetiche (“Variazioni aziendali” è ricalcato su “Variazioni Belliche”), lo spiega bene Aldo Nove nella Prefazione. Ma anche quello stesso strumentario è messo in discussione. Spesso (ed è un tratto preciso) nella versificazione irrompe la prosaicità quotidiana, e la lingua si infesta di linguaggi del lavoro e dell’economia, o del sindacalismo [nella sezione “Memento” la denuncia senza peli sulla lingua di un colossale tradimento consiste nella riscrittura della Costituzione: è]: altrettanti strali frattali che impazzano nelle nostre vite e le scompaginano, conculcandoci fin nell’interiorità. Ed è là che sono di fatto distrutti i diritti fondamentali, soprattutto della persona, che non debba solo far numero o prestare solo il proprio paio di braccia al pervasivo lavoro e alla pervasiva economia incombente.
Ilaria Grasso pone in discussione una questione di fondo anche sul lavoro su poesia e scrittura:
quanto quello strumentario, variato e funzionale, consistente e necessario, talvolta tendente ad allungarsi anche nella prosa, sia poi strumento di testimonianza e denuncia, e in ultima analisi di verità; quanto cioè la scrittura, ancor più la scrittura poetica, non indulga in vuoto madrigalismo, ma parli in faccia al potere, mostro subdolo dalle mille facce, capace di ridurci non di rado a suoi complici persino contro noi stessi.
Allora è chiaro, partiamo da una specie di proemio, in cui sfilano quei Maestri del Novecento nei cui versi Ilaria Grasso coglie proprio quel seme della rivolta giusta (tra Camus e Chiaromonte), potente vibrata e ironica – anche elegante, sì, ma poi la sfilata dei Maestri è soppiantata, ai nostri giorni, dalla sfilata delle slides nei webinar di formazione e aggiornamento dei lavoratori in smart working e con un fulmineo click ci fa guadagnare l’attestato, il quale in un attimo risolve il nostro zoppicante status di ex-cittadini, ormai solo lavoratori, di fatto schiavi con una ipocrita facciata sociale da mostrare come decoro esteriore.
Questa poesia spacca la lastra del decoro di vittoriana memoria e mostra senza veli come malviviamo.
Ingorgo
Qui da dove scrivo la notte è uno schianto di vuoto.
Non conosciamo stelle, solo smog e pali della luce.
Ci comprimono ad arte alla maniera di Arman
tra pilastri di cemento gomme e incrostazioni.
Siamo fluire di carne snervata e non abbiamo nome.
Siamo massa che avanza.
Ogni tanto un incidente prova a rompere le righe
di questo schieramento quotidiano.
La processione avanza sempre nelle stesse direzioni
tra canini d’acciaio e il guarire dei motori.
Anche in tangenziale, sempre in mezzo al niente affollati.
Inutile negare che ci tornano in mente due film: L’ingorgo ma soprattutto, prepotentemente, Fellini 8½: il sogno iniziale che è la favola onirica di un soffocamento, di un’asfissia. Ecco, anche il sogno è negato a tutti noi, affogati nel lavoro, nell’arrembaggio quotidiano, nella corsa a scavalcare tutto ciò che ci distrae da noi stressi, come emerge pure nella miseria di uno dei miserabili irredimibili di questa EPICA QUOTIDIANA, “L’evasore fiscale”, “Ma io dormo beato. / Fino a quando mia moglie e lo Stato non mi scoprono / non sono passibile di niente e non esiste reato.” – come a dire, “nulla si sa dunque nulla esiste”, filosofia (dell’evasore) diversa dal noto aforisma felliniano, “nulla si sa, tutto si immagina”. Questi i veri guasti del cieco progresso senza vero sviluppo, di pasoliniana profezia.
Foto di Andrea Annessi Mecci