Nessun prodotto nel carrello.

Dentro la lampada
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

Maria Clelia Cardona, viterbese di stanza a Roma, ha alle spalle una lunga traccia di titoli e raccolte che spaziano tra opere di narrativa traduzioni e sillogi, tuttavia a mio parere la delicatezza del tocco che emerge dal dettato delle sue pagine ci obbliga a pensarla soprattutto poeta. Non per la rinuncia a raccontare ma per il fitto lavoro sulle immagini e le figure, e su una potenza espressiva che sceglie la sintesi della scrittura poetica e affida al dettato poetico la densità di esperienze di vita e di letteratura come filtro e registro storico.
In questo I Giorni Della Merla – la raccolta di versi più recente, col corredo dei risvolti di copertina a cura di Giancarlo Pontiggia e di una postfazione di Marco Vitale – la molla scatta nel capodanno del 2000, momento cardine in cui il colloquio con la madre è il principio del punto di distanza-
[…]
Ai vetri batte il cedro del giardino
gigante a pelo irto incatenato di natalizie luminarie.
Tuo compagno
affidato dal caso ai giorni del silenzio,
di immobile pena, al tuo
sguardo fisso e impaurito – clown celeste
agita davanti a te i suoi stracci.
[…]
-e la memoria dei capodanni del passato non è solo un’infilata di ricordi casalinghi e familiari ma diventa il modo di innestare la propria storia in una tradizione cara che vince ogni reticenza ed estraneità, a dimostrazione del fatto anche che la classicità a cui la Cardona si rivolge ha già dentro di sé tutte le immagini di cui abbiamo bisogno per raccontare un/IL destino,
[…]
Forse il labirinto è la vita
e qui siamo dove la bestia
umana si nasconde e già so
non c’è alcuna uscita.,
Alla fine ti trovo, dimenticata nel tuo sonno
in un’incongrua corsia di vecchie picchiate
e nessuno lo dice che stai morendo, lo dice
il tuo essere così sola, con il viso girato verso il muro.
In questa sera di febbraio,
cinque gradi sottozero, di quello che eri non resta
che un codice rosso, il filo della flebo intrecciato
al filo delle Parche.
Questa tessitura che incorpora filamenti naturali e fili classici o della tradizione è una trama di parole. In essa, senza soggezione né verso l’esperienza e la vita (con le prove che ne derivano e con la naturale pietà destata in noi da tutti gli esseri fragili e tenaci in cui ci imbattiamo, e a cui dobbiamo rispetto cura e carezze), e senza intimorita deferenza per i Maestri che ci hanno aperto la strada nel solco dei versi, il segno più libero e franco risiede nell’invenzione lessicale,
[…] –eppure
ha inteporito del suo canto l’aria gelata […]
o ancora, […] la solidale intervita […]
Dunque dopo una serie di voli radenti tra gatti di casa e parrocchetti e gerani e begonie e poi cicale e farfalle e grilli e lucciole, spunta l’autoritratto come Arianna Senza Filo, sezione in cui l’autrice si colloca, punto mediano, in una fitta rete di classici, e qui ovunque si volti si ritrova circondata da Catullo e Orazio, e si incarna nella Sibilla ragazza e in Arianna che ha smarrito il filo appunto, e poi stabilisce la fratellanza con Leopardi a mezzo della luna per finire a sostare dalle parti di Ezra Pound e di T S Eliot passando com’è naturale per Dante e finendo a rivolgersi a Pier Paolo Pasolini. Ma tutto questo non è sfoggio di poesia del passato – diventa invece indagine, anzi rivelazione, dello stato della poesia attuale e di come agisca la poesia nella vocativa immaginazione del poeta. Lo lascio dire ai versi:
[…]
Non posso non pensare, poesia, che spunti
come un’ortica di città. Non hai destino
e un lieve eczema è divenuta tua carezza.
Ora il nostro è un amore svogliato- […]
[…]
Vedi, qui nasce tutto e tutto muore,
ma forse ci troveremo in altra vita
quando mi avrai dimenticata e io
avrò perso ogni traccia di te.
Svociate entrambe, per aver troppo
Parlato.
[…]
Ti vedo, poesia […]
[…] un angelico affondo– […]
[…]
E pensare che tutto è cominciato
in una notte di primavera mentre vaghi
servi d’amore gemevano
al suono del liuto e gli sguardi
si incrociavano con lieta
sventatezza. I passi allora
ti portarono altrove.
Da questo ultimo stralcio non cogliamo soltanto un destino di esilio (scelto da Dante, a cui questi versi sono rivolti): qui ci viene anche rivelato come nasce la poesia, come essa deragli dalla realtà immediata e trovi il luogo della finzione che è descrizione per figure, proiezione di immagini, ricreazione per simboli. Ma non si pensi, nel caso di Maria Clelia Cardona, a un poeta separato dalla vita e ritorto su se stesso. Tutt’altro. Il poeta è ritratto mentre sguazza nella rete, si affida al volo digitale, cavalca algoritmi, pascola negli ebook, e interroga il virtuale: Chissà dov’è acquattato il Minotauro del web? […] Lui partorito da una vacca meccanica […], e noi, mungitori smaliziati del patrimonio letterario, pensiamo subito alle pecore elettriche di Philip K. Dick. La poesia di Maria Clelia Cardona è una poesia che osserva con stupore la vita in tutte le sue forme, soprattutto le forme bizzarre o ignote o inspiegabili, meglio se (e quando) elusive – e registra l’amaro sconforto del pur risibile e irrisorio sapere con cui proviamo a colmare il mistero senza soluzione delle vie varie, plurime, che la vita sceglie e solo a volte ci sottopone. È una poesia che appare vissuta (dunque ci è indicata) come gioia: cioè come gemma e come felicità – come custode di gemme che non lasciamo mai andare, come in certe memorie di Erbari sull’esempio di Emily Dickinson o nella cura dei giardini come ci ha insegnato col proprio esempio Pia Pera. Registriamo dopotutto, come macro-figura, un cerchio, l’idea di una circolarità, che ci è confermata da quel finale LAMPO DEL BIG BANG in cui la fine non è altro se non l’auspicio di un ritorno al vero, grande inizio di tutto.
L’ultimo dato, umano, è registrato in una immagine-chiave: il sapiens sapiens avanza, progredisce!, col VISO GIRATO VERSO IL MURO (il poemetto iniziale), indizio e segno anche di una versificazione della dislocazione.

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
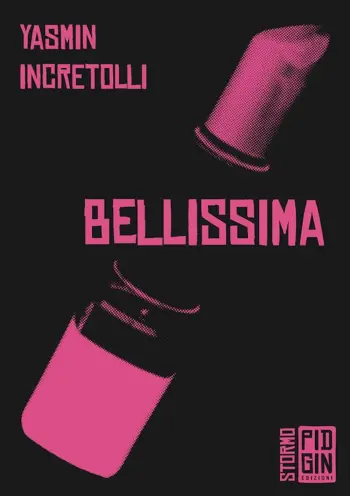
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare