Nessun prodotto nel carrello.

Dentro la lampada
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

Scrivere significa farsi trascinare una seconda volta dall’esperienza; significa anche assaporarla. In una ripetizione di questo tipo c’è il tempo di gustare la vita in tutta la sua complessità e impegnarsi in essa. L’esperienza non si ferma. Se l’io viene formato in parte dai colpi, dalle ferite e dai segni inferti dal mondo, allora la scrittura è una sorta di auto-guarigione.
Kureishi Hanif, Da dove vengono le storie? Bompiani, Milano, 1999, pag 38/39
Amo Kureishi, lo ammetto. Le ragioni sono tante, anche se per amare non si dovrebbe ricorrere a ragioni. Allora dico così: amo Kureishi per il suo rimandarmi come in uno specchio tutto ciò che io credo debba e possa essere la scrittura. Un modo per riassaporare l’esperienza, ad esempio: quella magia che si compie nel momento in cui recuperiamo avanzi di ciò che abbiamo vissuto per riutilizzarli e farne frasi di un racconto. Ed è nel momento in cui riviviamo esperienze vissute, e anzi diamo loro nuova luce e nuova forza, nel momento in cui riviviamo anche le ferite e i colpi subiti, che iniziamo a guarire da quei colpi e quelle ferite. È il potere taumaturgico della scrittura. Mettiamo fisicamente fuori di noi il dolore e la rabbia e la disillusione e tutto quanto ci teneva inchiodati ad una visione di noi stessi e della nostra vita che avevamo pensato immutabile e irredimibile, lo mettiamo fuori e mentre lo facciamo la nostra vita viene redenta. Una volta dissepolte e affrontate e portate alla luce, quelle emozioni perdono forza. Come l’elio dentro un palloncino abbandonato al sole.

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
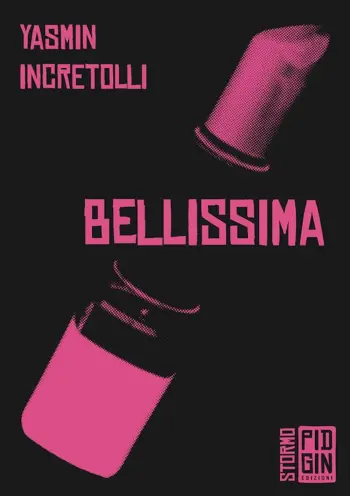
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare