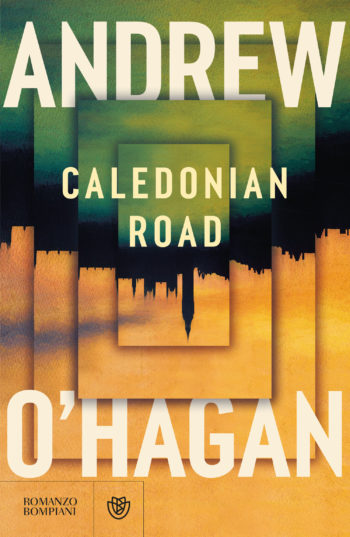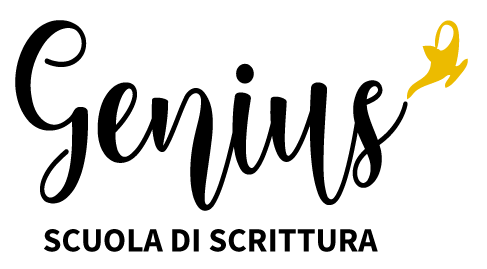Ho conosciuto Marco Roncaccia diversi anni fa in un laboratorio di scrittura creativa (ci potete vedere nella foto qui sopra in una presentazione con Manuela D’Aguanno). Lui stava scrivendo una storia fantastica, sia nel senso che era di genere fantastico e sia nel senso che era proprio forte. Il suo Roma Caput Zombie, che venne pubblicato da Nero Press, era infatti una storia di morti viventi e mondo del sociale, che nell’ambientazione, nei colori e nei temi anticipava un film di successo, Lo chiamavano Jeeg Robot. Roncaccia poi ha continuato a scrivere (una raccolta intitolata Nero ristretto pubblicata da Alter Ego) e a organizzare attività culturali. Adesso è tornato in libreria con un volume pubblicato da Fuorilinea e mi è sembrato il momento giusto per scambiare con lui due chiacchiere sulla scrittura e gli scrittori.
Storie di uno che voleva scrivere storie sembra una sorta di distopia, una bizzarra autobiografia fantastica ma anche un manuale di sopravvivenza per aspiranti scrittori, come ti è venuto in mente di scrivere un testo così inconsueto?
Il progetto è nato con Franco Esposito, di Fuorilinea edizioni, mi ha detto scherzando: «Visto che insegni agli altri a scrivere, se scrivi un manuale te lo pubblico». Io gli ho risposto: «Io scrivo narrativa, non manuali» e lui «Bravo, allora raccontaci della scrittura».
Quali sono stati i tuoi riferimenti letterari?
I primi che mi vengono in mente, sono: I ferri del mestiere di Fruttero e Lucentini, On writing di Stephen King e Parola di Chandler di Chandler, Veronesi e Igort.
Tra i tanti personaggi che popolano le pagine di questa storia, o insieme di storie, c’è qualcuno che ti somiglia più di altri, oppure sei sempre tutti tu?
No, non sono sempre io, da un po’ di tempo organizzo insieme a Sonia Lippi e Cristina Blasetti presentazioni di libri in un pub di Monterotondo. Abbiamo ideato Ztoryboard che è una modalità leggera e orientata al cazzeggio di invitare alla lettura chi si sta bevendo una birra la sera. L’incontro con molti scrittori mi fornisce un sacco di materiale. Forse il personaggio che mi somiglia di più è quello che scopre di avere un Daimon che somiglia a Berlusconi
A un certo punto scrivi: “Col tempo mi sono convinto che io, Marco Roncaccia, sono una specie di avatar”. Secondo te è questo il narratore, sempre più inaffidabile, un avatar, cioè un doppio virtuale della persona che si ritrova a essere l’autore?
Credo che in questi tempi di grande confusione editoriale caratterizzati da chi si autopubblica, da chi paga per pubblicare, da chi ottiene contratti editoriali in funzione del numero di follower, da chi scrive accanto al suo nome sui profili social la parola “scrittore”, l’autore sia in piena crisi di identità, il focus non sono più le storie che racconta ma quanto verosimilmente riesce a interpretare nel look, negli atteggiamenti, nei social media, un personaggio. Si è costretti a costruire una narrazione da cui si evince che il protagonista è uno scrittore, un vero scrittore, un grande scrittore. È necessario convincere di questo gli altri e prima di loro se stessi.
Una parte del testo è dedicata a una serie di racconti sull’apprendimento della scrittura e alle scuole di scrittura, pensi che senza la frequentazione di una scuola avresti scritto lo stesso?
Prima della scuola di scrittura scrivevo, ma nessuno capiva quello che volevo dire. La scuola mi ha aiutato a cercare (e trovare) una sintonia col lettore e a sviluppare uno stile riconoscibile.
Parli anche della vita da scrittore, la tua com’è?
È dura. Come si dice nel libro. È complicato trovare il tempo e la disposizione d’animo per scrivere, è complicato trovare un editore, è complicato promuovere e far conoscere i propri libri. è complicato dover gestire tutte queste cose e allo stesso tempo riuscire portare il famoso piatto di minestra a casa lavorando in altri campi. A volte la frustrazione supera il piacere. Però alla fine ti rendi conto che non puoi fare a meno della scrittura e che quando sei lì davanti al computer o a un foglio, tutto il resto sparisce dietro un incipit.
In fondo il tuo libro è soprattutto una satira della letteratura e dell’editoria, da dove nasce questo sguardo ironico? Essere diventato uno scrittore pubblicato ti ha insegnato qualcosa di buffo?
L’esser pubblicato è solo l’accesso alla tana del Bianconiglio. Rendere buffo ciò che è frustrante, deprimente e sconcertante è una strategia di sopravvivenza.
C’è un capitolo molto divertente “Facilmente edibile” in cui chi scrive commette molti terribili svarioni (e non racconto il resto). Vuoi dire che sono molti a scrivere senza conoscere nemmeno le basi minime del mestiere?
Sì e ne ho le prove! Mi sono capitati per le mani testi da far venire l’orticaria. Sembrerebbe che l’editing non sia più di moda. E non parlo solo delle auto pubblicazioni o dell’editoria a pagamento. A volte il mostro lo partorisce anche la grande casa editrice.
Giochi con la morte, la vita, i massimi sistemi, addirittura Dio, che in fondo è il primo scrittore… cos’hai capito dell’esistenza?
Che focalizzarsi troppo sul capire sottrae energia all’esistere. Che più lo cerchi, più il senso sfugge, che ci sono attimi in cui tutto diventa chiaro, poi, però, la birra finisce.
Ultima domanda: ma le gru?
Ce n’è una fantastica sulla copertina del libro, opera di un grande artista e artigiano mezzo calabrese e mezzo argentino: Giuseppe Seminara. È stato anche lui risucchiato dal tormentone “Gru” che ho lanciato sulla mia pagina facebook un paio di anni fa e, visto che casa sua non affaccia come la mia sul cantiere dove sorge quella incredibile opera dell’ingegno umano, è stato costretto a disegnarla.