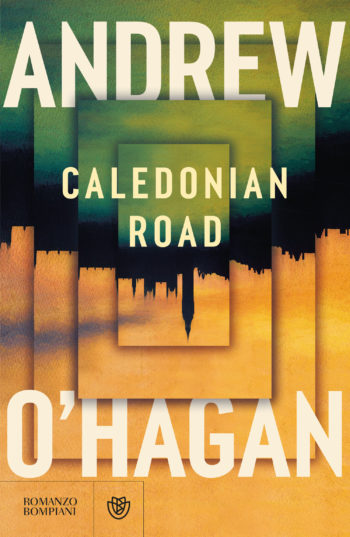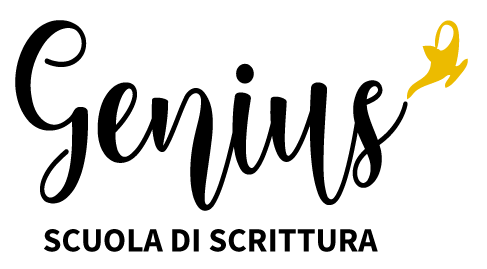Ancora non scrivevi di banca direttamente, però catalogavi tutto sul taccuino o in file d’appoggio che disseminavi nella memoria di dischetti privi di targhetta che ti pesavano nelle tasche della giacca, non più quelli flessibili e sottili e grandi di alcuni anni prima, oggi erano da 3½ pollici, più piccoli di una mano e rivestiti di plastica rigida, anche se continuavano a chiamarsi floppy-disk. Tu ne avevi sempre due o tre in tasca e ogni sera alle 16.55 minuto più minuto meno, cioè immediatamente prima di timbrare l’uscita, ci salvavi i tuoi lavori sopra, fregandotene se quella attività potesse apparire sospetta ai colleghi di stanza. Contavi sul fatto che nessuno si azzardasse a chiedere. In quei depositi viaggianti di dati ci finivano ritratti fisici, psicologici, frasi, epiteti, brevi descrizioni di ambienti, bozzetti che poi ti giocavi altrove, decontestualizzati, regrediti socialmente, come volevi tu. A quell’epoca ti attiravano gli umili anche se tu umile non eri mai stato! E non eri neppure buono, se è per questo. Forse del destino degli umili, e degli ultimi, davvero, in fondo, non ti importava molto, avevano ragione i tuoi vecchi amici che deridevano il tuo marxismo in pantofole, o qualcosa di simile (a quei tempi non esisteva ancora l’espressione radical-chic, te l’avrebbero addossata lussuriosamente anni dopo). La banca comunque era già una fonte di materia narrativa bruta, grezza, bastava saperla osservare e leggere. Non soltanto in senso regressivo. Ma no, era un mondo, la banca, c’era il bello e il brutto, lo sconcio e il sublime, il medio e l’estremo! E tu prendevi nota.
C’era il gay che si fingeva etero, spingendo la simulazione fino al punto di ridere alla battute sessiste dei colleghi. C’era quello che un bel giorno, senza aver mai fino a quel momento dato segni di squilibrio, davanti alle erogatrici dei caffè cominciò a stendere sul pavimento una lunga striscia di carta igienica, un nastro bianco che spiccava sul linoleum nero, per una demarcazione che soltanto alcuni colleghi potevano oltrepassare, quelli della Contabilità se ben ricordi – o dell’Ufficio Titoli, o quelli del Recupero Crediti, mentre era interdetto assolutamente a voi del Ced, secondo le sue disposizioni, ch’egli faceva rispettare con una specie di frustino da cavallerizzo, proprio così, non sono balle, che schioccava sull’uno o sull’altro, gridando come un pazzo, da soldato nazista, da invasato, Dove cazzo vai tu Pancrazi? Tu sei dall’altra parte, no perdio non è lo stesso! E c’era chi zompava dall’uno all’altro spazio per vederlo dar fuori di matto, te compreso! Da quel giorno in poi, i suoi nastri di carta igienica cominciarono ad apparire dappertutto, e già c’era un ragazzo dei trasporti incaricato di raccogliere e buttare quelle sue immaginarie demarcazioni. (Oggi quel tipo è un noto influencer molto attivo sui social).
C’era quell’altro che andava a pisciare col casco per risparmiare tempo: quando si avvicinava la pausa pranzo, – forse un quarto d’ora prima – infilava il caschetto senza allacciarlo, coi due lembi di fibbia penzoloni, e cominciava a smaniare dietro la scrivania, si alzava e si sedeva – quell’omino scheletrico e sfessato dal diabete, dall’alcol, dal fumo compulsivo, la cicca sempre accesa sul taglio sbieco e quasi invisibile delle labbra, a controllarsi le tasche cento volte, pronto a schizzare a casa in motorino per consumare, nei trenta minuti della pausa (con la restante mezz’ora ci copriva il ritardo del mattino), il pasto completo che una moglie-serva non mancava di allestirgli ogni giorno. Te la vedevi che lo accoglieva coi maccheroni fumanti sul pianerottolo.
C’era un perfido sordomuto che a casa aveva istallato telecamere nascoste per controllare la moglie adultera e al lavoro non faceva quasi nulla e recriminava su tutto. Un piantagrane incattivito dalla disabilità. Uno che conveniva evitare e invece ti ritrovavi sempre fra i piedi, e rincorreva follemente con te una complicità da reietti, da vessati, che ti ripugnava. Un giorno un collega più perfido di lui, quella carogna del Sorcio, un soggetto di cui parleremo anche troppo, lo rinchiuse a chiave dall’esterno in un cesso lasciandolo per un’ora a strepitare al suo modo disarticolato e gutturale e a dare calci alla porta come un invasato. La scenetta avvenne in una sede distaccata, dove anche tu ormai lavoravi, durante la pausa pranzo, e al ritorno ritrovaste la porta del cesso sfondata dai suoi calci e lui accucciato in un angolo del bagno con l’aria stravolta.
C’erano una quantità di tipi qualunque, in banca, che a ben guardarli, sbalzandoli per un attimo dal mucchio indistinto, qualunque non erano, e avrebbero meritato di finire nel tuo catalogo anche solo in un cenno.