Nessun prodotto nel carrello.

Dentro la lampada
La Tarologa e lo Scrittore: DAI UN CALCIO ALLE REGOLE!
Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.

Il Quaderno di Nerina (presentato da Jhumpa Lahiri con la collaborazione di Verne Maggio – Quaderni della Fenice, Guanda, 2021)
Siamo al nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva (breve e corposa: il mese d’agosto)
e sarà il caso che ci lasciamo con un ragionamento condiviso intorno a un libro classico e curioso nello stesso tempo, attorno soprattutto a una proposta poetica intricata e rivelatoria come certi intrighi che classicamente leggeremmo spiaggiati all’ombra davanti al mare. Partiamo da qui:
IV.
Già raccontato con esito tragico
dei bracciali dimenticati a giugno
nella vaschetta a Fiumicino
prima di imbarcarsi.
In realtà è andata a buon fine
perciò credo in Roma:
gioielli ricuperati dalla bolgia,
spediti da un impiegato a Milano e riportati
con cura dalla mia prima traduttrice
italiana, lei che mi rendeva italiana,
in un marsupio attorno alla vita
mentre io ero incinta di mia figlia.
Della moneta senese
che abitava in un cassetto dietro le spalle
nello studio romano
preferisco non riparlare,
né del diamante
che ho regalato ai traslocatori
invitati alla casa di Brooklyn un sabato mattina
per portare giù un’altra scrivania più una libreria
dalla camera da letto al pianoterra,
sforzo proibito per Alberto
appena dimesso con l’impianto nel braccio:
accesso venoso in prossimità del cuore,
somministrazione di flebo complicatissima
tre volte al giorno,
pezzo duro tra di noi.
Lasciamo stare allora il rubino
dell’anello di fidanzamento
rapito dai golfini di mia madre,
cavato dai tentacoli di lana
mentre sistemavo il suo armadio,
anche l’orecchino tondo (uno solo)
caduto nel supermercato
a causa della maglia infilata per il gelo.
Altro orecchino con pietra verde rasserenante
l’ho perso credo su Viale Trastevere
mentre Francesca sistemava i miei capelli
incastrati
sotto la catenella degli occhiali, gesto intimo tra
amiche.
Ogni volta torna indietro, quando patisco
l’attimo in cui i gioielli si staccano
dal corpo.
Guardo il pavimento scolorito
in attesa di qualche scintilla.
Qui l’elemento più forte che si coglie è l’eleganza della persona, il rapporto prezioso con i monili, ci pare quasi di vedere una Dea Calì dalle molte braccia avvolte nei bracciali e dalle molte mani inanellate. Tornerà più avanti questo dettaglio della cura e dell’eleganza, delle movenze gentili, e si paleserà un oggetto, il portagioie, che non è importante per il valore venale di ciò che conserva ma per la gelosa tutela delle gioie e per il fatto di custodirle, dunque di liberarle quando sarà aperto.
Questa quarta strofa proviene dalla sequenza Sparizioni in quattro parti all’interno di EVOCAZIONI, secondo dei sette “capitoli” in cui consiste il vero e proprio Quaderno di Nerina, ritrovamento di un corpus di versi, come spiega in apertura di libro la stessa proponente, Jhumpa Lahiri, in un mobile della sala da pranzo nella casa di Trastevere dove la scrittrice abita quando è a Roma. A corredo troviamo anche uno scritto della filologa, Verne Maggio, evidentemente italoamericana, consultata da Jhumpa Lahiri negli Stati Uniti dove la nostra insegna scrittura (a Princeton, mondo linguistico, culturale e universitario cui appartiene e da cui proviene, unitamente alle radici familiari bengalesi). Di cosa entrambe si sono occupate, depositandone il risultato in questo originale oggetto editoriale? Di un quaderno fisicamente descritto: un Monocromo Pigna formato 15 x 20,3 cm di 50 pagine, ci informa nella sua Nota la filologa, PhD e docente a Bryn Mawr, Pennsylvania datata 4.02.2020 – da Jhumpa Lahiri, in un recente incontro al MAXXI romano, unica presentazione del libro finora, abbiamo appreso che sui destini del libro (oltre a tutto il pregresso che è il vero oggetto dei versi raccolti nel libro) ha inciso la pandemia: era già pronto a giugno 2020 ma ha dovuto attendere una “forbice” temporale migliore, esattamente un anno dopo, ora, poco fa, giugno 2021.
Dunque, a che punto siamo?
Ecco, aprendo il libro troviamo la prefazione di Jhumpa Lahiri, la Ipotesi per una cronistoria della filologa italoamericana Verne Maggio che ci dice di aver ri-organizzato il testo arbitrariamente, di aver creato lei i capitoli e la disposizione dei brani interna a ciascuno di essi, e di aver anche trovato una cosiddetta ipotesi di titolo in un appunto volante del seguente tenore: peripezie favelle perituro. Poi entriamo nel vero e proprio Quaderno, il testo composito e articolato concepito, o, continuando a credere a quanto ci viene presentato, forse accumulato nel tempo, e anche dimenticato nei cassetti, lasciato lì a futura memoria, e a propria dismemoria, dall’autrice dei versi: Nerina.
Ci viene anche fornita la probabile accensione della memoria/dismemoria di Nerina, in un pugno di versi di Eugenio Montale:
Poiché la vita fugge
e chi tenta di ricacciarla indietro
rientra nel gomitolo primigenio,
dove potremo occultare, se tentiamo
con rudimenti o peggio di sopravvivere,
gli oggetti che ci parvero
non peritura parte di noi stessi?
Una volta da noi
si fermava tutto
se un raggio di sole
beccava un mio gioiello,
o l’anello o l’orologio
proiettando alla parete
un pianeta tremolante.
Se sbalzava e zigzagava
scatenato per la stanza
i ragazzi gridavano di gioia
impazziti tanto quanto
quel fenomeno transitorio.
***
Il quaderno in cui mia madre
scriveva i suoi versi bengalesi
aveva una copertina gialla (23) e
abitava accanto al suo letto finché
una volta, ispirata, non lo trovava più.
Si rammaricava della sbadataggine,
anch’io sotto sotto non l’ho perdonata,
ci tenevo a sentire quelle poesie
in cui capivo tre parole
insieme a tutte le viscere.
Si è arresa al demonio
che sposta le nostre cose
come gli pare
ma poi un giorno
mi ha chiamata eccitata.
È stato mio padre a recuperarlo
Nello studio sotterraneo,
senza neanche cercarlo.
Scantinato antipatico
dedicato ai libri respinti,
purgatorio mesto e umido.
Lì scendevo sempre con terrore,
troppo disordine, troppo passato.
Una volta, incinta, in cerca di chissà cosa
ho sbattuto la mano destra
contro una scheggia di vetro
ed è spuntato l’osso
a causa di un contenitore rotto
costruito per trasportare
una scultura dedicata a Calcutta,
mai buttato via per pigrizia.
Sopra la nocca
resta la ferita.
In quella Colchide
mio padre fu un eroe
conquistando un oggetto sacro,
superando le prove,
atto che declino
in quanto affetto.
***
[…]
Garage difettosamente stretto: manovra ostica e
proibita che sapeva fare solo lui.
A cinquant’anni lo sfido senza graffiare lo
sportello o storcere lo specchietto.
Schiaccio però con la gomma sinistra una latta di
vernice, rossa.
Era appoggiata ai margini di quel vano angusto. Si
forma una pozzanghera.
La tinta cruenta chiazza la gomma, lascia
un’impronta sulla pece.
Massacro ambientato direttamente sotto il divano
su cui mia madre grondava sangue.
Faccio del mio meglio per levare le tracce
a quattro zampe come un cane, come
Clitennestra.
I brani riportati qui sopra sono tutti tratti dalla sezione (o capitolo) GENERAZIONI, e, per non perdere certe mie inveterate abitudini, sono stati riportati in ordine inverso rispetto alla loro impaginazione nel libro – quindi anche io, come Verne Maggio ho riarrangiato il manoscritto, l’ho capovolto, chissà se riportandolo all’ordine originario dell’autrice: sempre che–. Le osservazioni da fare sono molte, e, anche se sembreranno dimentiche del vero obiettivo del discorso, in realtà scomodano alcuni mattoncini fondamentali della acuta, ingegneristica quasi, di sicuro geniale, costruzione e più congrua interpretazione di questo libro – che è un’opera.
Restando alle sollecitazioni che riceviamo qui:
La versificazione, come si vede forse meglio proprio in GENERAZIONI, è … in prosa: l’andamento non è metrico o rimato e anche il ritmo tende più ad accomodarsi lungo che a scandire secco, anche se un istituto tipicamente poetico come l’allitterazione qui non viene disdegnato ma la sua presenza si somma a una serie d’altri artifici (definiamoli così), cioè risorse retoriche, come i calembours, le sciarade, le crasi, gli anagrammi. I refusi e le imperfezioni, che pure affiorano, non sono strascichi incontrollati dell’uso dell’italiano scelto da una straniera o personalità multiculturale, quanto giochi semiologici, feritoie semantiche che aprono la lingua invece di chiuderla in una correttezza rigida.
“Cappelli”, con la doppia P quando dal contesto desumiamo che si parla di capelli, più che un errore è il transito tra possibilità di significato giostrando sui significanti, cioè rendendo compresenti due diversi sostantivi in cui il passaggio da un senso a un altro è tutto nello slittamento in una doppia, e il moto ondoso che provoca questa oscillazione è il vero punto d’interesse, il vero focus.
Questa polisemia come questione centrale, questa passione filologica, e l’attenzione alla scrittura come rivelazione delle molte anime acquisite dall’autrice in una miriade di esperienze di vita, sono definitivamente investite dal fervore con cui Jhumpa Lahiri ha stilato l’apparato di note che correda il corpus in versi del libro. Note costruite con competenza, anzi con compenetrazione, nella squisita questione linguistica, centrale, a ciò che capiamo leggendo i versi, sia nella Nerina presentata come la loro autrice che nella stessa Jhumpa Lahiri (entrambe consegnate all’italiano). Riporto un paio di note per dare conto anche dell’eleganza (anche qui) con cui sono redatte:
[…]
Ricordo di essere tornata a casa in macchina,
e di mio suocero appena vedovo che guidava
e di trovarci sempre in pianura in
«quelle ultime ore preziose
quando la tenebra
si disfa nell’alba»
(da pagina 59, ndr)
-del resto sappiamo bene (Nerina a parte: forse cominciate a capire, o no?) che Jhumpa Lahiri ha assunto come proprio patrimonio culturale la sterminata tradizione italiana, in prosa (cui ha dedicato The Penguin Book of Italian Short Stories – Racconti Italiani, Guanda 2019) come in versi, in una sorta di immersione totale che passa attraverso la lingua ma è nutrita di letteratura: d’altra parte, è proprio Jhumpa Lahiri, nella prefazione ai Racconti Italiani a chiedersi:
«A cosa serve, poi, la letteratura, se non ad accogliere chiunque abbia la curiosità e la voglia di affrontarla?»,ndr]
In effetti giallo e oro sono ricorrenti in questa opera costruita e articolata, composita in una parola, e anche questo è un elemento rivelativo. Azzardo la mia ipotesi che è una sensazione di lettrice: l’oro, il giallo, l’ocra sono i colori di Roma, la patria scelta da Jhumpa Lahiri e da Nerina come lei, la luce che quei colori conferiscono è il balsamo di una casa adottata con gioia, con identificazione somma. Roma l’ha accolta, e con Roma Jhumpa Lahiri intrattiene ormai una consolidata corrispondenza di amorosi sensi, e tutti i suoi libriGuanda, salvo i primi, non sono opere tradotte ma testi composti in italiano: altrettanti documenti di un’adozione reciproca.
Ma la vera rivelazione è un’altra.
Nerina e Verne Maggio sono altrettanti travestimenti di Jhumpa Lahiri in persona che riesce così a «guardare» sé stessa: a porsi come personalità multiculturale che abita almeno tre lingue, a narrare la miriade di esperienze di vita attraversate o osservate, a fare le pulci all’italiano d’adozione là dove nell’uso, nonostante un ipercontrollo tenuto saldo dall’amore, vede scapparle qualche errore o meglio qualche imperfezione – e questo innesca in lei un fanciullesco senso combinatorio di gioco. Jhumpa differisce sé stessa, triplica la propria azione creatrice ricorrendo alla risorsa romanzesca del ritrovamento del manoscritto, elemento manzoniano, e fa ancora di più: come fa David Foster Wallace in The Pale King, il quale inventa un passato da impiegato e ancor prima da ghost writer di tesi per altri per sorreggere l’immedesimazione nella grigia esistenza del ceto impiegatizio addetto al controllo fiscale sulla popolazione americana, così Jhumpa Lahiri crea Nerina e Verne Maggio: poeta autrice di un quaderni di versi che risorge tra masserizie e polvere facendone una fenice, e la esegeta corrispondente, la filologa che come una editor postuma sistema un’edizione del testo. Poi lascia a sé stessa il gusto, la goduria di ragionare sui testi, di chiosare i versi, di analizzare la lingua.
Come già nel caso di DFW, anche per Jhumpa Lahiri noi crediamo a lungo alla verità del testo, a una sua attendibilità realistica, la prendiamo per buona così come chi scrive ce la presenta e ce la lascia credere – siamo o non siamo lettori? Manteniamo o no la nostra suspension of disbelief?
Direte (forse protesterete): ma allora NON È Poesia?
Oh sì, lo è. Nella forma e nella sostanza. Il corpus fondamentale del libro è in versi e annotazioni, ed è anche messe di enunciati che costituiscono un diario, una confessione, un memoriale. Nerina, come affiora a un dato momento con la trascrizione dei versi leopardiani, è l’identità in cui, dopo il definitivo passaggio all’italiano (e a Roma), probabilmente la Jhumpa della vita precedente passa il testimone e lascia spazio alla nuova Jhumpa. Nerina è la donna dello schermo. È l’identità fittizia dietro cui Jhumpa può lasciare una pelle per indossare la nuova, una volta per tutte.
Questo libro È POESIA anche per la varietà del dettato: lunghe sequenze di racconto in versi, le folgorazioni definitorie del capitolo ACCEZIONI, gli infiniti richiami a molti topoi della tradizione e anche l’attenta formulazione delle etichette dei capitoli:
DAVANZALE
EVOCAZIONI
ACCEZIONI
DIMENTICANZE
GENERAZIONI
PEREGRINAZIONI
OSSERVAZIONI
– notiamo la pervasività della Z e la struttura (di nuovo: definitoria) prevalente in quei sostantivi, e la consonanza con FINZIONE / FINZIONI, più travestimenti che menzogne, e più acuta veridicità oltre che potenza di rivelazione. Il libro in versi di una narratrice, di una prosatrice raffinata, secca nella NOMINAZIONE, altro termine consonante, del mondo interiore ed esteriore, messi in vitale tensione e relazione reciproca. Dopotutto il «trucco» della letteratura sta tutto nella sensibilità linguistica.
Come sempre, una messe di finale versi riportati per il vostro piacere di leggere con i vostri occhi:
da ACCEZIONI,
«Aiuole»
Raccoglie
ogni vocale.
«Ambito»
Compaiano (27) uno
dopo l’altro
nel vocabolario.
Solo l’accento cambia il senso,
separa lo spazio
dal desiderio.
Nota 27: In questa sezione, il tasso di gioco linguistico
travestito da refuso o lapsus sale vertiginosamente. Qui
evidentemente «compaiano» è un calembour che combina
«comparire» con «paio» giacché il peso di omografi
«ambìto» e «àmbito» compaiono, appunto, di seguito
nel vocabolario [trattasi inoltre di crasi, ndr].
«Anafora»
Chiamo chi amo
con nome inventato
anziché anagrafico.
Codice segreto
tenuto stretto
per rendere mio
quel rapporto.
«Innesto» (29)
L’ozio nel mezzo dell’adozione.
Nota 29: Trovo questo componimento di un solo verso
alla fine del mio lavoro di curatela. Inizialmente mi pareva
un appunto, non una poesia: scritto con una penna doversa
pare a caso nel mezzo del quaderno, quasi nascondendosi.
Mi sembra opportuno innestarlo in questa sezione.
«Perché ‘P’iace»
Per poter(e)
pensare e parlare,
pendolare,
persino poetare.
Propria a Pessoa.
Lettera che punteggia
il titolo trittico di
Pier Paolo Pasolini.
Per Purgatorio giunto
e le sette P ne la fronte
di Dante;
Paradiso che proviene
dal pairidaeza persiano.
Purtroppo perturba e piange.
Patria mi pesa,
preferisco piazza, Porta
Portese e portagioie:
parola prediletta.
Peccato perdita.
Mentre la parola peripezia (34)
(preferibilmente al plurale)
che vuol dire mutare radicalmente
le cose
è sbarcata in italiano
nel Cinquecento
nonostante le proteste
dei puristi.
Ah però.
[colpo di coda filologico, ndr]
Nota 34: Una delle parole incluse nella lista fuori testo.
Forse dunque un possibile titolo? Vedi nota filologica,
[Nerina, ndr] non solo per i significati ma anche per la storia
dei lemmi: simili informazioni di lessicografia non si trovano
in comuni dizionari. Più avanti si cita l’illustre Devoto-Oli, ma
qui è verosimile che l’autrice abbia consultato ancora il GDLI
di Salvatore Battaglia.
A voi la gioia di avventurarvi tra le pagine di quest’opera poetica di impianto romanzesco
[come colpo di coda, che ve ne pare?, ndr].

Le carte della settimana sono: Giustizia, Papa, Matto e Innamorato.
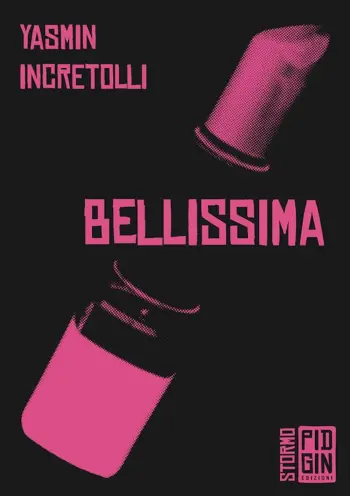
In questa storia si narra un’umanità dolente, viva e vitale, malata e indurita, crudele, che ha abbandonato la Speranza in una casa disfatta, la caduta di Icaro con le ali che luccicano al sole, prima dello schianto.

Le carte della settimana sono: Matto, Bateleur ed Eremita.

Scuola di scrittura creativa. Accompagniamo un autore dai primi passi fino alla pubblicazione, valutiamo racconti e romanzi, organizziamo laboratori per film maker e giornalisti digitali.
E ti stiamo aspettando.
I corsi sono riservati ai soci come attività istituzionale dell’Associazione.
Sede legale: Via Maurizio Bufalini 8 – 00161 Roma
Sede della scuola e aule:
+39 351 877 94 61 – genius@storygenius.it
C.F. 97996600587
Associazione Culturale Story Genius © Copyright 2024 | Designed by Appare