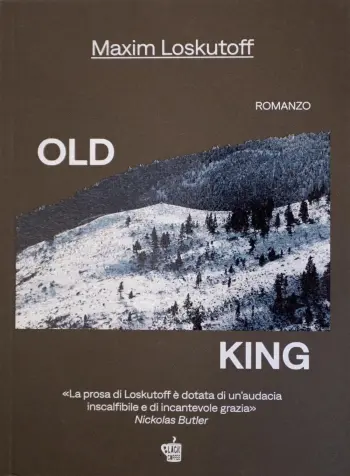Il modo più banale per svolgere un racconto è farlo cominciare con uno che si sveglia, poi raccontare la sua triste giornata, quindi farlo morire per chiudere la storia. Un’alternativa molto banale è che prima di svegliarsi lo vediamo in una situazione dolorosa oppure gioiosa o surreale, che però alla fine si rivela essere un sogno, poi si alza dal letto, vive un po’ e… muore.
Forse dipende dal fatto che questa sembra una metafora dell’esistenza umana: ci si sveglia, ci si sbatte, si schiatta. Detto così non sembra un granché ma neanche i racconti che ne vengono fuori lo sono.
Un’altra possibilità altrettanto banale è quella di far partire all’inizio il personaggio per un viaggio, ma poi alla fine dell’avventura spesso… muore.
Sembra che la maggior parte degli scrittori dilettanti non sappiano far finire una storia senza mettere termine alla vita del personaggio principale.
Però meglio pensarci due volte prima di far morire un personaggio, non è uno scherzo o comunque bisogna saperlo fare, per non essere banali o superficiali.
Insomma uccidere qualcuno (anche un personaggio) non è certo una cosa da fare a cuor leggero (o solo per chiudere un racconto), quindi nelle storie questa sorta di “soluzione finale” va realizzata solo quando serve davvero all’obbiettivo drammaturgico e psicologico che l’autore ha deciso di ottenere. Altrimenti il rischio è quello della banalità, un pericolo che si corre sempre quando si scrive ma che aumenta quando si vogliono descrivere i momenti essenziali nella vita dell’uomo. Provate a leggere i racconti e i romanzi in cui sono descritte nascite, grandi amori e morti. Ebbene, queste scene saranno noiose e scontate negli scrittori minori, mentre saranno potenti e originali nei grandi autori.
Per avere un esempio classico, procuratevi il racconto La morte di Ivan Il’ič di Lev Tolstoj (Smert’ Ivana Il’iča, 1887-1889, traduzione di Giovanni Buttafava, Garzanti 1975) e anche se avete il cuore indurito da troppi noir, non potrete non trasalire di fronte a questa frase: «Da quel momento incominciò il grido, che durò tre giorni, senza arrestarsi, così tremendo che non si poteva ascoltarlo neanche dietro due porte chiuse, senza sentirne orrore.» E se avrete la forza di andare avanti, sarete ricompensati da un finale fortissimo:
«Sì, li faccio soffrire,» pensò. «Mi fanno pena. Staranno meglio, quando sarò morto.» Voleva dirlo, ma non aveva la forza di articolare una frase. «Del resto, perché parlare? bisogna fare,» pensò. Con uno sguardo indicò alla moglie il figlio e disse:
«Portalo… via… mi fa pena… e anche tu…» Voleva aggiungere «perdonami,» ma disse «ridona»: non avendo più la forza per correggersi, agitò una mano, sapendo che chi doveva capire avrebbe capito.
E all’improvviso comprese chiaramente che ciò che lo tormentava e non voleva abbandonarlo, se ne stava andando via di colpo, tutt’insieme, da due parti, da dieci parti, da tutte le parti. Gli facevano pena: bisognava fare in modo che non soffrissero più. Liberare loro e liberare se stesso da quelle sofferenze.
«Com’è bello e com’è semplice,» pensò.
«E il dolore?» si chiese. «Dov’è andato? dove sei dolore?»
Si mise in ascolto.
«Ah si, eccolo. Non importa, resta pure lì!»
«E la morte? Dov’è?»
Cercò la sua solita paura della morte e non la trovò. Dov’era? Ma quale morte? Non c’era nessuna paura, perché non c’era neanche la morte. Invece della morte c’era la luce.
«Ah, è così!» esclamò d’un tratto a voce alta.
«Che gioia!»
Per lui tutto s’era compiuto in un attimo, e il significato di quell’attimo non cambiò più. Per i presenti la sua agonia durò ancora due ore. Qualcosa gorgogliava nel suo petto; il suo corpo esausto sussultava. Poi il gorgoglio e il rantolo si fecero sempre più radi.
«È finita» disse qualcuno su di lui.
Egli sentì quelle parole e le ripeté nel suo animo. «È finita la morte,» disse a se stesso. «Non c’è più.»
Aspirò l’aria, a metà del respiro si fermò, si distese e morì.
Oppure ascoltate e guardate il finale della Bohème di Giacomo Puccini, dove c’è l’esempio di una morte, quella di Mimì, annunciata come non mai e che pure emoziona in modo irresistibile lo spettatore, che la vive attraverso il dolore di Rodolfo. Infatti il pubblico piange, dopo che lei è morta, quando rientra il suo innamorato e si dispera. Quando muore, quasi non ce ne accorgiamo. Non è la morte di Mimì che mette fine alla storia e alla loro giovinezza, ma la disperazione di Rodolfo.
Talvolta la morte esige tempo e spazio per essere efficace. Ho sottomano Madame Bovary di Gustave Flaubert (nell’edizione tradotta da Oreste Del Buono, Garzanti 1965). Ebbene a pagina 254 Emma Bovary: «Afferrò il boccale turchino, ne tolse il tappo, poi ci ficcò dentro la mano, la tirò fuori, alla fine, piena d’una polvere bianca, cominciò a inghiottirla.» Ma bisogna aspettare pagina 263 perché la polverina faccia fino in fondo il suo effetto: «Una convulsione la rovesciò sul materasso. Tutti si avvicinarono. Non esisteva più.» Dieci pagine di tensione emotiva e di lenta agonia per una delle morti più memorabili nella storia della letteratura, conclusa con un memorabile uso della punteggiatura. Tre inquadrature quasi da cinema, separate da tre punti fermi. Uno: una convulsione la rovesciò sul materasso. Due: tutti si avvicinarono. Tre: non esisteva più.